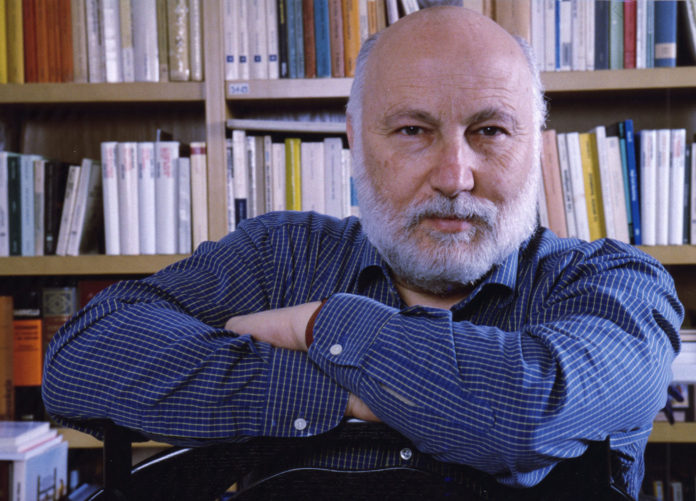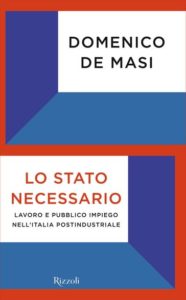«Sessanta milioni di italiani, hanno fatto una “sterzata”, trovandosi in guerra contro un nemico invisibile. Non si era mai visto nella storia umana, un esperimento corale di questa proporzione. Stili di vita, abitudini e costumi collettivi, nel breve giro di pochissimi giorni, sono stati modificati. Ricchi e poveri, giovani e vecchi, tutti sigillati in casa, in una dimensione in cui spazio e tempo hanno cambiato il loro significato. Così, la velocità, l’automobile, grandi icone della società industriale, non fanno più parte di noi, come se non ci appartenessero più; intanto stiamo imparando ad abitare il vuoto delle città e a ritrovare i legami con i gruppi primari: la famiglia, i parenti più stretti, il condominio e finalmente cominciamo a riascoltare i vecchi…».
Domenico De Masi, Professore emerito di Sociologia del lavoro presso La Sapienza Università di Roma, di rivoluzioni ne ha viste e studiate in ogni angolo del globo, ma la crisi che abbiamo di fronte è tutt’altra cosa. Scorrendo rapidamente solo alcuni dei suoi titoli più famosi Il lavoratore post industriale, L’ozio creativo, Mappa Mundi, Roma 2030, Il lavoro nel XXI secolo, si vede molto bene la capacità dello studioso di osservare, con particolare acume, le trasformazioni che da sempre attraversano i processi sociali e le organizzazioni produttive. Abbiamo chiesto, perciò, l’aiuto a chi sa porre lo “sguardo oltre” per cercare di capire dove stiamo andando.
Professore, lo aveva profetizzato Bill Gates già 2005: non ci ucciderà una bomba ma un virus. Il Covid-19 è arrivato come un vento impetuoso, spazzando via ogni cosa. Un crash test per la civiltà occidentale. Come sta reagendo il nostro Paese?
Bisogna dire che le reazioni razionali e positive hanno fortunatamente prevalso su quelle irrazionali e negative; in realtà è come se stessimo partecipando a un grande seminario che ci mette di fronte a un caso inedito e ci obbliga a ragionare e meditare.
Che cosa stiamo apprendendo da questo momento di “formazione collettiva” forzata?
Tantissime cose. Innanzi tutto, che il mondo è globalizzato e basta un nulla perché un virus propagato da un pipistrello cinese arrivi fino a casa nostra. Che non è possibile creare confini, ogni chiusura rigida è solo artificiale e psicotica, e che di conseguenza i sovranismi sono antiquati, sono vecchi retaggi che appartengono all’Ottocento, secolo dominato dagli Stati nazionali. Stiamo, inoltre, imparando che sono indispensabili le competenze, non si può fare a meno della preparazione per muoversi nella complessità del presente. Le discipline esatte non saranno infallibili, come già ci avevano detto grandi pensatori da Popper in poi, ma sono esatte quel tanto che basta per orientare i nostri comportamenti.
Il momento per un reset mentale e psicologico di massa non poteva essere più brusco. Che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi?
Abbiamo cambiato vita per decreto, perché abbiamo accettato i presupposti che hanno portato alla strategia del rigore. Inizialmente, qualcuno metteva in atto comportamenti non proprio virtuosi, credendosi immune, poi la gravità della situazione ha “convinto” anche i “super-uomini” e gli scettici. È in atto una mutazione profonda di molti atteggiamenti che fanno parte del nostro Dna. Per esempio, ci stiamo rendendo finalmente conto che le decisioni sono un fatto complesso, e che di fronte a fatti nuovi si può sbagliare. Il risultato è che una parte del Paese sta imparando a essere tollerante rispetto ad errori, che sono inevitabili quando si ha la responsabilità di decidere in condizioni di totale incertezza, come quella che stiamo vivendo in questi mesi. I segni di uno stravolgimento così profondo sono destinati a durare.
Non crede che anche il nostro rapporto con gli strumenti tecnologici stia subendo significative modificazioni?
La solitudine forzata ci fa riflettere sulla convivenza, diventano importanti quelli che i sociologi definiscono gruppi primari: la famiglia, gli amici più stretti, il condominio. Fino a ieri eravamo abituati ad avere dimestichezza solo con i gruppi secondari: colleghi di lavoro, clienti, fornitori, conoscenti in senso lato, passavamo del tempo più con le persone a cui davamo del “lei” che del “tu”. Ora, il mondo appare capovolto, ritorna prepotente la centralità del fattore umano e della convivialità, non più coltivata attraverso incontri fisici, ma attraverso informatica, Internet, di cui stiamo scoprendo ‒ come accennava lei nella domanda ‒ la preziosa utilità. Gli apocalittici sono sempre portati a condannare gli strumenti dell’innovazione, ma oggi dopo aver condannato la Rete ne siamo diventati grandi estimatori. Altro aspetto importante: stiamo riscoprendo il valore della comunicazione autentica, che deve essere il più affidabile possibile. Meglio attenersi a quello che dicono la radio e la Tv, senza soffermarsi sulle tante fake news. I media tradizionali stanno avendo una singolare rivincita sui new media, fatto impensabile fino a poco tempo fa. Ma il quadro dei rivolgimenti non è ancora completo.
A che cosa si riferisce?
All’incidenza dei giovani in questa partita, i nativi digitali hanno il vantaggio di essere addomesticati all’informatica, sanno telegiocare, telestudiare; senza troppe ambasce stanno continuando a “frequentare” gli amici e a svolgere le loro attività, ad andare virtualmente a scuola, anche se i cancelli degli istituti sono chiusi. Ma non sottovaluterei neanche la forza inaspettata degli anziani, che non dimentichiamo ci insegnano tante cose…
Non le pare che le persone più avanti negli anni sono oggettivamente le più penalizzate e svantaggiate, perché sempre più isolate, oltre che particolarmente esposte al contagio?
Che queste categorie vivono una condizione di fragilità è innegabile, per questo non dobbiamo far mancare agli anziani il nostro affetto e le nostre attenzioni. Però, va detto che sono anche più indipendenti, e sono abituati a stare in casa, a fare giochi sedentari. In virtù di una lunga esperienza di vita, stanno, inoltre, dimostrando saggezza ed equilibrio nell’affrontare una prova impegnativa. Ma, a parte tutto, c’è un’altra componente alla quale dobbiamo abituarci: abitare il vuoto delle città.
Il paesaggio lunare dei nostri centri storici, sembra venire fuori da una tela di De Chirico o da un racconto di Calvino. Uno choc che si aggiunge ad altri traumi. Quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità?
Nessuno ha la risposta in tasca, nemmeno gli esperti si sbilanciano. Una cosa è certa: mentre siamo a casa ci sentiamo protetti, siamo nel luogo che conosciamo da sempre, poi mettiamo il naso fuori dalla porta e abbiamo un panorama inedito, siamo proiettati verso l’ignoto, in un contesto che non abbiamo visto mai, almeno in questa forma. Tutto questo comporta reazioni psicologiche nuove, che non conosciamo e che per il momento possiamo solo ipotizzare.
In questo scenario, gonfio di paure e incertezze, anche la dimensione del tempo è totalmente cambiata. Niente appare più come prima. Qual è la riflessione del sociologo su questo?
Sono d’accordo con lei. Siamo passati da una vita frenetica, giocata su più fronti: la casa, il lavoro, gli amici, i colleghi, il teatro, il cinema a un’unica dimensione di vita racchiusa nelle pareti domestiche, in case che, per quanto grandi, ci sigillano e ci fanno da prigione. Nella prigione si sa, il tempo si dilata, non incidono nella nostra giornata gli spostamenti che riempiono le nostre giornate. La velocità, e l’automobile, le grandi icone della società industriale, è come se non ci appartenessero più. Per capirci: abito nella centralissima Corso Vittorio Emanuele a Roma, di solito è impossibile attraversare la strada se non sulle strisce e con la disciplina dei semafori. In questo periodo, ho potuto fare delle brevissime passeggiate sulla “linea di mezzeria”, cosa impensabile in condizioni normali, oltre che pericolosa. Ma non muta solo la concezione del tempo, insieme ad essa si modifica la percezione dello spazio. Ci sembrava che esso fosse illimitato, abituati a viaggiare dovunque con ogni mezzo, soffrendo la scarsità di un tempo fitto di impegni, di cose da fare, di appuntamenti. In questo “spazio recintato”, il tempo basta e avanza, sta adesso a noi saperlo riempire di senso e di significati.
L’Europa è apparsa frammentata e spiazzata di fronte all’emergenza. Ha chiuso le frontiere, mentre la sua classe dirigente ha solo balbettato risposte, deboli e spesso contraddittorie. Il vecchio Continente uscirà più debole o più forte da questa esperienza?
Qualche Stato europeo capirà, altri si arroccheranno su posizioni retrive. Questa vicenda ha fatto capire che serve uno Stato e un’Europa più forte. Così come lo Stato deve prevalere sulle Regioni, l’Europa nei momenti di emergenza deve prevalere sugli Stati. Abbiamo dileggiato gli scritti di Latouche e quelli che predicavano la decrescita serena. Ora è successo che quello che avremmo potuto pianificare noi, ce lo ha inflitto un pipistrello cinese.
Certamente si apre una nuova fase per il capitalismo, cosa che non era avvenuta neanche dopo l’11 settembre. Vuol dire che lo choc è più grave questa volta?
L’11 settembre in realtà non ha cambiato quasi nulla. Lo vedevamo 6.000 km lontano da noi, la preoccupazione era relativa. Anche questa epidemia in una prima fase l’abbiamo pensata come ad una cosa lontana, destinata a svilupparsi in un “altrove” indefinito. In tanti abbiamo pensato che, come un terremoto o uno tsunami, sarebbe rimasto un fatto lontano. Ma il virus si sposta e così molto in fretta ci ha raggiunto…
Nel suo ultimo scritto (Lo Stato necessario ed. Rizzoli n.d.r) afferma la necessità del ritorno dello Stato, dopo anni di liberismo esasperato. Alla luce dell’emergenza sanitaria, qual è il messaggio di fondo di questa ricerca?
L’attualità rende ancora più semplice il messaggio. Come avremmo fatto in questa situazione drammatica senza la sanità pubblica, sia per il contributo di carattere professionale e scientifico sia per quel livello di sicurezza e di competenza che gli esperti hanno trasmesso alla classe politica al fine di prevenire decisioni avventate? La necessità di uno Stato presente, anche se certo non invadente sta emergendo in ogni fase della crisi che stiamo vivendo. Prendiamo le reazioni delle Regioni che più si ritenevano immuni da ogni crollo economico, perché più organizzate e più ricche. Faccio un esempio concreto: tra la Lombardia e la Campania il Prodotto interno lordo è di tre a uno, questo ha fatto sì che la Lombardia si sentisse al di sopra di ogni rischio e di qualsiasi possibile oscillazione economica. Così le Regioni più ricche ‒ anche in virtù di un disegno costituzionale che prevede in questa materia ampia autonomia ‒ si sono fatte una loro sanità. Questo modello non funziona. L’emergenza sanitaria ha fatto capire in fretta che è molto più efficace e vantaggioso rifarsi allo Stato centrale, senza protagonismi e fughe in avanti. Non ci può essere un “Bertolaso contrapposto ad Arcuri”, tanto per intenderci, perché in queste circostanze c’è bisogno di uno Stato che decida con rapidità, coerenza e fermezza, per tutelare tutti, dalle Regioni economicamente più deboli, a quelle realtà territoriali che si ritengono più forti e perciò indipendenti e autonome.