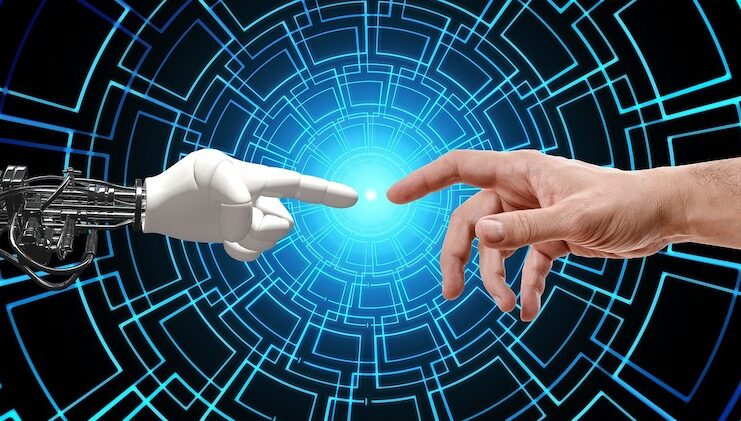Basterebbe, ancora oggi, leggere e rileggere La cultura del piagnisteo (The culture of complaint) di Robert Hughes, un testo del 1993, per avere tutte le risposte e la consapevolezza utili a contrastare la “cancel culture” e la dittatura del politicamente corretto, l’ideologia che l’ha ispirata. E invece, a distanza di ventisette anni, dobbiamo ancora fare i conti con la grettezza di un pensiero che vuole affermarsi come unico e fondamentalista, che si siede d’imperio dalla parte di una presunta ragione, per giudicare che cosa è moralmente accettabile e che cosa offende la morale comune dei diritti universali.
Ma procediamo con ordine. Cosa è la cancel culture di cui si parla con insistenza? È il boicottaggio di persone, aziende, gruppi, associazioni che hanno espresso o sostenuto opinioni discutibili: tutto ciò che non rientra nella morale comune, deve essere osteggiato, deriso, messo al bando, cancellato, rimosso. È l’ennesima manifestazione di una dittatura culturale, quella del “politically correct” che stabilisce cosa sia lecito e perbene, e quindi ammesso, e cosa non lo sia: dai comportamenti sessuali ai gusti letterari, dal modo di vestirsi al lessico da usare, da come atteggiarsi con il prossimo sino a cosa mangiare o bere per non sembrare sconvenienti o offensivi, per rappresentare il modo giusto di fare le cose e di essere.
Da ciò ne conseguirebbe – manco a dirlo – la discriminazione nei confronti di tutto ciò che non rientra in questi parametri. Ebbene, è questa la nuova creatura del politicamente corretto, la cultura della cancellazione da intendersi come la rimozione di persone, gruppi e aziende dalla produzione culturale perché colpevoli di esprimere giudizi, valori e opinioni ritenuti lesivi dei diritti delle minoranze, della parità di genere, del principio di uguaglianza.
La cancel culture, nata intorno al 2010, è quella, per intenderci, che ha dato la stura al #MeToo nel 2017 con le accuse – molte delle quali poi rivelatesi infondate – nei confronti di attori accusati di molestie sessuali e di stupri, come Kevin Spacey, cancellato dalla serie Tv House of Cards e oggi del tutto scagionato. Ed è quella che ha portato ad abbattere le statue e i busti di personaggi storici ritenuti impresentabili perché colpevoli di presunti misfatti morali.
È in questo clima e con tali premesse che si sono sviluppati, negli ultimi tempi, veri e propri processi di piazza nei quali la Rete e i social media hanno assunto il ruolo di una potentissima cassa di risonanza, con campagne di odio e liste di proscrizione ai danni dei colpevoli. È il fenomeno dell’online shaming, la messa alla gogna, sul web, dei trasgressori delle regole della morale, giudicati senza appello e senza prove da un tribunale collettivo e immateriale che non rispetta alcuna procedura e alcuna garanzia e che procede con forme varie di cancellazione.
In questo contesto non può non essere menzionata la lettera che 150 intellettuali (tra loro Martin Amis, Margaret Atwood, John Banville, Noam Chomsky, Michael Ignatieff, Garry Kasparov, J.K Rowling, Salman Rushdie, Michael Walzer, Fareed Zakaria) hanno pubblicato lo scorso 8 luglio su Harper’s Magazine contro la cancel culture e l’online shaming. Un vero e proprio manifesto in favore della libertà di parola e di espressione. «(…)Questa atmosfera soffocante finirà per danneggiare le battaglie più importanti della nostra epoca. La restrizione della possibilità di esprimersi, sia che provenga da un governo repressivo o da una società intollerante, va sempre a colpire chi ha meno potere e rende tutti meno capaci di partecipazione democratica. Per sconfiggere le idee sbagliate bisogna smascherarle, servono il ragionamento e la persuasione. Non cercare di silenziarle o aspettare che spariscano. Noi rifiutiamo ogni falsa scelta tra giustizia e libertà: nessuna delle due può esistere senza l’altra. In quanto scrittori, abbiamo bisogno di una cultura che ci lasci spazio per sperimentare, per assumere rischi e anche per sbagliare».
Questo il terreno sociale e culturale sul quale si è dispiegata questa forma di intolleranza, con processi di piazza che, per la rabbia e l’odio di cui sono intrisi, portano al rogo dei libri, ad abbattere le statue di personaggi ritenuti colpevoli di aver violato valori e princìpi condivisi, a indicare al pubblico ludibrio gli eretici. E si può venire “canceled” per i motivi più diversi, estemporanei e insondabili: per avere detto o fatto qualcosa di discriminatorio, con elementi più o meno presenti di misoginia, razzismo, omofobia, ravvisati in dichiarazioni, interviste, video, apparizioni televisive e subito crocifissi sui social media, con hashtag deliranti su Twitter e Facebook ed esposti alla vergogna planetaria a velocità supersonica, con la conseguenza di vite distrutte, carriere spezzate, reputazioni falciate, affetti e relazioni persi per sempre e senza alcuna ipotesi di risarcimento materiale o morale.
La cancel culture è quella che ha fatto da sfondo alle manifestazioni violente negli States dopo la morte di George Floyd, l’uomo di colore ucciso da un poliziotto a Minneapolis nel giugno di quest’anno, a cui sono seguiti saccheggi, sommosse di piazza, e distruzione di statue, targhe e lapidi che evocavano una cultura razzista, coloniale, reazionaria, degna di essere rimossa e cancellata per sempre dalla memoria condivisa. Forme di violenza e di intolleranza che hanno rievocato l’immagine dei libri sgraditi al Fuhrer, ammucchiati nella Openplatz di Berlino dai nazisti il 10 maggio del 1933 e dati alle fiamme. E se, a Londra, è stato necessario proteggere la statua di Winston Churchill con una struttura di legno dagli assalti di chi lo ritiene colpevole dei reati di razzismo e di colonialismo, vuol dire che il fenomeno non può essere sottovalutato. Analisti e studiosi hanno visto in queste manifestazioni segnali diversi, ma tra di essi connessi, quali la decadenza della democrazia, della tolleranza e del dialogo, il riacutizzarsi della rabbia sociale, la rinascita di razzismi e di culture che si ritengono superiori e che pertanto possono giudicare chi, nella storia e nella contemporaneità, siede dalla parte della giustizia e della verità, con tutte le nefandezze che possono derivarne e che è facile immaginare.