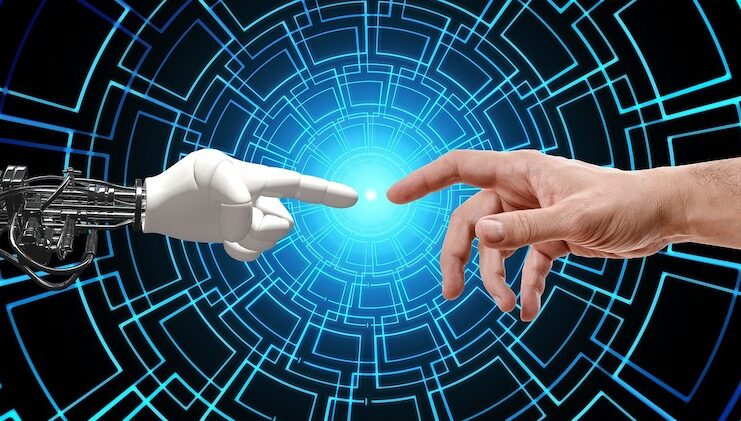Alle congratulazioni, per una volta non formali, che da ogni parte piovevano su Palazzo Chigi dopo l’amplissima ratifica parlamentare del suo incarico, il nuovo premier Mario Draghi ha voluto rispondere subito ricordando quali sono i due capisaldi della politica estera italiana: il legame con l’Unione europea e la fedeltà al rapporto transatlantico.
L’impronta di Draghi alla politica estera non è banale
Qualcuno potrebbe osservare che in queste due scelte tradizionali non c’era motivo di particolare interesse, che Draghi aveva semplicemente sposato la continuità. Ma si tratterebbe di un errore. Dopo la presidenza Trump, che aveva gravemente danneggiato e indebolito l’alleanza tra l’Europa e gli Stati Uniti, dalle capitali della Ue, a cominciare dalla nostra, doveva arrivare al nuovo e ben più amichevole presidente Joe Biden un segnale forte sull’indissolubilità del legame storico tra le due rive dell’Atlantico e sulla persistenza dei valori democratici e libertari comuni. Segnale che Draghi ha lanciato, ben sapendo che nella sua vasta (troppo?) maggioranza parlamentare sedevano anche le saltuarie tentazioni filo-cinesi dei 5Stelle e i passati amori filo-russi di Matteo Salvini. Quanto all’Unione europea, qui sì, Mario Draghi sembra essere scivolato nella banalità. Sarebbe forse concepibile un governo da lui guidato che fosse tiepido verso quella Ue che proprio lui dalla BCE ha contribuito a tenere a galla quando incombeva il pericolo di naufragio? Eppure, Draghi non è stato scontato nemmeno in questo. Nella suddetta amplissima maggioranza di sostegno, non c’è forse chi ha troppi dubbi sull’Euro, e chi è assai più vicino all’ungherese Orbàn che alla tedesca Merkel?
Ripartire da una prospettiva europea
A modo suo, Draghi sta resuscitando nell’Italia prolissa e retorica una vecchia e buona abitudine della cremlinologia d’un tempo: attenti a ogni parola, perché ogni parola pesa. Ma è vero, come egli stesso ha detto nel suo discorso al Senato, che a stabilire la validità di questo approccio saranno i fatti, i concreti risultati. E se parliamo di fatti, i problemi aperti sono ancora piuttosto consistenti. Partiamo da una prospettiva europea, che è poi quella giusta per la politica estera italiana. C’è da esultare per le prime mosse dell’alleato Joe Biden, la volontà di tornare al multilateralismo, il ritorno alla comune difesa dell’ambiente, il prolungamento in extremis del trattato New Start tra Usa e Russia (chissà se un giorno potrà rinascere anche l’INF, che vietava i missili a gittata intermedia in Europa prima che la volontà di Trump e limitate violazioni russe lo affondassero), l’annuncio di voler riattivare gli accordi anti-nucleari del 2015 con l’Iran, anch’essi stracciati da Trump. Si direbbe che Biden stia smontando, pezzo per pezzo, le scelte di Trump come Trump aveva fatto con quelle di Obama, e questa è una buona notizia. Ma sul tema dei rapporti con la Cina, che gli Usa continuano a considerare un banco di prova dell’alleanza strategica con gli europei, basterà l’atteggiamento ondivago dell’Europa che ha i suoi interessi non sempre coincidenti con quelli statunitensi? E sulla ripresa dei negoziati con Teheran, gli europei non sono forse molto più disponibili degli americani, condizionati dal loro fronte interno? E l’eventuale ritiro parziale o totale degli Usa dall’Afghanistan, che coinvolge anche contingenti europei (circa ottocento militari italiani), potrà davvero avvenire in modo ordinato dopo tanta attesa e con i Talebani tanto vicini alla vittoria finale? L’attualità internazionale, in sintesi, è ancora ricca di possibili difficoltà tra le due sponde dell’Atlantico, anche se la Nato è bravissima nel diluire ogni contrasto che indebolisca l’Alleanza e anche se il tono del dialogo tra alleati è decisamente cambiato per il meglio dai tempi di Trump.
La voce dell’Italia sulla scena internazionale
Ma detto in sintesi, della cornice internazionale, occorre ora dire qualcosa che attiene alla politica estera italiana, agli interessi nazionali dell’Italia che continuano ad esistere inquadrati nelle scelte di fondo della Ue e dell’Alleanza Atlantica. E qui il discorso diventa a dir poco preoccupante, per Draghi e per quella “voce” che l’Italia meriterebbe di avere sulla scena internazionale e che purtroppo non ha. Su questa atavica debolezza della politica estera italiana sono stati versati fiumi di inchiostro che vanno dalla “politica della delega” scelta nel dopoguerra perché meno impegnativa oltre che bene accetta dalla DC e anche dal PCI, ad una cronica mancanza di iniziativa e un eccesso di prudenza, al fatto che la politica estera classica sia stata troppo spesso sostituita (bene, diciamo noi) dalle missioni di pace militari, così chiamate anche quando si trattava di sparare. Non è questa la sede per un simile dibattito, ma un caso recente può essere citato ad esempio di una politica estera certamente deficitaria nei processi decisionali riservati e persino nella sua rappresentazione pubblica: il caso della Libia, dove tra l’altro, proprio oggi a Benghazi, giurerà il nuovo governo di unità del Premier Dbeibah, il primo esecutivo unitario da 7 anni.
Leggi anche
Senza dover tornare agli anni non lontani nei quali di Libia si discuteva soltanto in termini di rivalità italo-francese, e si pensava che fossero utili maxi-conferenze che mai a qualche progresso sul terreno hanno portato (quella italiana fu a Palermo, con gran dispendio di mezzi e di azioni diplomatiche a corto raggio), basterà constatare quali sono i poteri che si fanno valere in Libia: Russia, Emirati (per conto dei sauditi) ed Egitto in Cirenaica e in parte nel Fezzan; Turchia e Qatar in Tripolitania, dove, fino allo scorso venerdì, all’ombra di un governo debole ma legittimo, Ankara ha messo sotto tutela numerosi e importanti interessi nazionali italiani.
Che cosa è accaduto in Libia?
In estrema sintesi: che il governo di Tripoli, anche ma non soltanto per fronteggiare l’offensiva del generale Haftar, si è rivolto ai paesi amici reclamando urgenti forniture di armamenti. Consultata come altri, l’Italia ha detto no: non si trattava più di motoscafi veloci per aiutare la Guardia costiera libica a frenare le ondate migratorie, ma di equipaggiamenti da guerra. Era forse possibile che l’Italia dicesse di sì, magari parzialmente? Conoscendo il nostro “fronte interno” non lo crediamo, ogni concessione a Fayez al-Sarraj avrebbe provocato un putiferio. La Turchia, invece, ha detto “ci penso io” e ha mandato forze in Tripolitania mentre i russi facevano la stessa cosa sul fronte opposto. E noi, come i francesi ed altri, dobbiamo oggi constatare che in Libia comandano turchi e russi, almeno fino a quando il processo appena iniziato per la formazione di un governo libico unitario, non avrà raggiunto un auspicabile sbocco positivo. L’errore della politica estera italiana in Libia è in parte dovuto alle nostre farraginosità decisionali interne, come abbiamo detto. Ma la “perdita” della Tripolitania rivela sbagli più antichi, e anche più gravi: il nostro appiattimento aprioristico sull’Onu, la costante mancanza di iniziative efficaci, il rilievo quasi caricaturale dato, a livello diplomatico come sui media, alle investiture verbali americane in occasione di visite ufficiali, da parte di Obama e poi di Trump. Senza alcun seguito, però, alle troppo timide richieste italiane di impegnare maggiormente gli Usa in Libia e dintorni.
La Libia ci indica un vuoto esemplare e troppo frequente della politica estera italiana. Mario Draghi è chiamato a tentare di riempirlo, e il suo compito non sarà facile.
*Franco Venturini, giornalista, è membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio permanente sui Temi Internazionali dell’Eurispes.