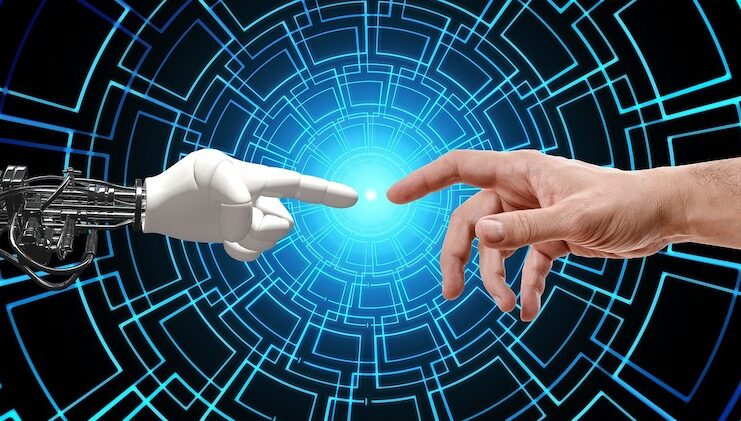Città “sensibili” e non solo “smart”, tecnologicamente intelligenti ma a misura di cittadino. È la sfida di chi crede in una innovazione “etica” che metta al centro l’uomo e consenta di “sostituire un lavoro meno piacevole con altro più creativo e a maggior valore aggiunto”.
Carlo Ratti, docente presso il Mit di Boston, dove dirige il Senseable City Laboratory, special advisor presso la Commissione Europea su Digitale e Smart Cities, architetto e ingegnere, è tra i protagonisti del dibattito che, a livello mondiale, riguarda l’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, ed innovatore lo è fino al midollo. Molti suoi lavori sono stati esposti da istituzioni culturali tra cui la Biennale di Venezia, il Design Museum di Barcellona, lo Science Museum di Londra e il MoMA di New York. Nel saggio la “Città di domani”, scritto con Matthew Claudel, ricercatore del Senseable City Lab, lo studioso si spinge un “passo oltre” l’incrocio tra tecnologia, progettazione e visione del futuro.
Professor Ratti, i centri urbani, oggi, sono tecnologizzati, ma anche fragili, come ha dimostrato la tragedia di Genova. La città di domani che profilo assumerà?
Sono convinto che la “forma urbis”, il profilo della città, non sarà sottoposto a stravolgimenti eccessivi. I “Fundamentals” descritti da Rem Koolhaas alla Biennale di Venezia del 2014 sono destinati a restare tali, se non altro in rapporto a precisi limiti fisici e funzionali che rimangono insormontabili. A cambiare, insomma, non sarà tanto l’aspetto, quanto le modalità di relazione all’interno dello spazio: come ci spostiamo, ci incontriamo, discutiamo, lavoriamo, o facciamo acquisti.
Per Senseable city dobbiamo intendere uno stadio più avanzato, rispetto a Smart city, definizione che comincia ad essere criticata da molti studiosi?
Non mi piace il nome Smart City per le sue assonanze tecnocratiche, a cui non mi sento vicino. Senseable city, invece, è una città capace di sentire, ma anche sensibile, con la sua vocazione a integrare aspetti umanistici nella sua analisi digitale. Quando abbiamo aperto il laboratorio presso il Mit, nel 2004, erano ancora in pochi a parlare di Smart City: non esisteva l’iPhone, e a malapena si sapeva cosa fosse Facebook. Non saprei, quindi, se si tratta di un superamento: però mi fa piacere che gli aspetti per i quali si criticano le città intelligenti, oggi, sono quelli che avevamo già individuato quindici anni fa.
Intanto le città continuano ad essere dei “magneti umani”. La popolazione urbana cresce, infatti, al ritmo di 250mila abitanti al giorno. Quali sono le conseguenze di tutto questo?
La crescita demografica urbana va in scena da tempo, attenzione però, perché si tratta di una cifra deformata da quello che sta succedendo nei Paesi emergenti: in Europa e in Nord America la maggior parte delle città non sta crescendo. Inoltre, occorre tener presente che le nuove migrazioni urbane non si concentrano solo nelle megalopoli.
In contesti abitativi dominati da Reti, sensori, IoT, quali scenari si aprono sul fronte della privacy e della possibile sottrazione di dati sensibili?
Di fatto abbiamo già perso la nostra privacy, anche se non ce ne siamo accorti. L’osservazione tocca tutti gli aspetti delle nostre vite, non solo le città. Dobbiamo ora evitare che la situazione degeneri: penso in particolare alla enorme asimmetria che esiste – quando si parla di accesso e possesso dei dati – tra pochi giganti informatici e tutti gli altri attori sociali. Per fortuna negli ultimi anni, soprattutto in Europa, è emersa una maggiore sensibilità rispetto a questi temi. Pensiamo al recente provvedimento GDPR-General Data Protection Regulation, che potrebbe cambiare le regole del gioco mondiali.
Pensa che sia possibile mettere al centro dell’innovazione tecnologica il cittadino che, come si sta vedendo nei più diversi contesti, appare sempre più escluso dai processi di decisione politica?
Credo che sia fondamentale: la “smart city” non si costruisce solo dall’alto. Intendiamoci, il pubblico ha di certo un suo ruolo da giocare. Ad esempio, il sostegno alla ricerca accademica, o l’intervento in àmbiti che possono apparire meno “attraenti” al capitale di rischio – come lo smaltimento dei rifiuti o la gestione delle acque. In generale, però, credo che i governi dovrebbero soprattutto impiegare i loro fondi per promuovere una cittadinanza attiva e per sviluppare un ecosistema di innovazione organica rivolto alla città, simile a quello che sta crescendo naturalmente nella Silicon Valley. Si tratta, come si vede, più di un approccio dal basso, che di schemi dall’alto verso il basso.
Le élites globali, possiedono i requisiti di preparazione, sensibilità etica e professionale necessari a indirizzare il prepotente sviluppo scientifico e tecnologico verso scopi coerenti con il progresso dell’uomo?
Quando parlo di ‘Transizione’ intendo capacità di saper gestire gli sconvolgimenti tecnologici odierni senza esserne travolti. Per aiutare chi ha perso un lavoro oggi a trovarne un altro domani – e per educare le nuove generazioni alle professioni del futuro. ‘Ridistribuzione’ vuol dire invece chiedersi a chi andranno i vantaggi di questo nuovo mondo. A chi ha investito capitali? O a chi è rimasto disoccupato?
Provi a rispondere lei a questi interrogativi…
Un’idea sarebbe quella di far pagare le tasse ai robot o alle nuove intelligenze artificiali. Vuol dire semplicemente tassare il capitale e trasferire reddito a chi magari ha perso il proprio posto di lavoro. Una proposta sfortunatamente bocciata dal Parlamento Europeo qualche mese fa, ma che ha trovato un sostenitore inatteso in Bill Gates. Se sapremo gestire transizione e redistribuzione, il futuro potrebbe offrirci molte opportunità. Come scriveva il grande storico americano Lewis Mumford nel secolo scorso, «il beneficio maggiore della meccanizzazione non è l’eliminazione del lavoro», bensì la sostituzione di un lavoro meno piacevole con altro più creativo e a maggior valore aggiunto.
Credevamo, sulla scorta dell’insegnamento di antropologi come Marc Augé, che l’unica realtà era quella dei “non-luoghi”. Lei ci ricorda che i bit non hanno cancellato la distanza e hanno ridato significato ai luoghi. Come si spiega questo cambio di rotta?
È vero, negli anni Novanta si credeva anche che Internet avrebbe cancellato lo spazio fisico. Non è stato affatto così. Il diritto alla città, così come proposto da Lefebvre, è una chiara ispirazione, ma sarebbe semplicistico negare che come progettisti agiamo in un contesto socio-economico del tutto diverso e molto più complesso rispetto ad allora.