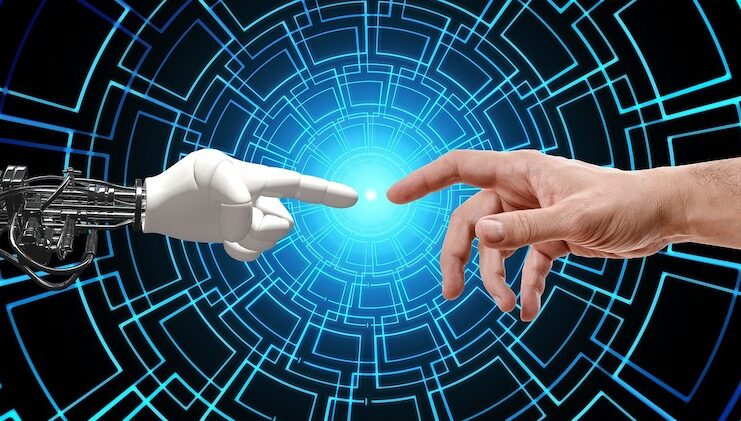La domanda che appare nella nebbia dei pensieri suscitati dai media è sempre la stessa: qui prodest, a chi giova?
Guardiamoci intorno, è tutto un fiorire d’insoddisfazioni.
Ultima è la polemica sul Sud, che per alcuni è abbandonato, per altri cancellato dal dibattito politico, mentre all’opposto diventa “piagnone” e autoassolutorio.
Nel mezzo della palude i cittadini, i fruitori del territorio: abitanti, turisti o pendolari che siano.
E ancora, Roma: città violata nella sua intima grandezza, che appare stanca e sporca, senza un’idea guida, un progetto capace di risvegliare le coscienze, indirizzare risorse e coinvolgere quelli che potrebbero o vorrebbero; combattuta tra detrattori reciproci, che sembrano non aver mai saputo cosa realmente fare se non quello che hanno fatto male.
Anche qui, nel mezzo della palude i romani, e i milioni di visitatori, portatori di reputation virale in tutto il mondo.
Ma, sono solo due esempi.
Continuando a leggere e ascoltare, troviamo i giovani, i bambini, gli anziani. E la famiglia, o chi una famiglia la vorrebbe. E poi gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani, i consumatori, i disoccupati, i lavoratori, i migranti, gli emigranti. Recentemente, anche i sacerdoti.
Ne dimentichiamo la maggior parte, perché tantissime sono le categorie della vita e le sue declinazioni, mentre, continuando a leggere e ascoltare, i pensieri si fanno cupi, l’interesse decade, l’egoismo, la depressione e lo stress aumentano.
E allora? Qui prodest?
Se i cittadini siamo noi, se noi siamo i fruitori del nostro mondo, perché non riusciamo a generare che un mondo ostile, ostile per tutti?
È colpa di chi ci guida? È colpa nostra?
Ci dicono che la politica sia l’arte della mediazione. Ma la mediazione dove si trova? Tra gli interessi diffusi o tra gli interessi di pochi?
Ci diranno che questi sono discorsi retorici, che si sa a chi giova e di chi è la colpa, che le cose della vita sono come sono, mentre ci spiegano sottili strategie e tattiche di questo o quel gruppo di interesse, scomodando economisti, banchieri e magistrati per una narrazione nichilista della nostra vita.
Ma la trappola è proprio questa, derubricare le grandi domande e le pulsioni positive che tutti abbiamo dentro a piccole questioni esistenziali al di fuori del tempo, e, facendo leva sull’egoismo, perpetuare la sconfitta prima ancora della battaglia.
Un gioco al ribasso che ci abbandona tutti su un piano inclinato discendente, dove il tempo che passa diventa la costante inesorabile del declino, tra persone e comportamenti sempre uguali a loro stessi. Dove sembra che nessuno abbia idee, ideali, figli, e responsabilità da consegnare al futuro.
E siamo tutti un po’ K., l’agrimensore de Il Castello di Kafka, chiamato a lavorare per errore, sopportato, intralciato, respinto, che vive una vita che è sua, ma sulla quale ha ben pochi diritti, pur essendo circondato da regole e tribunali.
Avviluppato in una nebbia senza fine, tra strade che ritornano al punto di partenza, a fare una vita che non dovrebbe, ma dove, nonostante tutto, ama, cerca, si ingegna e spera. Infinitamente, come senza fine è il romanzo, rimasto incompiuto e forse anche per questo ancora più capolavoro.