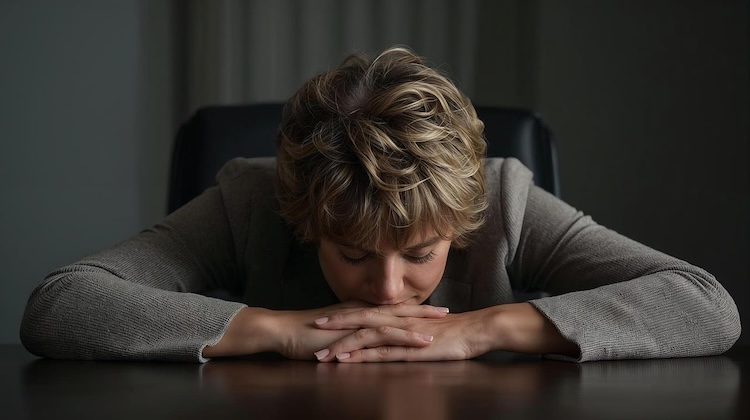Il tempo è denaro: Franklin lo scrive nel 1748. Due secoli dopo, Jäckel e Wollscheid ne fanno una griglia che incrocia tempo e reddito per mappare il benessere. Emergono quattro territori: chi ha entrambe le risorse (pensionati benestanti, rentier), chi ha denaro ma non tempo (professionisti oberati), chi ha tempo ma non denaro (disoccupati, studenti senza sostegno), e il quarto quadrante, dove mancano entrambe. Qui vivono lavoratori precari con turni imprevedibili, madri sole a basso reddito, donne che sommano lavori mal pagati e carichi di cura non retribuiti. Questo è il territorio della doppia povertà. Lo abitano soprattutto donne, soprattutto madri. La doppia povertà non è la semplice somma di due privazioni separate: le due scarsità si amplificano a vicenda. La povertà economica è misurabile: reddito insufficiente, impossibilità di accedere a beni essenziali. La povertà di tempo è più sfuggente: non significa “avere poco tempo libero”, ma sperimentare una scarsità cronica che impedisce di soddisfare bisogni fondamentali: cura di sé, riposo, partecipazione sociale, investimento nel proprio futuro. Baker (2010) lo documenta: non è una scelta volontaria ma il risultato di vincoli strutturali. Quando le due scarsità si intersecano, emerge quella che Amartya Sen chiamerebbe deprivazione di capacità fondamentali: mancano le risorse materiali e il tempo per convertirle in benessere reale.
Il circolo vizioso: da una povertà all’altra
I meccanismi di amplificazione operano in entrambe le direzioni. Dal denaro al tempo: le donne a basso reddito compensano la mancanza di soldi con più lavoro non retribuito, svolgendo in prima persona tutto il carico di cura familiare e domestico. Le famiglie povere vivono lontano dal lavoro e dai servizi: ore al giorno in spostamenti. La povertà economica si “converte” in povertà di tempo. Dal tempo al denaro: la scarsità di tempo impedisce di investire nel proprio capitale umano. Formazione, aggiornamento, certificazioni richiedono tempo che non c’è. Senza investimento in competenze, le donne restano confinate in lavori a bassa qualificazione e retribuzione. La scarsità limita anche la qualità della ricerca del lavoro: le donne sovraccariche accettano il primo lavoro disponibile, spesso precario e mal pagato. Opera anche lo stigma sociale verso chi appare sempre in ritardo, stressata, disorganizzata.
La maternità rappresenta per molte donne il momento critico di ingresso nella doppia povertà
La maternità rappresenta per molte donne il momento critico di ingresso nella doppia povertà. La nascita di un figlio innesca la child penalty: penalizzazione sistematica e duratura di reddito e carriera delle madri, senza equivalenti per i padri. I dati sono consistenti: in Canada riduzione del 49% del reddito materno nell’anno della nascita, che persiste al 34,3% anche dieci anni dopo (Connolly, Fontaine e Haeck, 2023). In Russia riduzioni del 30-40% nei primi cinque anni (Lebedinski, Perugini e Vladisavljević, 2022). In Spagna riduzione del 28% dopo cinque anni (de Quinto, Hospido e Sanz, 2021). In Italia, vendiamo un tasso di occupazione delle madri del 62,3%, contro il 91,5% dei padri; nel 2023, il 74,7% delle dimissioni femminili aveva motivazioni legate alla conciliazione lavoro-cura (Save the Children, 2025). Non sono aggiustamenti temporanei ma perdite economiche massive che ridisegnano le traiettorie di vita. La maternità spinge molte donne dal secondo quadrante (povere di tempo ma ricche di denaro) al quarto (povere di entrambe). Una volta entrate nella doppia povertà, molte donne vi rimangono intrappolate. Artmann, Oosterbeek e van der Klaauw (2022) documentano come le coppie si specializzino progressivamente: le madri assumono quote crescenti di lavoro domestico e cura, i padri si concentrano sul lavoro retribuito. Non è il risultato di preferenze innate, ma una risposta razionale a vincoli economici: dato che le donne guadagnano meno, ha “senso economico” che siano loro a ridurre l’orario. Il problema è che questa specializzazione diventa difficile da invertire. Barigozzi, Cremer e Thibault (2024) identificano tre meccanismi autoalimentanti: perdita di capitale umano (riducendo l’orario, le madri perdono esperienza e competenze), segnali di produttività (i datori interpretano riduzioni d’orario come minore commitment professionale), segregazione verso la flessibilità (le madri si concentrano in lavori flessibili ma di bassa qualità: commercio, pulizie, lavoro domestico).
La povertà invisibile: quando il cervello collassa
Cosa preparare per cena considerando preferenze, allergie, ingredienti disponibili, tempo necessario. Ricordare che il bambino ha bisogno di scarpe nuove. Anticipare che tra due settimane c’è la recita scolastica. Verificare mentalmente se ci sono abbastanza pannolini. Pensare che bisogna prenotare il pediatra. Tenere traccia di chi ha mangiato cosa e quando. Coordinare gli orari di tutti. Questo flusso incessante di micro-decisioni e anticipazioni non è visibile, non è retribuito, non è riconosciuto. Daminger (2019) lo chiama carico mentale: il lavoro cognitivo domestico scomposto in quattro componenti (anticipare bisogni futuri, identificare soluzioni possibili, decidere tra alternative, monitorare le decisioni). Le donne gestiscono una quota sproporzionata soprattutto delle prime due: il lavoro di anticipazione e pianificazione. Aviv et al. (2024) quantificano: le madri gestiscono in media il 73% del carico cognitivo domestico, contro il 64% del lavoro fisico. Attività cognitive completamente invisibili. Questo carico occupa permanentemente risorse cognitive. Anche quando una donna ha teoricamente “tempo libero”, il suo cervello è impegnato in preoccupazioni, pianificazioni, monitoraggio mentale. Non è vero riposo, ma tempo apparentemente libero e cognitivamente occupato. E qui emerge il dato più inquietante: Mani et al. (2013) hanno dimostrato che indurre preoccupazioni finanziarie produce una riduzione delle performance cognitive equivalente a una perdita di 13 punti di QI o all’effetto di una notte insonne. Per le donne in doppia povertà, questa occupazione è permanente: preoccupazione per bollette, organizzazione cura figli, arrivare a fine mese.
Le madri gestiscono in media il 73% del carico cognitivo domestico, contro il 64% del lavoro fisico
Non è un problema caratteriale ma neurobiologico. La scarsità produce effetti profondi sui processi mentali. Mullainathan e Shafir (2013) documentano il “tunneling”: quando le risorse scarseggiano, l’attenzione si focalizza ossessivamente sulla gestione immediata, a scapito del lungo periodo. Una madre in doppia povertà che deve decidere se accettare un turno extra mal pagato per pagare l’affitto, difficilmente può dedicare risorse cognitive a valutare un corso di formazione che migliorerebbe le prospettive tra due anni. Ludwig et al. (2019) e Cassidy (2018) documentano che persone a basso reddito tendono a scontare più fortemente il futuro: non “miopia” naturale, ma struttura di incentivi che rende razionale dare priorità al presente. Esiste poi un ultimo anello del circolo vizioso: quello relazionale. I “weak ties” – legami deboli, come conoscenti ed ex colleghi – sono cruciali per accesso a informazioni e opportunità lavorative. Crowell (2004) documenta che le madri tendono ad avere reti più dense ma meno estese: molti legami forti, pochi legami deboli con conoscenti professionali. Il problema: coltivare weak ties richiede tempo che le donne sovraccariche non possiedono. Beaman e Magruder (2012) dimostrano che le reti sociali maschili rendono strutturalmente più difficile per le donne ottenere opportunità lavorative. La scarsità di tempo limita i weak ties, la mancanza di weak ties limita le opportunità migliori, la permanenza in lavori mal pagati perpetua la scarsità.
La doppia povertà non è un fallimento individuale ma un’architettura sociale
La doppia povertà non è un fallimento individuale ma un’architettura sociale che trasferisce sistematicamente i costi della riproduzione sociale dalle istituzioni agli individui, dagli individui alle famiglie, dalle famiglie alle donne, dalle donne con risorse a quelle senza. La “scelta” di una madre di lasciare il lavoro o ridurre l’orario non è una preferenza rivelata, ma un adattamento razionale a vincoli strutturali: quando i servizi di cura costano quanto si guadagna, quando le reti professionali si costruiscono in orari incompatibili con la scuola, quando il capitale umano si accumula attraverso disponibilità illimitata, la specializzazione domestica diventa inevitabile. La ricerca sulla scarsità cognitiva aggiunge un elemento inquietante: la doppia povertà modifica i processi decisionali interni. Una madre in doppia povertà sceglie in condizioni in cui le sue capacità cognitive sono strutturalmente compromesse dalla necessità di gestire urgenze multiple. È come chiedere a qualcuno di giocare a scacchi mentre risolve equazioni differenziali: non è questione di intelligenza, ma di bandwidth disponibile. Questo sistema non è naturale ma costruito: risultato di scelte collettive su come organizzare lavoro, cura e distribuzione del tempo. Spezzare il circolo richiede interventi strutturali, non appelli alla resilienza individuale. I servizi di cura accessibili, la redistribuzione del lavoro domestico, la riorganizzazione dei tempi lavorativi non sono concessioni ma prerequisiti.
*Andrea Laudadio è a capo della Formazione e Sviluppo di TIM e dirige la TIM Academy.
Fonti
Artmann, E., Oosterbeek, H., & van der Klaauw, B. (2022). Do couples decide jointly? Experimental evidence on household decisions. Journal of Economic Behavior & Organization, 204, 372-387.
Aviv, E., Waizman, Y., Kim, E., Liu, J., Rodsky, E., & Saxbe, D. (2024). Cognitive household labor: gender disparities and consequences for maternal mental health and wellbeing. Archives of Women’s Mental Health, 28(1), 5-14.
Baker, M. (2010). Choices or constraints? Family responsibilities, gender and academic career. Journal of Comparative Family Studies, 41(1), 1-18.
Barigozzi, F., Cremer, H., & Thibault, E. (2024). The motherhood wage and income traps. Journal of Population Economics, 37(4), 1-26.
Beaman, L., & Magruder, J. (2012). Who gets the job referral? Evidence from a social networks experiment. American Economic Review, 102(7), 3574-3593.
Cassidy, R. (2018). Are the poor so present-biased? Oxford Research Archive.
Connolly, M., Fontaine, I., & Haeck, C. (2023). Child penalties in Canada. Canadian Journal of Economics, 56(2), 507-540.
Crowell, L. F. (2004). Weak ties: a mechanism for helping women expand their social networks and increase their capital. Women’s Studies International Forum, 27(2), 217-231.
Daminger, A. (2019). The cognitive dimension of household labor. American Sociological Review, 84(4), 609-633.
de Quinto, A., Hospido, L., & Sanz, C. (2021). The child penalty in Spain. SERIEs – Journal of the Spanish Economic Association, 12(4), 585-606.
Jäckel, M., & Wollscheid, C. (2007). Time is money and money needs time? A secondary analysis of time-budget data in Germany. Journal of Leisure Research, 39(1), 86-108.
Lebedinski, L., Perugini, C., & Vladisavljević, M. (2022). The motherhood wage penalty in the Russian labour market. Applied Economics, 54(57), 6619-6639.
Ludwig, R. M., Flournoy, J. C., & Berkman, E. T. (2019). Inequality in personality and temporal discounting across socioeconomic status? Assessing the evidence. Journal of Research in Personality, 81, 79-87.
Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. Science, 341(6149), 976-980.
Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. New York: Times Books.
Save the Children Italia (2025). Le Equilibriste: La maternità in Italia nel 2025. Roma: Save the Children Italia.