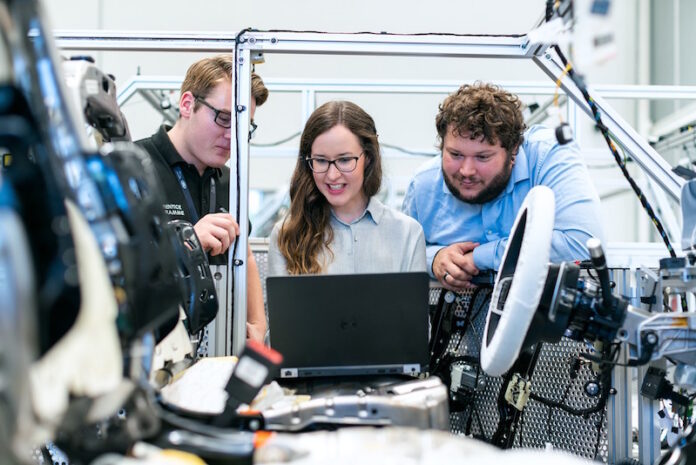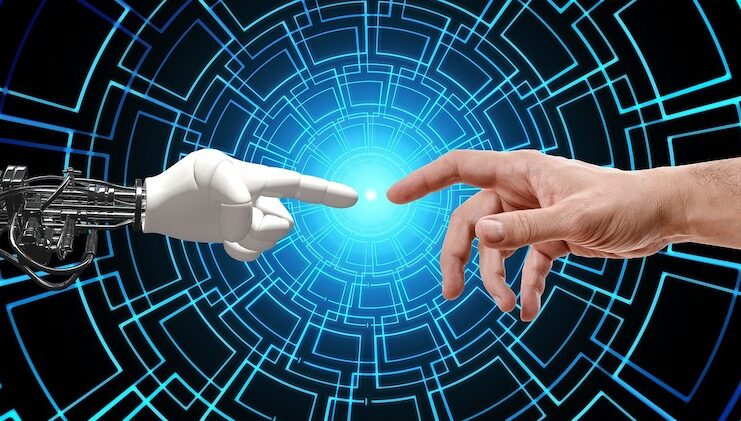Giovanni Mari, già professore ordinario di Storia della Filosofia dell’Università di Firenze, Presidente della Firenze University Press e della rivista Iride, ha dato alle stampe un interessante scritto (La libertà nel lavoro, ed. Il Mulino) in cui volge lo sguardo verso la nuova dimensione della Smart Factory. Con la capacità speculativa del filosofo e la lente interpretativa del semiologo l’autore entra nell’“anima” tecnologica di questa nuova realtà organizzativa che va inserita nella cornice della quarta rivoluzione digitale, quale «luogo ideale utile per capire lo svolgimento e la natura del nuovo lavoro», che viene descritto come «atto linguistico performativo». Nel nuovo modello di impresa, secondo l’analisi dello studioso che ci pone di fronte a un salto logico e culturale profondo rispetto alla concezione del lavoro e della fabbrica che la modernità aveva elaborato, si producono «beni comunicando, come quando il dipendente comunica alla stampante 3D il modello dell’oggetto fisico, che poi la macchina fabbrica in base alla sola comunicazione del modello digitale». Manager e imprenditori devono prepararsi ad affrontare dunque scenari inediti e a maneggiare linguaggi che ancora non conoscono e che ci porteranno verso orizzonti per molti aspetti inediti.
Professore, nel suo saggio punta l’attenzione sulla Smart Factory. Per quale ragione uno storico della filosofia guarda con interesse a questa specifica forma organizzativa dell’impresa, fortemente connotata da un’anima tecnologica?
Il libro si propone di mettere a fuoco la “natura” del lavoro che fuoriesce dalle trasformazioni in corso, soprattutto informatiche, digitali e organizzative. Una “natura” trascurata per l’attenzione rivolta soprattutto ai problemi della disoccupazione tecnologica e alle questioni economiche. Le trasformazioni citate mettono in crisi l’idea che abbiamo sempre avuta del lavoro, un’idea legata in qualche modo alla manualità, alla fatica e alla subalternità delle attività svolte; una crisi che prima l’automazione e ora la digitalizzazione hanno reso inservibile, lasciandoci senza un’idea precisa di lavoro. La Smart Factory, intesa come il luogo in cui sono concentrate le tecnologie e le forme organizzative della quarta rivoluzione digitale, è il luogo ideale per capire lo svolgimento e la “natura” del nuovo lavoro che ho cercato di descrivere come “atto linguistico performativo”.
«Nel lavoro vi sono varie forme di linguaggio in gioco» è un concetto forte, sul quale, negli anni ha avuto anche modo di confrontarsi con Remo Bodei. Può spiegare il significato di questa affermazione?
Quando nel 2018 pubblicai Il lavoro 4.0 come atto linguistico performativo (in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari, Il lavoro 4.0, Firenze 2018), che poi, con alcune integrazioni, divenne il primo capitolo del libro di cui stiamo parlando, Remo Bodei apprezzò molto il mio contributo che prefigurava un tipo di rapporto tra l’uomo e la creazione di oggetti fisici sul modello del rapporto con cui il Dio della Bibbia crea oggetti quale Verbo: «Dio disse […] E così avvenne». Purtroppo, la morte di Bodei ha interrotto il nostro dialogo del quale però ci sono ampie tracce nel suo ultimo libro, Dominio e sottomissione, in cui parla del rapporto tra uomo e macchine. Quanto ai linguaggi in gioco, nel lavoro della Smart Factory sono legati al fatto che in essa ci sono tre tipi di comunicazione: quelle tra gli uomini, quelle tra uomini e macchine, quelle tra macchine e macchine. Dal punto di vista della “natura” del lavoro, decisive sono quelle che si svolgono tra uomini e macchine perché, come nel caso della stampante a tre dimensioni, performano oggetti (e servizi) sulla sola base di una comunicazione digitale in cui consiste l’essenziale creazione lavorativa dell’uomo.
Distinguere, giudicare, scegliere: come “rimanere umani tramite la tecnica”
Nel nuovo modello di impresa si “producono beni comunicando”, siamo di fronte a un salto logico e culturale profondo rispetto alla concezione moderna del lavoro. Manager e imprenditori sono preparati ad affrontare i nuovi scenari che si stanno aprendo, che investono società e impresa?
Una volta stabilita la “natura” linguistica del nuovo lavoro svolto in “fabbrica”, ho cercato di trarre quelle che mi sono sembrate le principali conseguenze di questa circostanza, che riguardano àmbiti centrali della nostra esistenza, quali l’etica, l’identità personale, la concezione del “tempo libero” e quella del conflitto sociale. La questione della direzione d’impresa, cui lei fa cenno, è trasversale a tutti questi àmbiti, e nel libro viene ripetutamente toccata, anche se non tematizzata specificatamente. Se il lavoro è essenzialmente linguaggio, occorre un ambiente di lavoro in cui la libertà sia ampiamente riconosciuta: senza libertà non si comunica e non si interloquisce, non si è creativamente autonomi, non si realizza un lavoro soddisfacente che richiede un ozio altrettanto creativo e attivo, nel tempo di non lavoro, soprattutto non si può trasformare il conflitto in una dialettica partecipativa in grado di confrontarsi linguisticamente e sulla base delle conoscenze. Ma tutto questo richiede un management che abbia superato il modello top-down fordista e sia, invece, capace di rapporti collaborativi e autonomi tra direzione e dipendenti a tutti i livelli.
Libertà e lavoro un connubio indissolubile
Il titolo del suo saggio, fa tornare in mente un celebre scritto di Vittorio Foa: La libertà dentro il lavoro, con cui lo studioso intendeva sottolineare la missione della politica, ma anche e soprattutto del sindacato, che doveva dimostrare di essere pronto a comprendere le fenomenologie della trasformazione destinate a cambiare il profilo del Novecento. A che punto siamo su questo delicato fronte? L’auspicio di Foa è destinato a rimanere nel regno dell’utopia?
Nel libro che lei ricorda, ed in altri, Vittorio Foa – come Bruno Trentin che nel libro cito frequentemente – insiste sul concetto che anche nelle più sfavorevoli condizioni di lavoro, come quelle fordiste, il lavoratore non rinuncia mai alla propria libertà. La fine del fordismo, il lavoro della conoscenza, il lavoro come atto linguistico in ambiente digitale, sono stati e sono occasioni per affermare questa libertà. In questo senso parlo di “sfida” della rivoluzione digitale. La quale può anche essere occasione di un maggiore e più sofisticato controllo da parte di algoritmi e macchine, capaci di controllare e valutare in tempo reale le attività lavorative. Ma l’innovazione richiede un “coinvolgimento” intellettuale ed emotivo del lavoratore e questo è raggiungibile solo con il riconoscimento di un sufficiente grado di libertà. Riconosciuto da parte dell’azienda e ottenuto, anche col conflitto, da parte del lavoratore che dovrebbe porsi l’obiettivo di codeterminare i programmi della macchina nel quadro di un’ampia e attiva partecipazione. La novità è che, per la prima volta, libertà e produttività del lavoro dipendente possono coincidere.
I diritti dei lavoratori sono oggi messi a rischio da quel fenomeno che molti definiscono come il “capitalismo della sorveglianza”. Esiste, a suo giudizio, il rischio di un “neo-teylorismo tecnologico”?
Il recente libro di Shoshana Zuboff, Capitalismo della sorveglianza, come altri volumi usciti negli anni scorsi, tra i quali occorre ricordare i testi di Zygmunt Bauman, rilevano il fatto inquietante che la nostra esistenza viene continuamente “sorvegliata” e codificata nel linguaggio digitale da parte di Google, Facebook, Microsoft ed altri, per essere venduta alle aziende per il loro marketing. Si tratta di un vero e proprio “mercato dei comportamenti” e delle “intenzioni di consumo”, cui contribuiamo gratuitamente e che fa la fortuna finanziaria delle grandi imprese hi-tech. In Europa esiste una buona normativa a difesa della privacy (il GDPR, 2018), ma non è stata ancora efficacemente attuata. L’aspetto più preoccupante non è tanto quello commerciale, quanto quello politico. I dati raccolti possono avere, come hanno già avuto, un impiego politico, ad esempio nelle competizioni elettorali, mettendo in crisi aspetti fondamentali delle nostre libertà democratiche. Si tratta del “lato oscuro” della rivoluzione digitale – cui si è aggiunto l’impiego di apparecchi televisivi che spiano le nostre preferenze nei confronti dei programmi al fine del calcolo degli ascolti – che ognuno deve imparare a controllare e a combattere.
Democrazia, libertà e salute: valori sotto scacco in tempo di pandemia
“La qualità e il senso del lavoro dovrebbero essere materia di contrattazione collettiva” come Lei scrive. È su questo terreno che si dovrà sempre più misurare l’apporto del sindacato nell’universo della digital society?
Al lavoro in genere si dedica la maggior parte del tempo della vita attiva e in questo tempo si costruisce gran parte della nostra identità personale e sociale (l’altra parte viene costruita nel tempo di non lavoro che comprende le relazioni personali, la formazione e l’ozio). Quando si tratta di lavoro dipendente è essenziale che questo lavoro sia il più possibile codeterminato tra chi lavora e la direzione d’impresa, al fine di evitare al massimo un tempo di lavoro eterodiretto e alienato, capace di determinare personalità marcate da questo fatto. Questa codeterminazione è tanto più possibile quanto più elevato e meno esecutivo e ripetitivo è il lavoro, come accade nel lavoro della conoscenza (e linguistico). Più è elevata la qualità del lavoro, professionalmente e per le condizioni di svolgimento, ovvero quanto più il lavoro corrisponde alle aspirazioni individuali e più liberamente e con più soddisfazione viene svolto, tanto maggiore è l’autorealizzazione personale nel lavoro. Ma nell’impresa moderna, a differenza del laboratorio artigianale, i processi produttivi e di impiego della forza lavoro non avvengono nella piena consapevolezza di chi lavora, oltreché essere spesso apertamente coercitivi e iniquamente compensati. L’insieme di queste problematiche, in cui è in gioco il senso del lavoro, non possono che essere contrattate e a questo fine indispensabile appare l’azione sindacale, quando il sindacato è presente. Nel lavoro come atto linguistico la coercizione e l’esecutività non sono conciliabili con il coinvolgimento e la produttività della persona che lavora, questa è la base della nuova “sfida”.
La centralità della persona nell’impresa rete
“Centralità della persona” spesso si tramuta in un facile slogan in tanti interventi e discorsi aziendali. Le organizzazioni reticolari possono facilitare l’espressione autonoma dei lavoratori, facendo emergere nuove leadership?
La riproposizione della persona e la sua “centralità” nel lavoro sono una realtà, oltreché essere una necessità di tutte le forme del lavoro della conoscenza e del lavoro digitale come atto linguistico. Ma non sempre il management è disposto ad accettare pienamente questa esigenza, in particolare nelle organizzazioni in ritardo nell’innovazione. L’ostacolo principale a questo riconoscimento è la cultura fordista che spesso anima ancora la direzione ed il conflitto. Alla base ci sono il timore della perdita del “comando” e la sottovalutazione della partecipazione e delle responsabilità nei confronti del risultato che il dipendente è disposto ad assumere. Ma l’organizzazione a filiera e reticolare, che sempre di più configura la produzione, richiede sempre di più un lavoro di squadra (team) e individuale responsabile, creativo e capace di risolvere autonomamente i problemi che è impossibile organizzare con un management fordista.
L’algoritmo è al centro delle scelte, anzi è proprio l’algoritmo che decide assunzioni, strategie, orientamenti. L’etica, quale spazio può avere in un ecosistema letteralmente dominato dalla tecnologia?
Propriamente parlando, non esiste un “ecosistema dominato dalla tecnologia”, ma solo dall’organizzazione e dal Design che l’uomo gli ha dato ed in cui sono previsti la collaborazione e l’impiego delle macchine digitali. Non è l’algoritmo che assume personale, ma l’uomo che impiega questo strumento. Quindi, occorre codeterminare questo uso, cioè i programmi che lo mettono in atto. La digitalizzazione dell’economia esige livelli maggiori, e non minori, di partecipazione e informazione delle persone che lavorano.
Responsabilità, democrazia, futuro del lavoro, come trovare un equilibrio tra queste componenti se a dettare legge saranno sempre più robot e macchine intelligenti?
Come ho già detto, tutto dipende dall’organizzazione della volontà imprenditoriale. La tecnologia ha indubbiamente proprie leggi autonome, ma le finalità possono e devono essere sempre stabilite dall’uomo. Nel caso di robot – capaci, entro certi dati a disposizione (che l’uomo ha messo, almeno inizialmente, a loro disposizione), di compiere scelte autonome, ma comunque nell’arco di determinati quadri e limiti – l’uomo può e deve imparare a collaborare (cobot), lasciando a sé stesso la definizione delle finalità superiori e innovative, che la collaborazione della macchina può aiutare a isolare e riservare quale compito specificatamente umano.
Fabbrica e città (vengono in mente Le città invisibili di Italo Calvino) impresa e ambiente, come cambia il rapporto tra queste componenti sulle quali è stato costruito un modello di convivenza che ha retto, pur tra mille contraddizioni, lungo tutto il corso del Novecento, oggi messo alla prova dalla crisi sanitaria?
Nel 1997 Bruno Trentin pubblica La città del lavoro, in cui si denuncia il fatto fondamentale che la democrazia, come sostiene Norberto Bobbio, si arresta sulla soglia della fabbrica, perché il moderno lavoro industriale subordinato non riconosce nell’operaio i diritti del cittadino: il lavoro fordista, in auge in Italia fino agli anni Ottanta, è un’attività eterodiretta in cui la libertà della persona è coercitivamente piegata a direttive definite senza alcuna partecipazione del lavoratore, tenuto a realizzarle passivamente secondo la regola che l’operaio deve eseguire e non pensare. Ci sono ovviamente eccezioni, com’è il caso di Adriano Olivetti, ma la regola è questa: quella che tra la fabbrica e la città, con i suoi diritti democratici, vi è un muro che la cittadinanza non riesce a scavalcare. Nel libro ho cercato di dimostrare come il nuovo lavoro digitale, non per motivi ideologici o etici ma per necessità economiche e organizzative, ha profondamente trasformato questa realtà: nel lavoro 4.0 l’efficienza dell’impresa richiede autonomia, creatività e responsabilità che presuppongono un grado inedito di libertà. Questo accade nella Smart Factory che deve “coinvolgere” tutti i dipendenti. Non accade invece nell’“economia delle piattaforme” dove trionfa un neo-fordismo digitale ed il lavoro, anche se implica la comunicazione digitale, non si presenta con i caratteri di un atto linguistico, ma con quelli di un’attività manuale e fisica governata dall’algoritmo anziché dal “caposquadra”. Quindi, ugualmente coercitiva e sottomessa. Nel caso, invece, della “fabbrica 4.0 e nelle forme di partecipazione e di collaborazione che in essa si possono realizzare, i diritti della cittadinanza democratica sono in gran parte riconosciuti, o possono esserlo sempre di più su iniziativa del lavoro (la “sfida”) per cui la “fabbrica” può finalmente essere definita una “città del lavoro”.