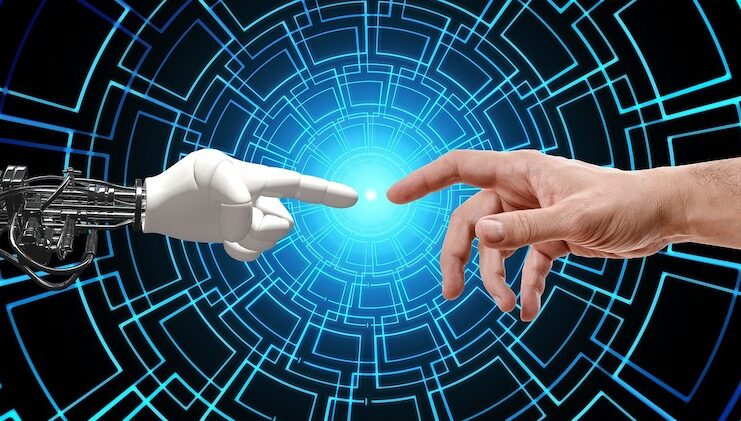Articolo 151: “L’Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali (…), hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione”.
Questo è l’incipit dell’articolo che apre la sezione “Politica sociale” del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e che esprime in larga misura i principi e i valori a cui la mia organizzazione, la UIL, si ispira nella sua azione quotidiana in difesa dei lavoratori del settore pubblico. Perseguire il rafforzamento del modello sociale europeo significa, innanzitutto, dare sostanza a quei principi e trasformare in prassi concreta quei valori. In altri termini, significa coltivare i presupposti di una buona e sana politica economica per il nostro Paese e per l’intera Unione Europea.
Credo che questo angolo di approccio sia particolarmente utile ed attuale in un periodo storico caratterizzato da una crisi economica e sociale senza precedenti, che sta colpendo ormai da almeno sei anni il nostro Continente e di cui ancora non si intravede la fine.
Una crisi lunga.
Insolitamente, stranamente lunga.
Al punto da apparire quasi creata, o quanto meno, alimentata in modo artificiale, se non addirittura eterodiretta dal potere finanziario. Una crisi che, però, rischia di far saltare quel modello storico di economia sociale di mercato che, probabilmente, ha rappresentato l’invenzione più efficace ed originale della cultura europea nel corso del XX secolo.
In realtà, l’aspetto più grave della difficile fase che stiamo vivendo sta proprio nell’interruzione del processo di integrazione sociale che aveva caratterizzato finora il cammino dell’Unione. Dopo più di 60 anni di storia comunitaria, é paradossale dover constatare che l’incremento dei vincoli di natura giuridico-economica fra i Paesi dell’Unione ha scatenato un movimento centrifugo sul piano dei livelli e delle prospettive di coesione sociale. Dobbiamo riconoscere che oggi, fra i Paesi europei, c’è molta più diversità sociale che in passato. Tutti gli studi ci dicono che i divari fra i Paesi dell’Unione sono in aumento, e che anche negli Stati sono enormemente cresciuti i divari interni. E questa divaricazione delle capacità di tutela dei diritti e di promozione delle politiche sociali appare ancora più evidente se consideriamo il nucleo più antico dei Paesi dell’Unione. Quelli che, proprio in virtù delle più profonde radici comunitarie, oggi dovrebbero far registrare una omogeneità economica e uno stadio di integrazione dei livelli sociali più avanzato.
Personalmente, sono convinto che esista una forte interconnessione fra il tema della qualità sociale del modello di sviluppo europeo e il tema della qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni nei singoli Paesi dell’Unione. Perché è proprio a livello di copertura e di qualità dei servizi pubblici che si registra l’incremento più forte dei divari all’interno dell’Unione e all’interno dei singoli Stati. E nella disomogeneità con cui il “pubblico” si dimostra in grado di presidiare i processi sociali e di orientarne le politiche a livello nazionale si annida, la malattia profonda del modello europeo in crisi di identità.
In nessun Paese, tanto meno in Italia, la presenza di una forte dinamica relazionale può costituire il surrogato della mancata attuazione di adeguate politiche pubbliche in tema di coesione e sostenibilità sociale del modello di sviluppo economico. Il punto è tutto qui. Se non si riporta il “pubblico” al centro dello sviluppo, il modello sociale va in frantumi. Non esiste più una società civile se le istituzioni pubbliche non promuovono politiche di sviluppo orientate al superamento dei divari. Ma lo sviluppo, a sua volta, è subordinato alla capacità di attuare politiche redistributive della ricchezza prodotta. La vera crisi ”di sistema” che l’Europa sta attraversando all’alba del XXI secolo non risiede tanto nella perdita di produttività, quanto nella mancata capacità di trasformare la crescita della produttività in maggiore ricchezza diffusa.
Per questo noi oggi dobbiamo iniziare seriamente a porci il problema di quale debba essere il ruolo della pubblica amministrazione per il rilancio del sistema Italia e per una sua ripresa di “competitività” sociale, prima ancora che economica, rispetto al sistema Europa. Se partiamo dal presupposto che il servizio pubblico rappresenta, per qualunque modello e in qualunque contesto, una garanzia di equità sociale, giustizia e democrazia, allora dobbiamo concludere che non c’è sviluppo possibile in Europa laddove il sistema pubblico dei servizi entra in crisi: cioè diventa selettivo e non più aperto a tutti, esclusivo e non più inclusivo, classista e non più universalista. E rispetto a questo genere di prospettiva, ogni Paese è chiamato ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Passate, presenti e future.
Quali sono state le scelte compiute dall’Italia in materia di qualità, inclusività, universalità del servizio pubblico negli ultimi 15 anni? Basta rileggere i testi delle manovre economiche o delle infinite “riforme” messe in campo per farsene un’idea. Per 15 anni la classe politica italiana ha adottato consapevolmente la scelta di superare la presunta inefficienza dei servizi pubblici restringendone il perimetro di competenza e sottraendole risorse in nome dell’equilibrio del bilancio statale e del rispetto dei parametri economici imposti dai trattati internazionali. Equilibrio in realtà mai raggiunto, come oggi possiamo amaramente constatare, malgrado gli enormi tagli alla spesa pubblica che hanno determinato un progressivo peggioramento della qualità dei servizi, mentre il debito pubblico continua incessantemente a crescere e a pesare sul destino delle generazioni future.
Fra il nostro Paese e l’Europa si sta formando un delta, si sta allargando un fossato sul piano del rispetto dell’uguaglianza di tutti i cittadini.
In Italia, l’impoverimento e la de-strutturazione dei servizi pubblici stanno determinando, di fatto, la progressiva esclusione dei ceti meno abbienti dalla possibilità/diritto di fruire del sistema di tutele e protezioni sociali. Sanità pubblica, istruzione pubblica, cultura pubblica, trasporto pubblico, assistenza pubblica diventano sempre più povere, non-governate ed inefficienti. E il non-governo del sistema pubblico è un disagio selettivo riservato a determinate classi sociali, costituite da chi non è in condizione di pagarsi gli analoghi costosi servizi offerti dal mercato.
In Germania si investono ogni anno oltre 7 miliardi di euro per le politiche attive, mentre in Italia si arriva a malapena a 500 milioni. In Germania i Centri pubblici per l’impiego, ossia le strutture pubbliche deputate alla realizzazione delle politiche attive e che avviano concretamente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dispongono di 120.000 operatori appositamente formati e specializzati, mentre nei Centri per l’impiego italiani lavorano poco più di 8.000 addetti, un terzo dei quali con rapporto di lavoro precario e formalmente dipendenti da un livello amministrativo – le province – in fase di dismissione.
Che fare, dunque ?
La prima cosa da fare è organizzare meglio le conoscenze. Sembra assurdo nell’era del web, dei multimedia e del cloud; eppure è così. Noi oggi disponiamo di un sistema di rilevazione delle dinamiche socio-economiche dispersivo e frammentario. Abbiamo immensi data-base assemblati grazie ad architetture software sempre più sofisticate, ma spesso ci manca una visione organica dei fenomeni e delle trasformazioni che avvengono nella società. Che poi è il presupposto essenziale per mettere in campo delle vere azioni di progettualità politica.
Per esempio, un tema del quale conosciamo ancora troppo poco, pur avendo a disposizione milioni di bit di documenti classificati e organizzati, è quello che riguarda il modo in cui si sta evolvendo in questi anni il sistema delle relazioni industriali su scala europea. In realtà, conosciamo relativamente poco anche di quello che sta avvenendo in Italia, specie dopo lo scompaginamento che ha fatto seguito all’avvento dei cosiddetti patti in deroga e dopo l’entrata in vigore degli accordi interconfederali del 28 giugno 2011 del 10 gennaio 2014, che hanno completamente ridefinito i rapporti tra i vari livelli della contrattazione riscrivendo – in un certo senso – il sistema delle relazioni industriali. Servirebbe una percezione più attenta delle trasformazioni che stanno avvenendo nel mondo del lavoro per effetto del nuovo clima relazionale che si va instaurando nelle aziende, dove sempre più si tende a fondere in un’unica variabile welfare e produttività, con ricadute enormi sull’equilibrio del modello sociale di interi distretti o di intere regioni. Siamo di fronte a un deficit di conoscenza che non investe solo l’ambito italiano, ma che forse interessa l’intero panorama europeo.
Dove sta andando il sistema relazionale? Di quali contenuti innovativi si sta riempiendo la contrattazione? Di quali funzioni sociali nuove essa si sta facendo carico, nell’Europa dei divari che aumentano ? Manca oggi in Italia un soggetto istituzionale che si faccia carico di queste domande e che possieda il know-how per elaborare risposte coerenti con le tendenze in atto delle politiche sociali europee. Manca un interprete istituzionale del dialogo sociale, declinato attraverso i processi di autoregolazione che il mercato del lavoro mette a punto per compensare le incongruenze della politica.
Forse è arrivato il momento di recuperare tale ritardo.
Occorre acquisire consapevolezza del fatto che elevare al rango di servizio pubblico la capacità di comprendere i fenomeni relazionali e partecipativi ci aiuterebbe a compiere scelte più sagge in materia di lavoro e di politiche sociali.
Proviamo a riflettere per un attimo sul tema degli istituti della partecipazione aziendale: cioè, di tutte quelle forme di presenza attiva nella vita delle aziende attraverso cui i lavoratori possono essere messi, anzi, possono decidere di mettere sé stessi in condizione di offrire un contributo diverso da quello del mero scambio “sinallagmatico” tra prestazione e retribuzione. Non è forse un argomento che ci pone davanti a una prospettiva rivoluzionaria in chiave di sostenibilità sociale dell’economia di mercato? Senza scomodare esempi illustri di imprenditori illuminati come Adriano Olivetti, o gli esperimenti condotti con successo già da decenni in alcune importanti aziende europee, possiamo tranquillamente affermare che l’esistenza di forme partecipative dei dipendenti alla gestione e alla responsabilità d’impresa si manifesta da sempre, più o meno apertamente, nell’ambito delle moderne dinamiche relazionali.
Ma oggi ci troviamo di fronte a un salto di qualità. Dovuto in parte alla necessità del mercato di esplorare meglio alcuni territori di confine del complesso rapporto tra capitale e lavoro; in parte al tentativo, abbozzato dal legislatore italiano, ma mai decollato, di introdurre una forma sistematica di regolamentazione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori attivate attraverso la contrattazione collettiva. Se leggiamo, o ri-leggiamo la delega, ancora inattuata, contenuta nell’ 4 della legge n.92 del 2012, ci rendiamo forse conto di che cosa parliamo: dagli organismi paritetici dotati di competenze a vasto raggio su tutti i possibili meccanismi di controllo della gestione aziendale, alla partecipazione dei lavoratori agli utili o al capitale dell’impresa e alla definizione, attuazione e controllo dei piani industriali.
C’è un intero universo di possibilità da esplorare.
C’è da mettere mano a un sistema di regolazione, monitoraggio e verifica che permetta di tenere sotto controllo un meccanismo affascinante, ma pieno di incognite e di ambiguità. Le potenzialità degli istituti della partecipazione sono straordinarie in chiave di ricadute sull’equilibrio del nostro modello sociale, a condizione però che la partecipazione sia attivata nell’ambito di una cornice di regole certe e condivise. Può la pubblica amministrazione permettersi il lusso di ignorare questi richiami? Può il servizio pubblico lasciare sguarnite certe funzioni ? Come è possibile non avvertire l’importanza di fare in modo che le tipologie partecipative che si vanno affermando non si sviluppino per germinazione spontanea, ma in una prospettiva di economia sociale che sia anche coerente con un quadro di riferimento europeo?
Nessun modello sociale può prescindere dalla presenza di un soggetto pubblico in grado di fare da snodo di collegamento fra politica, economia e collettività. Le considerazioni svolte sinora hanno un senso nell’ottica di salvare la pubblica amministrazione italiana dal processo di disgregazione a cui viene sottoposta negli ultimi anni.
Quanto più la pubblica amministrazione arretra e si arrocca sulle sterili funzionalità di una tecnocrazia autoreferente, tanto più il modello sociale si trasforma nel modello dei divari sociali ed economici che producono disuguaglianza e recessione. Noi l’8 novembre saremo in piazza a Roma per una grande manifestazione nazionale unitaria insieme ai lavoratori della pubblica amministrazione.
Se sapremo ricostruire una pubblica amministrazione equa, efficiente e professionale, cancelleremo i divari, faremo ripartire il nostro Paese e, soprattutto, daremo un contributo affinché l’Europa ritrovi la strada smarrita dello sviluppo e della solidarietà.