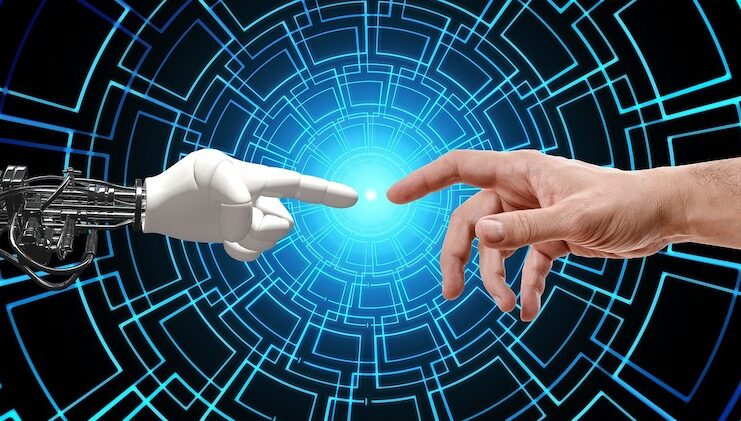Durante il corso della sua lunga vita politica, Joe Biden ha sempre avuto lo sguardo rivolto al massimo traguardo: la Presidenza degli Stati Uniti. Persino chi scrive ne ebbe una piccola testimonianza. La sua prima candidatura è del 1988. Vi arriva 38 anni e cinque Presidenti dopo. Dopo essere stato uno dei Senatori più giovani (eletto nel 1972, a 29 anni), è oggi il Presidente più avanti negli anni (78) ad assumere la carica, con sei mandati legislativi e otto anni di Vicepresidenza alle spalle. Questa montagna di esperienza politica offre una doppia chiave di lettura del 46° Presidente degli Stati Uniti: della sua personalità e del suo approccio alla meta così ambita ma mai così irta di sfide.
Nelle mura dell’Ufficio Ovale che ben conosce ha trovato ad attenderlo la tempesta perfetta; eredita dal suo predecessore una situazione non paragonabile a nessun inizio di presidenza americana del dopoguerra. La lista dei problemi da affrontare – tutti subito naturalmente – è lunga ma in estrema sintesi si può riassumere in tre grandi sfide: l’attacco alla democrazia americana; la pandemia dilagante che mette in ginocchio l’occupazione e mette a nudo le criticità della rete di sicurezza sociale; il ripristino della leadership internazionale degli Stati Uniti. C’è di che far tremare i polsi.
Da dove cominciare? È chiaro che viene prima l’America, poi il mondo. Questo non significa un inizio di presidenza introverso. Fra i primi atti ci sono già stati provvedimenti importanti di politica estera, lunghe telefonate a Justin Trudeau, Boris Johnson, Emmanuel Macron. Per formazione, interessi, esperienza, Biden è un Presidente internazionalista. Ha subito dichiarato suo obiettivo strategico il recupero delle alleanze, bistrattate da quattro anni di America first. Ma deve prima e prioritariamente mettere a fuoco i nodi interni, attaccando immediatamente pandemia e critica situazione economico-sociale della nazione. Scatto all’interno, politica estera in progressione. Gli alleati europei, impazienti di riannodare il dialogo transatlantico, devono anche dare alla nuova Amministrazione il tempo di mettersi a regime con la conferma delle decine di nomine in Senato. Nel frattempo, farebbero bene a pensare a come interagire con la presidenza Biden, in maniera propositiva; nel caso dell’Italia, ad esempio, gli argomenti non mancano: G20 (quindi Cina), NATO, cambiamenti climatici (nostra co-presidenza di COP26), Mediterraneo, Libia…
Il recupero di leadership internazionale non sarà una passeggiata. Il rilancio delle alleanze allieta gli amici, innervosisce i rivali. Russia, Cina, Iran non stendono tappeti rossi. Ma tutto fa pensare che l’America possa tornare nel ruolo che ha rivestito per tre quarti di secolo, sia pure in un mondo cambiato, come lo stesso Biden ha riconosciuto. Più arduo è il cammino all’interno. A favore del nuovo Presidente giocano però importanti fattori psicologici: età ed esperienza ne proiettano un’immagine rassicurante. È forse quello di cui gli americani (e non solo loro…) hanno bisogno dopo essere stati tempestati per quattro anni dalle esternazioni e dai tweet di Donald Trump.
In effetti, Joe Biden ha ben giocato la carta del leader fermo, misurato, razionale e competente fin dal momento in cui ha potuto presentarsi al Paese come “President elect”, mentre Trump ancora alla Casa Bianca ingaggiava freneticamente la battaglia sempre più persa del sovvertimento del voto. Sulla stessa lunghezza d’onda, il suo discorso inaugurale del 20 gennaio ha cavalcato la solennità del rituale, toccato le corde emotive dell’identità nazionale e beneficiato della brevissima parentesi di riconciliazione bipartisan – sulla stessa spianata che due settimane prima era stata teatro dell’insurrezione contro la sua elezione.
Poi è andato in ufficio e si è messo al lavoro. Si era preparato. Aveva messo in piedi una squadra il cui tratto comune è la competenza. Molti vengono dalle due Amministrazioni di Obama, alcuni sono fedelissimi di Biden come Anthony Blinken, nominato Segretario di Stato, altri hanno un impressionante curriculum professionale, come Janet Yellen destinata al Tesoro. Non poteva esserci più contrasto con l’improvvisazione a simpatie variabili del suo predecessore, con cambi continui e improvvisi nei posti chiave dell’Amministrazione, con poco o nessun riguardo a esperienza e professionalità, specie nell’ultima fase di presidenza. La squadra di Trump scendeva in campo con una formazione diversa per ogni partita e l’assoluta lealtà al capo faceva premio sulla qualità di gioco. Biden è arrivato alla Casa Bianca con una squadra ben affiatata e allenata, dove ognuno sa come schierarsi e quale ruolo occupare.
L’Inaugurazione era mercoledì. Prima del weekend il nuovo Presidente aveva firmato circa 40 Ordini Esecutivi con i quali revocava molte delle decisioni più dirompenti prese dal predecessore, disponeva il rientro degli Stati Uniti nell’Accordo sui cambiamenti climatici e nell’Organizzazione Mondiale della Sanità, varava le misure più urgenti per la lotta contro il Covid e per il sostegno economico dei meno abbienti colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia, dava subito forti segnali d’inclusione e di contrasto a diseguaglianze e razzismo. Ha immediatamente proposto alla Russia l’estensione per cinque anni del Trattato New START sulla limitazione dei missili balistici intercontinentali che scadrà il 5 febbraio. Aveva già annunciato un programma di stimoli economici che ammonta stimato in quasi 2 trilioni di dollari (per avere un’idea dell’ordine di grandezze, essi corrispondono a circa dieci volte il finanziamento del Recovery Fund che l’Italia attende dall’Ue), sulla scia di quello di 900 miliardi approvato dal Congresso nel crepuscolo a fine dicembre.
Non male per una mezza settimana di lavoro. Questa però era la parte più facile: si trattava essenzialmente di disfare l’operato di Donald Trump attraverso Ordini Esecutivi. I segnali, ad esempio, di inversione di rotta sui cambiamenti climatici, sono forti ma su una strada che Biden trovava già tracciata. Bastava invertire direzione di marcia. Il difficile viene dopo, nel momento in cui il nuovo Presidente comincia a tracciare la propria e deve, inevitabilmente, fare i conti con il Congresso, per la nuova legislazione, e con la nazione, dove un segmento non trascurabile continua a credere al mito trumpiano delle elezioni rubate – del tutto infondato e senza uno straccio di prova ma vivo e vegeto online. Un buon terzo degli elettori di Trump (74 milioni) professa di crederci. In buona fede o no è abbastanza da condizionare il Partito Repubblicano, lacerato dal dilemma se mettere definitivamente da parte l’ex-Presidente o continuare ad esserne subordinato. Non è un’alternativa accademica. Fra meno di due anni (novembre 2022) tutti i Congressmen e un terzo dei Senatori affronteranno di nuovo l’elettorato. Mettersi contro Trump significa rischiare di non riottenere la “nomination”.
Da ex-Senatore di lunga data Biden è ben attrezzato mentalmente per lavorare col Congresso e cercare un colloquio bipartisan. L’ha fatto per la maggior parte della sua vita politica. Ma non è mai stato alle prese con un Congresso e una nazione così divisi. Il nodo verrà subito al pettine in febbraio. Il Presidente sottoporrà il programma di stimolo; in parallelo, il Senato celebrerà il processo del secondo “impeachment” di Donald Trump.
Per quanto possibile Biden si è tenuto, e si terrà, alla larga dall’impeachment. Saranno piuttosto i repubblicani ad essere in difficoltà al momento del voto; la condanna richiede la maggioranza di due terzi (67) quindi il voto di ben 17 Senatori GOP. Uno solo (Mitt Romney) sembra sicuro, rendendo la soglia molto problematica – a meno che di fronte a schiaccianti argomentazioni sulle responsabilità dell’ex-Presidente nella “presa” del Campidoglio non prevalga un altro istinto di conservazione: per salvarsi da future disfatte elettorali, tipo la doppia sconfitta in Georgia costata la perdita di maggioranza in Senato, il partito deve scaricare Trump. Il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, si è abilmente tenuta aperta l’opzione di votare per l’impeachment.
Per il Presidente è molto più importante l’altra dinamica parlamentare, quella dell’approvazione del pacchetto di misure per il rilancio dell’economia. I democratici hanno la maggioranza in entrambe le Camere e possono farlo passare, sia pure di stretta misura. Per una presidenza che esordisce nel nome dell’unità nazionale e vuole ricucire dove il predecessore tranciava, sarebbe preferibile un voto bipartisan. Questo, tuttavia, implicherebbe concessioni ai repubblicani che, cambiato Presidente, si sono riscoperti fiscalmente ortodossi oltre che obiettori verso misure di sostegno sociale a loro avviso eccessive. Il che a sua volta scontenterebbe la base e l’ala progressista del Partito Democratico (Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez) alla cui mobilitazione Biden deve l’affluenza alle urne senza precedenti che gli ha permesso di incassare un voto popolare (78 milioni) senza precedenti. Infine, bisogna far presto: per avere un’approvazione rapida non c’è tempo per negoziare a lungo.
Lo stimolo è dunque la prima prova del fuoco che attende il nuovo Presidente degli Stati Uniti. È cruciale per due motivi. Innanzitutto, perché è la ricetta di Biden per il rilancio dell’economia – su cui si giocano da sempre le presidenze americane. It’s the econmy, stupid portò Bill Clinton alla Casa Bianca spodestando un Presidente, George H. Bush, che aveva avuto un successo travolgente in campo internazionale; la politica estera non aiuta a fare la spesa… In secondo luogo, come sarà approvato il programma, l’eventuale terreno di incontro con i repubblicani, segnerà il clima dei rapporti Esecutivo-Legislativo, maggioranza democratica-minoranza repubblicana, Casa Bianca-GOP e influirà sul bivio che spacca i repubblicani: emanciparsi da Donald Trump o continuare a seguirlo?
Quest’ultimo è, indirettamente, un nodo critico anche per la presidenza Biden, oltre che per il partito di Abraham Lincoln. La priorità allo stimolo economico e alle vaccinazioni (100-100: cento milioni di vaccinati nei primi cento giorni) è la risposta del nuovo Presidente alla sfida posta dal Covid, aggravata dall’incuria negazionista di Donald Trump. Ed è la più urgente, su cui egli può gettare le fondamenta del suo quadriennio alla Casa Bianca. È anche quella che gli offre ottime possibilità di successo grazie all’elasticità dell’economia americana e alle capacità di mobilitazione della nazione purché ben guidata. Ben più ardua è l’altra sfida interna, quella di ristabilire unità nella Democrazia e fiducia nelle Istituzioni. Richiede il concorso dei repubblicani. Senza di loro, Joe Biden può governare ma non riconciliare.
Passata la breve ebbrezza identitaria dell’Inaugurazione, non è detto che i repubblicani vogliano rientrare nei ranghi di un gioco politico duro ma condotto secondo le regole e lo spirito della Costituzione. Ammesso che buon parte di loro lo voglia, non è detto che l’ombra lunga di Donald Trump lo consenta. La partita principale della 46ma Presidenza si gioca sulla pelle della democrazia americana. Ha tenuto ma ha vacillato. Adesso tocca a Joe Biden blindarla. Il nuovo Presidente è partito bene ma lo attende una strada tutta in salita.
* Ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e rappresentante permanente dell’Italia presso la NATO.