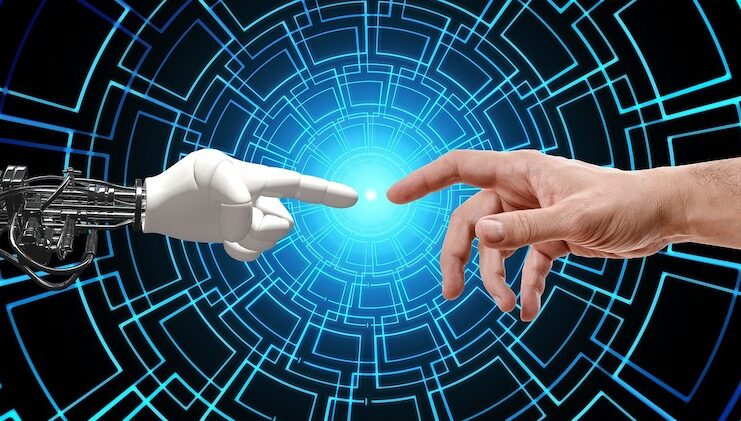Molte tesi riguardanti le migrazioni internazionali spesso usano la demografia per spiegare l’origine dei flussi migratori e giustificare politiche finalizzate più alla ricerca del consenso che alla gestione del fenomeno. Ciò riguarda, in particolare, la tesi di un supposto assalto in corso all’Europa da parte di flussi migratori di giovani africani. Una sorta di assedio destinato, peraltro, ad aumentare nel corso dei prossimi anni. Per questa via, si finisce col sostenere, con argomenti in realtà assai deboli, la tesi di una sorta di africanizzazione del Vecchio continente.
In Francia, ad esempio, uno dei testi più diffusi (Fuga in Europa, La giovane Africa verso il nuovo continente, Einaudi, 2018), sostiene che l’Africa sarebbe caratterizzata da un “rullo compressore demografico” alimentato dall’elevata fecondità a Sud del Sahara. Secondo alcune stime delle Nazioni Unite, la popolazione africana sarebbe destinata a passare da 1,2 miliardi di abitanti nel 2017 a circa 2,5 miliardi nel 2050, fino ai 4,4 miliardi nel 2100. Nel contempo, ancora secondo queste tesi, l’Africa sarebbe destinata a sviluppare un’economia in grado di far crescere i redditi dei suoi abitanti, garantendo loro i mezzi necessari per emigrare verso altri continenti. Per questa ragione, in molti, in Europa, prospettano una continua “fuga in massa” dal continente africano verso l’Europa con conseguente aumento della popolazione europea di origine africana. Quest’ultima, secondo le stime più recenti, fra trent’anni, dovrebbe attestarsi tra il 20% e il 25% del totale, contro l’1,5%-2% nel 2015. Su questa tesi molti partiti, xenofobi e sovranisti europei, hanno fondato la loro campagna elettorale e, quando al governo, le loro politiche securitarie.
Ma stanno realmente così le cose? Davvero questi studi giustificano la tesi di una prossima africanizzazione dell’Europa dando ragione a chi denuncia un Vecchio continente ormai sotto assedio da parte dei migranti africani? Proviamo ad analizzare nel merito queste tesi e a riflettere sulla complessità del fenomeno migratorio e sugli effetti che su di esso determinerebbe lo sviluppo economico.
Innanzitutto, è utile ricordare che il 70% circa dei migranti africani rimane, di fatto, nel proprio continente. È una migrazione che, seppure in uscita dal proprio paese di origine, resta all’interno del continente africano, senza mai approdare in Europa, Asia o America. Si tratta di una percentuale che è stabile dal 1990 e, quindi, sufficientemente monitorata per ritenere che anche in futuro non ci saranno cambiamenti importanti.
Inoltre, i dati del Fondo Monetario Internazionale, dell’OCSE e della Banca Mondiale, sostengono che gli afro-europei verso il 2050 saranno solo dal 3% al 4% del totale della popolazione europea. Una cifra ben lontana dal 25% ipotizzato. Ciò significa che nei prossimi decenni la povertà africana sarà ancora così endemica da non agevolare né ampliare la platea delle persone disposte ad emigrare verso altri continenti. L’Africa sarà ancora troppo povera per fare le valigie ed emigrare verso l’Europa. Le analisi demografiche, pure fondamentali, devono fondarsi su studi metodologicamente ben articolati e non precipitare in favore di conclusioni approssimative e grossolane. Già queste due considerazioni contestano, nel merito, la tesi di una prossima africanizzazione dell’Europa.
Un’ulteriore ragione che smonta la tesi dell’invasione africana in Europa riguarda il fatto che lo sviluppo economico, in Africa, se pure reale, continuerà a condannare milioni di persone alla povertà per via delle gravi perequazioni che lo caratterizzerebbero, impedendo loro di emigrare se non a fronte di rischi elevatissimi. Le popolazioni dei paesi molto poveri, infatti, si spostano poco non potendosi permettere viaggi lunghi, costosi e rischiosi.
È utile ricordare che, fino al 1971, le analisi sulle migrazioni erano fondate sul modello neoclassico secondo il quale, quasi meccanicisticamente, ad un minore divario di livello economico tra i paesi di partenza e quelli di arrivo corrisponderebbero flussi migratori più contenuti. Questo modello è stato messo in discussione dal geografo Zelinsky, il quale avanzò l’ipotesi di una “transizione nella mobilità”, chiamata anche transizione migratoria. In altre parole, la dinamica di Zelinsky prevede che allo sviluppo dei paesi più poveri segua una diminuzione della mortalità e, conseguentemente, un ringiovanimento della popolazione residente con relativo aumento del tasso di emigrazione. Questa dinamica si interromperebbe, ancora secondo il geografo, appena raggiunto un certo livello di sviluppo economico, trasformando i paesi con forte tasso d’emigrazione in paesi di immigrazione. Si consideri, per esempio, la storia migratoria di alcuni paesi europei caratterizzati da importanti tassi d’emigrazione, come l’Italia, la Spagna o l’Irlanda, i quali, dopo aver registrato importanti tassi di sviluppo economico, sono divenuti paesi di immigrazione (Rapporto Italia, Eurispes, 2016). Questa stessa dinamica potrebbe essere presto seguita da paesi come la Turchia, la Cina, l’India o il Marocco. Si tratta di un processo d’inversione che, con ogni probabilità, interesserà anche l’Africa, a meno che questo continente non diventi la prima eccezione nella storia delle migrazioni mondiali.
La stessa idea, diffusa in Italia da una classe politica poco qualificata su questo tema, secondo la quale si devono “aiutare gli africani a casa loro”, risulta poco efficace, stando alle considerazioni svolte sopra, poiché il sostegno allo sviluppo con cui si pensa di trattenere gli africani, profughi o meno che siano, nei loro paesi di origine, rischia, nella sua prima fase, di legittimare il diritto all’emigrazione per milioni di giovani africani.
Per spiegare questo fenomeno sono state avanzate diverse tesi. In primis, l’alleggerimento dei vincoli economici. Emigrare, infatti, costa molto e prevede il pagamento del visto, del biglietto aereo, delle spese per il trasporto, per soddisfare i vincoli imposti dalle legislazioni dei paesi di destinazione. Tutto questo costituisce, senza alcun dubbio, un vincolo per le persone povere, aggirabile solo mediante l’utilizzo di percorsi informali o viaggi della speranza. Si tratta di ciò che Emilio Drudi definisce “fuga per la vita” (Tempi Moderni, 2017) e che spesso costa proprio la vita di migliaia di persone, bambini compresi, per via di tragitti informali gestiti da trafficanti di esseri umani e organizzazioni criminali. L’aumento dei redditi permette, dunque, ad un numero maggiore di persone, di disporre dei mezzi necessari per intraprendere il viaggio migratorio. Il miglioramento delle condizioni economiche dei paesi economicamente poveri non significa solo il potersi permettere di affrontare i costi vivi e ufficiali per emigrare in sicurezza in Europa ma, anche, di avere la possibilità di migliorare le proprie relazioni sociali, la quantità e la qualità delle proprie informazioni, il proprio stato di salute e la possibilità di realizzare i propri progetti migratori.
La domanda che è necessario porsi riguarda le ragioni per cui, nonostante la povertà economica, i regimi dittatoriali, le guerre e i disastri ambientali, migliaia di africani continuino a lasciare il loro paese andando alla ricerca di qualcosa di diverso in un altro paese o continente, attraversando ostacoli naturali e politici di notevole pericolosità. La risposta è più articolata di quello che comunemente si immagina.
Negli Stati economicamente poveri, il relativo sviluppo non è sinonimo di prosperità collettiva. Persistono disuguaglianze strutturali rilevanti e, di conseguenza, ampie fasce della popolazione restano, anche nelle fasi di sviluppo economico, escluse dallo stesso e condannate a vivere condizioni di indigenza economica o di povertà. Un esempio possibile riguarda le politiche di modernizzazione dell’agricoltura in paesi poveri a vocazione agricola, le quali trasformano il mondo rurale sino a condannare migliaia di persone alla disoccupazione e alla povertà. Uno dei casi più noti riguarda la politica di modernizzazione delle attività agricole realizzate in India con il nome di “green economy” e che ha certamente migliorato l’organizzazione imprenditoriale del settore agricolo, in particolare nella regione del Punjab, ma anche generato una trasformazione nel relativo sistema rurale con conseguente aumento della disoccupazione e dei flussi migratori verso paesi maggiormente sviluppati. È noto il caso dell’emigrazione indiana sikh diretta prima verso paesi occidentali anglofoni e poi anche nell’area del Mediterraneo.
Questi flussi sono composti generalmente da giovani, sempre più istruiti, emarginati socialmente perché non riassorbiti dal sistema industriale che caratterizza, in particolare, le aree urbane. Si ingrossano, dunque, le fila degli emarginati, bloccati nelle campagne, dipendenti dalle famiglie o da vari sistemi di sopravvivenza, segregati in condizioni di marginalità da chi invece è riuscito ad intercettare lo sviluppo economico. Non si tratta di poveri in senso assoluto ma, spesso, di giovani lavoratori disoccupati ed impoveriti che vedono crollare il loro status sociale, precipitando in classi sociali inferiori. Si tratta di un precipizio nel quale cadono milioni di persone, spinte ad emigrare per trovare altrove le condizioni, anche minime, per poter sopravvivere insieme alla propria famiglia.
A queste riflessioni si devono aggiungere quelle sul carattere specifico della crescita economica, spesso iniqua e disfunzionale, e quelle sugli effetti sociali delle logiche di mercato, dei processi di accumulazione del capitale e di accaparramento delle terre e delle acque da parte dei grandi gruppi industriali, dei fondi finanziari e di alcuni specifici Stati (Cina, Usa, Italia, Francia, ecc.), delle crisi ambientali.
Se gli studi sulla transizione migratoria giungono tutti alle medesime conclusioni è in ragione del fatto che essi prendono in esame lo stesso tipo di sviluppo, basato non sulla ricerca di un’occupazione ampia e di un mercato del lavoro adeguatamente articolato, tutelato e regolamentato, a diritti democratici costituzionalmente garantiti, sulla riduzione delle disuguaglianze e delle criticità ambientali, ma sul libero scambio quale unica bussola per orientare lo sviluppo stesso, sulle privatizzazione di servizi essenziali come i beni comuni, sulla flessibilità del mercato del lavoro e sulla precarizzazione della vita sociale, sull’ottimizzazione dei “vantaggi comparati” per attirare investimenti stranieri, a tutto svantaggio delle popolazioni più fragili.
In realtà, non è lo sviluppo a provocare l’emigrazione ma lo squilibrio tra l’offerta e la domanda occupazionale, in particolare per i giovani, determinata dalle politiche promosse dai vari governi, a cui si associano le crisi politiche, economiche, di democrazia e ambientali che fasce sempre più ampie della popolazione sono costrette a vivere, situazioni di conflitto continuo, azioni terroristiche, violenze e discriminazioni per le più varie ragioni, interessi economici e industriali predominanti, alcuni dei quali riconducibili agli Stati occidentali o ai grandi gruppi industriali che caratterizzano la globalizzazione economica.
La tesi diffusa in Europa, dunque, per cui decine di milioni di africani sarebbero pronti ad invadere le coste italiane, greche o spagnole e che l’identità europea (mai in realtà specificata nel merito) sarebbe seriamente minacciata dall’immigrazione africana, non è sostenibile, perché fondata su tesi superate, sulla disinformazione o sull’uso strumentale delle paure indotte dalla pianificazione dell’odio astutamente articolata, organizzata e perseguita.
Rispetto a questa tesi, ne esiste un’altra che è, probabilmente, migliore. Non è automatico che nei paesi di ingresso di flussi migratori di richiedenti asilo africani o asiatici, come l’Italia, la Francia, la Spagna o la Grecia, si diffondano sentimenti d’odio o repulsione nei riguardi dei migranti. Tali sentimenti nascono in contesti in cui dominano l’austerità generalizzata, la destabilizzazione del sistema previdenziale che rende incerto il futuro delle generazioni più vecchie e di quelle più giovani – queste ultime hanno visto già abbondantemente restringersi le loro possibilità di andare in pensione –, l’ indebolimento dei servizi pubblici, le scelte politiche che mettono in competizione tra loro i poveri, il pubblico e il privato, i lavoratori e i pensionati, coloro che hanno un salario minimo garantito e coloro che sono disoccupati di lungo periodo. In queste circostanze, l’arrivo dei migranti viene rappresentato come un’ulteriore pressione, non richiesta e non autorizzata, su risorse economiche sempre più limitate, sulle quali fanno leva partiti e movimenti che hanno sviluppato una spiccata vocazione xenofoba fondata sulla colpevolizzazione del migrante e sulla divisione delle classi popolari. Sono le politiche neoliberiste proposte in Occidente a dover essere cambiate, insieme al mercato del lavoro e alle politiche estere dell’Unione europea. Il modello economico vigente deve essere riformato a partire dalla rottura con le politiche xenofobe e razziste, perché si sia in grado di osservare e comprendere la complessità delle migrazioni in generale e con esse della società contemporanea, senza rincorrere scorciatoie e semplificazioni che rischiano di condurre l’Europa verso una crisi così profonda da metterne in discussione l’intero impianto democratico e liberale.