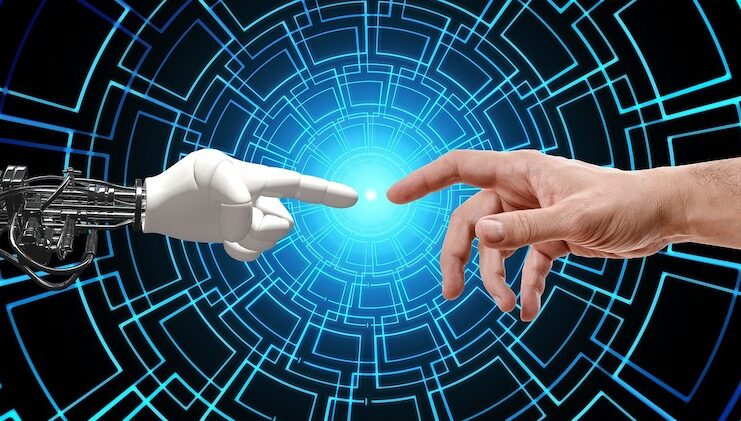La guerra in Ucraina ha reso effimere molte delle parole spese, durante i momenti cruciali della pandemia, per descrivere la condizione della gente minacciata dal virus. Nulla di paragonabile però a quanto accaduto dopo. Migliaia di persone, costrette dai bombardamenti e dall’artiglieria, hanno formato ondate di esuli. In tanti hanno dovuto lasciare le case, spesso distrutte e inagibili, riversandosi dove possibile, nei paesi europei confinanti e altrove. Il lockdown della pandemia ci aveva fatto sperimentare la separazione tra le persone, la rottura delle relazioni, la frantumazione del tessuto sociale. L’invasione del 24 febbraio ha dato origine ad un’epoca assai più cruenta di dispersione umana. Molte famiglie hanno perso sotto le bombe i loro cari, altre si sono divise a forza: gli uomini al fronte a combattere; le donne, gli anziani, i bambini in cerca di rifugi. L’attualità non cessa di contare il numero di morti e profughi, vittime della paranoia del potente vicino, che usa la popolazione civile come arma di pressione. Una parte di quell’umanità aggredita ha dovuto scegliere la lontananza, il distacco dai propri cari, l’esilio dalla terra che li ha visti nascere e vivere, senza alcuna certezza di ritornare. Sarebbero circa cinque milioni le persone rifugiatesi in paesi europei.
Una migrazione dovuta non a ragioni economiche o climatiche, ma a un terribile sogno arcaico di potenza
Certe volte non rimane che l’immaginazione per continuare a sperare, vincere lo sconforto. Forse ci si consola un po’ pensando che «essere lontani è un modo di abitare il proprio paese», come ha scritto il filosofo argentino Miguel Benasayag, descrivendo il fenomeno migratorio contemporaneo. Sempre che beninteso si riesca, tra tante sciagure, a «portare il proprio paese dentro di sé». Lo sradicamento è la patologia che affligge le persone, alle prese, senza averlo voluto, con situazioni complicate, altre lingue, diversi costumi, assenza di legami sicuri e riferimenti noti. È l’ennesimo esempio di migrazione, dovuto non già a ragioni economiche o climatiche, ma agli effetti di una guerra determinata da un terribile sogno arcaico di potenza. La fuga in cerca di salvezza segna una cesura con il proprio passato, allontana dal mondo abituale, infrange il radicamento sociale, quella sicurezza che Simone Weil, in Radicamento, Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano (1951), definiva «il bisogno più importante e misconosciuto dell’anima umana», forse anche il più struggente, cioè l’appartenenza a qualcosa.
L’operazione serve a creare il mito fittizio del Donbass filorusso e svilire l’identità dell’Ucraina
Eppure la vicenda umana di tanti profughi, che gli stessi italiani hanno accolto numerosi e con generosità, non esaurisce la tragicità del momento. Di quello stato fisico e mentale l’attualità offre infinite declinazioni, persino più laceranti, quando lo squarcio attraversa la percezione di sé. La storia dello scrittore ucraino di lingua russa Vladimir Rafeenko (raccontata da ultimo da Marco Imarisio su La Lettura, 20/3/22) racchiude incredibili contraddizioni, che nessun saggio sui rapporti tra Russia e Ucraina riuscirebbe a mostrare in maniera altrettanto chiara. Nato nel Donbass da genitori di lingua russa, parla e scrive solo in russo, vince numerosi premi, si afferma nel mondo delle lettere, diventa un personaggio importante della letteratura russa. Afferma che deve «tutta la notorietà a Mosca», e che nonostante la guerra avrebbe potuto proseguire l’ottima carriera, ma confessa il suo stupore: non avrebbe mai «immaginato di doversi difendere dalla Russia».
Nel 2014, con l’invasione del Donbass e della Crimea, sceglie di trasferirsi a Kiev e d’imparare l’ucraino, una lingua che – va aggiunto – conosceva poco e tuttora ha difficoltà a parlare in modo fluente, tanto da fargli dubitare di poter scrivere in ucraino. Tuttavia oggi la brutalità dell’azione armata è sconvolgente. Putin ha voluto un’accelerazione violenta del processo di “russificazione” del territorio iniziato dopo la Seconda guerra mondiale. Tutta l’operazione serve a creare il mito fittizio del Donbass filorusso e con esso perseguire il disegno di svilire l’identità del paese che anche in quella zona era sopravvissuta nelle tante tradizioni popolari. Il punto doloroso di non ritorno è constatare di non poter più usare, di fronte allo sfacelo, la sua stessa lingua madre, il russo.
Vladimir Rafeenko, scrittore ucraino di lingua russa in conflitto con la propria identità
Rafeenho è ormai entrato in conflitto con sé stesso, la sua cultura, le parole usate fin qui. Non riesce a spiegarsi perché sia accaduta questa follia etichettata come operazione di denazificazione. Non comprende che cosa, di anomalo, ci fosse in vite come la sua. Lui si era sempre sentito «un ucraino che scrive in lingua russa, questa era la cosa chiara e comprensibile». Il malessere con il quale ha dovuto fare i conti deriva da una ferita impossibile da rimarginare, il sentirsi strappato dalle origini proprie e dal suo mondo, esattamente quello che è stato costretto ad abbandonare.
«Pensavo che l’Ucraina fosse proprio quel pezzo di terra e di città dove abitavo, che quella fosse la mia terra, anche se parlavo un’altra lingua». Non c’era nulla di strano a rivendicare la propria appartenenza all’Ucraina pur scrivendo in altra lingua, «in un paese così grande, pieno di tante culture diverse», questa la dolorosa conclusione.
C’è un nesso tra lo sradicamento e la visione autoritaria perseguita da Putin
C’è un nesso inestricabile tra lo sradicamento, non importa se fisico o psicologico, e la visione autoritaria perseguita da Vladimir Putin. Soprattutto si rinnova la minaccia che l’Europa ha ben conosciuto con il nazismo e il fascismo. Il furto del passato, la manomissione del legame con le proprie idee, è il medesimo male che ha generato la pulizia etnica di Hitler, l’asservimento di Stati indipendenti da parte della Germania nazista, la matassa del colonialismo moderno.
Oggi la storia si ripete tragicamente. L’invasione dell’Ucraina determina lo scollamento di un popolo dal suo territorio, la menomazione dell’identità nazionale. Alla base c’è la convinzione errata che la patria non sia anche un luogo, esattamente quel lembo di terra che costituisce il grumo prezioso di affetti, ricordi, pensieri. L’estraniamento individuale è la condizione diffusa di chi in questo momento subisce la guerra scatenata dal tiranno, precede a ben vedere altri effetti catastrofici: l’isolamento e la superfluità.
Ammoniva Hannah Arendt, ne Le origini del totalitarismo (1951), «Essere sradicati significa non avere un posto riconosciuto e garantito dagli altri; essere superflui significa non appartenere al mondo. Lo sradicamento può essere la condizione preliminare della superfluità, come l’isolamento può esserlo dell’estraniazione».
L’invasione dell’Ucraina determina lo scollamento di un popolo dal suo territorio
Le discussioni sulla neutralità dell’Ucraina mascherano l’intento efferato di renderla un paese invisibile, nascosto persino ai suoi stessi cittadini. Sono, queste della Arendt, come quelle della Weil, categorie elaborate per rispondere al lutto post bellico, per impostare una reazione morale contro i propositi tirannicidi su altri popoli. Oggi quei concetti sono sconcertanti nella loro attualità. Servono a comprendere il senso della contemporaneità. L’eliminazione del legame di ogni individuo con la propria storia è il fulcro della politica di aggressione perseguita dalla Russia di Putin.