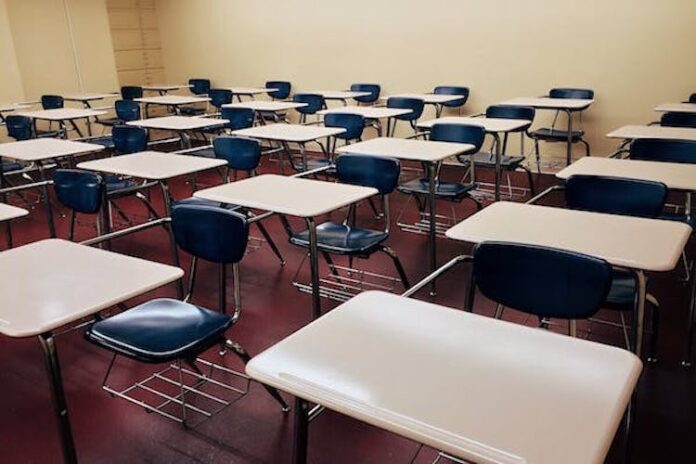La pandemia, la guerra, le grandi crisi internazionali sembrano aver messo in discussione un po’ tutti i paramenti di riferimento della vita sociale. Il senso di smarrimento che tutti noi proviamo pare avere reso tutto più complesso, difficile da capire. Sovente si ha la sensazione di non avere le categorie per interpretare la realtà che ci circonda e questo spaventa e disorienta. La scuola non fa certo eccezione, ma non sembra essere adeguatamente al centro dell’attenzione della pubblica opinione. Tutti dovrebbero preoccuparsi di risultati così poco soddisfacenti per molti allievi, poiché essi sono un problema per tutti i cittadini, per l’intera collettività nazionale. Non dovremmo mai dimenticare che una democrazia moderna può funzionare solo se i suoi cittadini hanno un livello di istruzione adeguato, altrimenti viene meno la capacità del singolo di trovare una sintesi, per definizione provvisoria e dinamica, tra diritti e doveri che sono alla base di qualsiasi forma avanzata di convivenza civile.
La scuola non sembra essere adeguatamente al centro dell’attenzione della pubblica opinione
Ma la situazione è veramente così catastrofica come qualcuno la dipinge o, invece, guardiamo gli esiti della scuola attraverso una lente inadeguata? Partiamo degli esiti delle prove INVALSI 2022 al termine della scuola secondaria di secondo grado. Ma subito ci dobbiamo chiedere se esse siano la lente giusta o se, invece, siano proprio loro a fornirci un quadro a tinte troppo fosche. Come noto, ogni misura è parziale e ci fornisce una prospettiva, tra le diverse possibili. Forse nemmeno la metafora della fotografia è la più adeguata, poiché tutti noi sappiamo che angolature o prospettive diverse possono fornirci esiti molto differenti. Ma allora, come uscire dal problema? In primo luogo, cercando di capire se sistemi di misura diversi ci forniscono immagini simili, ossia se abbiamo riscontri anche esterni alle prove INVALSI che ci danno informazioni coerenti con quelle fornite dalle prove predisposte dall’Istituto nazionale di valutazione. È noto che ormai da anni, forse decenni, quando usiamo misure comparabili, nazionali o internazionali, gli esiti che otteniamo sono sempre coerenti con quelli che ci restituiscono le prove INVALSI e questo ci aiuta a trarre alcune informazioni fondamentali sul funzionamento del nostro sistema scolastico.
Nel 2022 uno studente su dieci ha terminato la scuola secondaria di secondo grado in condizioni di forte fragilità
Nel 2022 il 9,7% degli studenti ha terminato la scuola secondaria di secondo grado in condizioni di forte fragilità, conseguendo esiti molto più simili a quelli che ci dovremmo attendere al termine della terza secondaria di secondo grado. Ma se guardiamo i dati nelle regioni, troviamo risultati molto diversi e in alcuni casi preoccupanti. Infatti gli allievi fragili sono, ad esempio, il 19,8% in Campania, 18,7% in Sardegna, 18% in Calabria, 16% in Sicilia. Sono dati veramente allarmanti per la collettività, non solo per alcune regioni. E l’altro estremo della distribuzione, ossia gli allievi che terminano la scuola secondaria di secondo grado con risultati buoni o molto buoni? Questi allievi sono il 13,5% del totale a livello nazionale, ma salgono al 20% e oltre in Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Valle d’Aosta, mentre oscillano solo tra il 5% e il 6% in Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna. Le regioni che hanno quindi esiti più problematici non solo hanno molti allievi in condizioni di fragilità, ma anche pochi allievi che conseguono risultati solidi e robusti. È quindi in crisi tutta la filiera dell’inclusione, sia lungo la dimensione della fragilità sia quella dell’eccellenza. È necessario quindi prendere atto di una crisi profonda del sistema scolastico nazionale che richiede una riflessione adeguata sull’effettiva capacità di garantire adeguate competenze di base a tutti e a ciascuno, ma anche di favorire e sostenere la crescita degli allievi più bravi.
Misurare per intervenire su situazioni di fragilità
Si potrebbe però argomentare che questi risultati non sono una novità e che non servono misure ripetute tutti gli anni per verificare ciò che già sappiamo. Ma è proprio così? L’argomentazione potrebbe sembrare convincente. Perché ripetere una misura che più o meno dice sempre la stessa cosa? Perché misurare se poi non si interviene? Ma se vogliamo fare un passo avanti bisogna guardare meglio all’interno di questi quesiti e cercare di capire se non stiamo cadendo vittime di una semplificazione eccessiva e o di un’illusione di semplicità. In primo luogo non si deve mai dimenticare che la misura non è ripetuta sugli stessi studenti, ma su coorti differenti. Siamo più concreti. Gli allievi fragili erano il 9,8% nel 2021 e sono il 9,7% nel 2022. L’informazione complessiva che abbiamo non è cambiata, ma i giovani sui quali è necessario intervenire sono diversi. Se non avessimo i dati INVALSI sarebbe difficilissimo, se non impossibile, individuare delle politiche a loro favore, semplicemente perché non sapremmo chi sono. Ma alcuni sostengono che la valutazione è una competenza esclusiva della scuola. Come non essere d’accordo? Ma la misurazione, con i suoi pregi e suoi limiti, ha bisogno di prove standardizzate, altrimenti non sapremmo a chi rivolgere le azioni di miglioramento. Tanto per essere chiari, se usassimo i voti di scuola, nessuna delle regioni con risultati molto fragili sarebbe destinataria di risorse per il supporto, anzi queste dovrebbero andare tutte alle regioni del Nord dove i risultati dell’esame di Stato sono mediamente più bassi. È questo il risultato che si desidera? Pensiamo cosa sarebbe accaduto se tutte le risorse del PNRR contro la dispersione fossero andate alle regioni del Centro-Nord. Si sarebbe giustamente gridato allo scandalo.
I dati INVALSI hanno contribuito a destinare risorse alle regioni del Mezzogiorno e alle scuole con esiti di apprendimento più bassi
Ma veniamo alla seconda domanda, ossia perché misurare se poi non si interviene. Posto che sia stato così nel passato, ora non è più vero poiché il PNRR mette a disposizione ingenti risorse proprio per combattere la dispersione e la fragilità degli esiti scolastici. I dati standardizzati ci aiutano a individuare con criteri uniformi chi ha bisogno di maggiore aiuto, le competenze professionali della scuola permettono di cercare e trovare soluzioni adeguate. I dati INVALSI, pur nella loro parzialità, hanno contribuito a destinare le risorse finanziarie principalmente alle regioni del Mezzogiorno e alle scuole con esiti di apprendimento più bassi. Forse è giunto il momento di approfittare di un’opportunità unica e di cessare la battaglia ideologica contro uno strumento che ha consentito di destinare di più a chi ha più bisogno. È importante quindi che il sistema non perda di vista la misura di una situazione molto seria che, se non affrontata con vigore e determinazione, rischia di compromettere definitivamente la possibilità del Paese di prosperare e di competere nel contesto globale.
*Presidente Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).