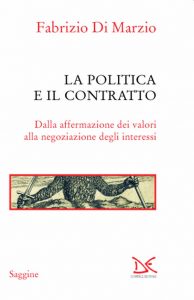Lega e M5S legati da un “contratto di Governo”. Nel saggio di Fabrizio Di Marzio, La politica e il contratto, la ricchezza, i limiti, la miseria e la nobiltà dello strumento contrattuale che oggi domina in tutti i campi.
La politica, la più nobile delle attività umane, quella che presiede l’organizzazione e la regolamentazione della convivenza civile, può essere ridotta ad un contratto? L’arte del possibile – secondo la definizione di Otto Von Bismarck – può essere espressione della mera e rigida volontà delle parti, espressa nella forma contrattuale? È a questa e ad altre domande e riflessioni che Fabrizio Di Marzio, nel suo interessante saggio dal titolo La politica e il contratto, edizione Donzelli, risponde, delineando un contesto nel quale il contratto, le sue implicazioni, la sua odierna pervasività, i suoi limiti, le sue opportunità, vengono messe in luce in modo nitido. «L’accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, che ha dato vita a una nuova maggioranza parlamentare – spiega l’Autore –, e che è di per sé un contratto di governo e non di coalizione, in quanto tende a soddisfare interessi e non a realizzare valori, ha assunto un’enfasi particolare, espressa nella scelta del nome “contratto di governo”, negoziato e sottoscritto tra le due formazioni politiche e che si ispira esplicitamente al modello contrattuale mutuato dal diritto privato». È un nuovo metodo dell’azione politica? È questo l’atto con cui nasce la Terza Repubblica?
Il percorso storico e giuridico che Di Marzio compie, si fonda sulla analisi del contratto quale origine della comunità e che dà legittimazione alla sovranità dello Stato sui cittadini. Ma la sostanziale differenza, oggi, è che, nel caso del contratto di governo siglato da Di Maio e Salvini – capi politici di M5S e Lega – l’intesa viene stabilita non con i governati ma tra i governanti, passando così dal piano istituzionale a quello della negoziazione privata di interessi. Cambia così la piattaforma iniziale: la “negoziazione di interessi” prende il posto della “rivendicazione di valori”, la quale stava alla base del discorso politico precedente. Nessun giudizio di merito da parte di Di Marzio, da esperto e studioso qual è, sui due modelli, ma la consapevolezza sì, della grande trasformazione in atto, con la definizione di nuovi àmbiti politici, con uno schema che offre ampie possibilità di manovra ma che può rivelarsi in tutta la sua rigidità. Perché, in ogni contratto che si rispetti, tutte le clausole possono essere previste, ma se il campo di applicazione è quello della politica, le sfumature, gli equivoci sui punti del programma che possono essere o meno contemplati dalla comune azione di governo, gli spunti di discussione e le tensioni, le aspettative e le reciproche pretese, possono essere occasione continua di scontro e di lacerazioni. A scanso di equivoci, Di Marzio chiarisce subito come, sul duplice presupposto della sussistenza di interessi contrapposti e della necessità di un compromesso, la categoria del contratto richiami il metodo di maggiore successo nell’organizzazione della convivenza umana.
Per i teorici del patto sociale, il “contrat social” di Rousseau è financo istitutivo della comunità politica e, quindi, va da sé che la tipologia non possa che rappresentare una grande opportunità di composizione delle dispute politico-programmatiche. Gli esempi che la storia offre, in tal senso, sono numerosi, ma non tutti privi di aspetti problematici. «Il contratto – ricorda Di Marzio – è un vincolo liberamente assunto dai contraenti, fondato su premesse reciproche e finalizzato a realizzare interessi corrispettivi: l’accordo contrattuale si fonda su promesse, sul dare qualcosa, oppure sul fare o non fare qualcosa, o, infine, sul sopportare qualcosa, e la reciprocità delle promesse è la cifra del rapporto»; senza dimenticare che «il contratto è un atto di libertà e che tale libertà è detta autonomia». L’Autore delinea il tragitto storico e culturale dello strumento contrattuale, la sua evoluzione, con richiami a Rousseau, Althusius, Hobbes, operando le dovute distinzioni tra i concetti di “intesa”, “accordo”, “patto”, “convenzione”, e la categoria contrattuale che «presuppone la libertà e l’uguaglianza dei contraenti», illustrando al lettore un aspetto di fondamentale importanza, ossia, che «l’organizzazione capitalistica e mercantile dello scambio e la progressiva declinazione in termini economici degli interessi umani, la classificazione negli accordi privati come interessi di tutto ciò che sarebbe classificabile nell’ambito dei bisogni, dei desideri, delle aspirazioni, delle emozioni, ha reso il nostro mondo il regno del contratto». Luci e ombre sulla categoria del contratto che sembra avere occupato ogni spazio della nostra vita, persino quello della politica; ma un elemento di positività Di Marzio non manca di citarlo, laddove si consideri che, «attraverso il calcolo degli interessi, a volte spietato, il contratto ci allena alla ragionevolezza, al compromesso piuttosto che allo scontro di valori non negoziabili: ecco allora che la trattativa, per il suo insopprimibile contenuto educativo, può fornire speranza anche quando offende, nell’immediato, ciò che pensavamo avesse dignità, ma cade lo stesso nel negoziato». È la dimensione dell’ascolto e del confronto che il contratto, di per sé e nonostante tutto, implica. Ecco, dunque, che la presenza – che per alcuni è sinonimo di invasione di campo del contratto nella politica – può assumere anche un significato di risoluzione ultima dei conflitti e della contrapposizione di interessi che devono di volta in volta essere negoziati. Nel caso della esperienza attuale del contratto di governo stipulato da Lega e M5S per il Governo del cambiamento, solo il tempo potrà dire se lo strumento è stato utile, in questo particolare momento storico, alla causa, ossia, al rafforzamento della democrazia, al consolidamento delle Istituzioni, e ad una maggiore partecipazione e fiducia dei cittadini-elettori nei confronti della cosa pubblica. Di Marzio offre tutti gli spunti per capire la categoria contrattuale nelle sue infinite potenzialità, disvelandone i rischi, i limiti, il cinismo, le trappole, anche perché «i contenuti del contratto li mettono i contraenti, le parti, gli uomini, e di quelli, il contratto non risponde…».
Fabrizio Di Marzio è consigliere della corte di Cassazione. Autore di numerosi lavori in materia di diritto civile e commerciale, sul tema del contratto ha pubblicato ‘I contratti d’impresa’ (Utet 2008) e ‘Contratto illecito e disciplina del mercato ( Jovene, 2011). Per i tipi della Donzelli ha pubblicato ‘Agricoltura senza caporalato’ (2017)