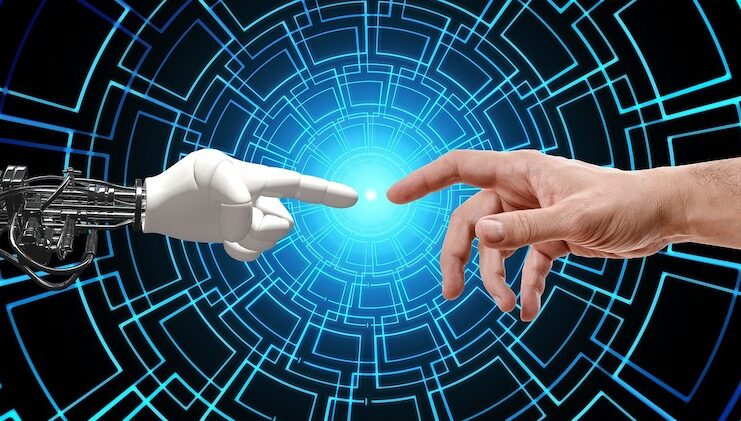Crisi e disoccupazione nel mondo del cinema. Come “la settima arte” racconta le difficoltà del lavoro, il precariato, le professioni che cambiano. Ne parliamo con Emanuele Di Nicola, giornalista professionista e critico cinematografico, autore del libro “La dissolvenza del lavoro. Crisi e disoccupazione attraverso il cinema”.
La dissolvenza del lavoro è il primo testo in Italia ad affrontare il cinema sul lavoro negli anni della crisi. Come è nata l’idea? Pensa di aver colmato una lacuna nel panorama editoriale?
Alla base di tutto c’è una questione di gusto: da sempre seguo il cinema sul lavoro e sul movimento operaio, sono cresciuto sui film di Loach e Cantet, su Riff Raff e Risorse umane. Intendiamoci: amo molti registi del cinema più immaginifico di oggi, come François Ozon, ma trovo che al nostro tempo la descrizione della realtà sia sottovalutata. Ho notato che nessuno parlava di cos’è successo nell’ultimo decennio. Come in tutte le grandi crisi la forma narrativa è stata costretta a una riscrittura radicale di sé stessa: d’altronde, la seconda guerra mondiale fu una scintilla per il neorealismo. Ora, nella crisi economica epocale, molti registi hanno ricominciato a parlare di lavoro proprio quando è venuto a mancare. È stato un passo obbligato: all’improvviso l’Occidente si è ritrovato disoccupato, i cineasti dediti alla messinscena del reale lo hanno riversato nelle loro storie. In dieci anni di crisi è tornato il cinema sul lavoro. Non c’era alcun testo italiano su questo e allora ho provato a tematizzarlo, in tempo reale, mentre le cose sono ancora in corso. Non sta a me dire se ho colmato una lacuna, mi limito a fantasticare su un lettore curioso che vede i film citati.
Il libro si concentra sul periodo 2008-2018, dall’inizio della crisi al decennio successivo. In che misura la congiuntura economica che tanto ha influito sul mercato del lavoro ha trovato espressione sul grande schermo?
Se ci limitiamo al numero dei titoli, nel decennio sono usciti circa 500 film che affrontano la crisi economica in modo più o meno diretto. Tra questi, 50 sono i più significativi che tratto nel libro. In termini generali non sono molti. Ma, se guardiamo all’esito, tante opere si sono imposte e resteranno nel tempo: basti pensare al dittico di Stéphane Brizé, La legge del mercato e In guerra, totalmente dedicato alla condizione del lavoro oggi. Poi vanno considerati tutti quei film in cui il lavoro e la crisi entrano in modo trasversale, indiretto o metaforico; in tal senso abbiamo una vera e propria gemmazione di opere. Non a caso un capitolo è dedicato al lavoro sotto forma di metafora. Pensate a Ricky proprio di Ozon: la storia di un bambino che nasce con le ali e, attenzione, è il figlio di due operai chimici. Vedete? C’è traccia di lavoro ovunque.
Il cinema, prima della crisi, raccontava il mondo del lavoro o sembrava un po’ distratto rispetto all’argomento?
Dipende. Alcuni registi hanno sempre rappresentato il lavoro come stella polare del loro cinema. Ken Loach ha seguito proprio le evoluzioni storiche e sociali del lavoro, come dimostra In questo mondo libero… del 2007, il racconto di una ragazza che apre un’agenzia di lavoro interinale. Un film esattamente in tempo. Molti altri sguardi si sono risvegliati con l’arrivo della crisi, e soprattutto con le sue conseguenze concrete che non potevano essere ignorate. In generale, se dovessi scegliere tra attenzione e distrazione, direi che il cinema è stato distratto. La crisi ha suonato la campanella.
Quali sono i principali approcci e prospettive dai quali l’argomento è stato affrontato al cinema?
Gli approcci sono moltissimi e diversi tra loro. È proprio questo un senso del libro: non anticipo troppo, ma i registi hanno trattato il tema con un ampio ventaglio di stili possibili, anche radicalmente differenti e in antitesi. C’è l’ottimista e c’è il pessimista, il tragico e il comico, lo sguardo visionario e la ricerca di un nuovo “neorealismo”. La parte più interessante è proprio passeggiare tra i film e metterli a confronto, tra lacrima e risata, tra pugni e lieto fine.
Sulla scorta della disamina portata avanti nel testo, ritiene che la crisi occupazionale sia stata descritta in tutte le sue sfaccettature o tralasciandone aspetti essenziali? In modo realistico o edulcorato da esigenze “di intrattenimento”?
Questo è un punto importante. Per me non c’è differenza tra realismo o esigenze di intrattenimento nella riuscita di un film: per esempio, Il diavolo veste Prada descrive le donne al lavoro secondo la commedia hollywoodiana, eppure la sua forza arriva e proprio perché è un film commerciale ha raggiunto un pubblico più ampio. In Italia un risultato simile lo ha ottenuto Smetto quando voglio sul problema dei ricercatori precari. Allora, ben venga il cosiddetto “intrattenimento”: non è affatto una diminuzione, al contrario allarga la platea degli occhi disponibili. Poi, per vedere un “vero” corteo di licenziati, c’è sempre In guerra di Brizé.
Mettendo a confronto cinema italiano e cinema straniero, in che modo, a suo avviso, si differenziano nell’affrontare la crisi del lavoro di questi anni?
Ci sono varie differenze. Il cinema italiano continua a riferirsi ai generi che sono nelle vene della sua storia, come la commedia. A volte dovrebbe liberarsene e provare un altro sguardo. Comunque, le diversità tra l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti sono spesso illuminanti e non anticipo troppo: nel libro c’è un paragone tra due lavoratori maturi, un italiano e un americano, l’italiano vuole disperatamente andare in pensione mentre l’americano chiede di continuare a lavorare. Sono storie, certo, ma partono sempre da un brandello di realtà.
Nel suo libro si osserva come il tema del precariato nel lavoro sia un’esclusiva del cinema italiano.
Vero. In Italia è fiorito un vero e proprio sottogenere che, scherzando, chiamo il “precario movie”. Nei film inglesi o francesi troviamo personaggi disoccupati e poveri, ma solo in quelli italiani ci sono i precari. Qui, davvero, l’elaborazione narrativa della realtà è lucidissima e si rivela sintomatica: solo nel mercato del lavoro italiano abbiamo così tanti contratti precari, nati molto prima della crisi, i registi dovevano ignorarlo? Il precario è diventato un personaggio. C’è un film, L’intrepido di Gianni Amelio, dove il protagonista cambia lavoro ogni due ore. Non serve aggiungere altro.
La copertina è dedicata a Marion Cotillard in “Due giorni, una notte” dei fratelli Dardenne. Perché ha voluto dedicare la copertina ad una donna che rischia di perdere il lavoro?
Prima di tutto è un atto d’amore. Due giorni, una notte è uno dei film più grandi sul contemporaneo, sul lavoro e sul dubbio etico, su che cosa siamo disposti a sopportare e a che cosa possiamo rinunciare, quindi, sul nostro stare al mondo. È un film interrogativo, che fa domande più che dare risposte. Poi la protagonista è una donna, fascia debole tra i deboli, la categoria più maltrattata e umiliata nel mercato del lavoro. Ma, grazie al magistero dei Dardenne, tira fuori una forza morale straordinaria e disegna un finale di dolce utopia. Non a caso Marion Cotillard in copertina è in bianco e nero, ma c’è anche un tocco di colore: vogliamo suggerire la sofferenza e, insieme, la possibilità di farcela, l’opportunità di spezzare il cerchio. Infine Due giorni, una notte mi ricorda un mio cult personale: Sabato sera, domenica mattina di Karel Reisz del 1960, che inscena il weekend di un operaio di Nottingham, interpretato da Albert Finney appena scomparso. Alla fine il suo personaggio dice: «Questo non è l’ultimo sasso che tiro». Ecco, il cinema ha tirato un altro sasso.
Per maggiori informazioni sul libro consultare il sito https://www.ediesseonline.it/prodotto/la-dissolvenza-del-lavoro/