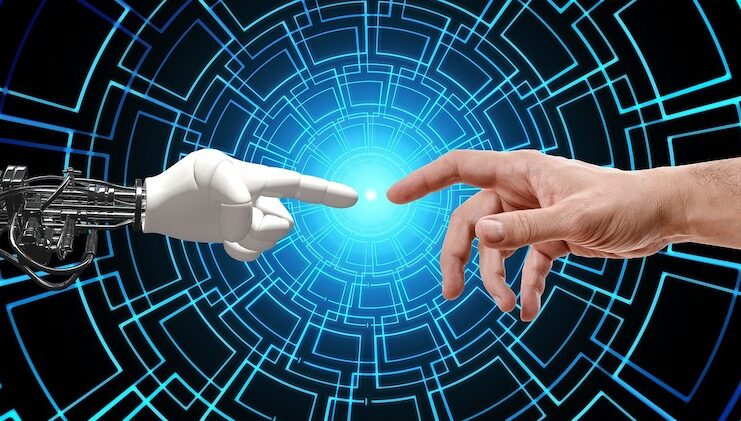Il valore economico dei dati informatici costituisce un tema che agita e agiterà sempre di più il dibattito internazionale, pubblico e privato, per le conseguenze e gli interessi che coinvolge.
Quando si parla di data value, inteso come valore economico dei dati, la maggiore difficoltà è quella di attribuire una materialità ad un concetto che rischia altrimenti di rimanere sospeso nell’etere. Al contrario, ci sono numeri impressionanti che dimostrano la dimensione del fenomeno economico che si nasconde dietro di esso e che spiegano perché ogni produttore di dati – il consumatore – dovrebbe seguire con attenzione civica il loro percorso economico.
Uno studio pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale ha evidenziato come non esista, nel mondo della digital economy, nulla di veramente gratuito. Le piattaforme on line offrono beni e servizi apparentemente gratis, in cambio dei dati dei consumatori, che vengono trasformati in modo da renderli monetizzabili.
Da un lato, i dati costituiscono un valore aggiunto per le potenzialità che offrono a chi li elabora, rispetto alla conoscenza delle preferenze del proprio pubblico di riferimento.
Secondo le ultime stime del SCB, la rivista del Bureau of Economic Analysis, negli Stati Uniti la digital economy costituiva nel 2017 il 6,9% del Pil, corrispondente a 1.351,3 miliardi di dollari, ed è attualmente il settore che contribuisce maggiormente alla crescita del paese.
È indubbio che i dati posseggano un valore e che questo, a livello aggregato, sia potenzialmente immenso. Tuttavia, la difficoltà risiede nel misurare ex ante il valore di un dato: da un lato, non si tratta di beni tangibili che sono sottoposti ad una usura misurabile; dall’altro, l’attribuzione di valore dipende molto dall’utilizzo che ne viene fatto.
Secondo James E. Short, dell’Università di San Diego, e Steve Todd, di Dell EMC, si può definire il data value come l’insieme di tre fonti di valore economico: il valore dell’asset strategico o valore di mercato; il valore derivante dall’attività che interessa il dato; il potenziale valore o valore futuro atteso del dato.
Il valore dei dati negli ordinamenti occidentali
In Europa, la consapevolezza di dover ideare una strategia di gestione della distribuzione economica derivante dai dati si è consolidata dopo uno studio promosso nel 2017 dalla Commissione Europea al fine di individuarne le dimensioni. Si era stimato, infatti, che il valore totale derivante dalla “data economy” nell’Unione europea sarebbe cresciuto dai 285 miliardi di euro nel 2015 fino ai 739 miliardi nel 2020.
La questione che si è posta riguarda l’attribuzione della proprietà ai dati prodotti. Questa è rilevante nella misura in cui dalla produzione dei dati, spesso, può derivare un trasferimento di ricchezza che favorisce gli Stati in cui si trovano le aziende che immagazzinano quegli stessi dati.
Il primo tentativo europeo di garantire una proprietà esclusiva sui dati si è avuto nel 1996 con la cosiddetta “Database Directive”, volta a tutelare per un periodo limitato – 15 anni – i diritti intellettuali sia su database contenenti dati originali, sia quelli contenenti dati non originali. In quest’ultimo caso la protezione, ex art. 7 della Direttiva, interviene se «il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo». Nonostante lo sforzo legislativo, apprezzabile per l’epoca, un successivo intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea – con la sentenza The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd, nel 2004 – ha limitato la portata del testo normativo rispetto all’evoluzione a cui è andato incontro l’utilizzo dei dati. Infatti, l’approccio interpretativo della Corte ha dato risalto alle operazioni di organizzazione ed elaborazione dei dati, svolte per creare un database, escludendo dalla tutela della Direttiva l’investimento effettuato nella fase di mera raccolta degli stessi, attività che oggi invece riveste un ruolo centrale sia in termini di investimento che di ritorno economico.
In effetti, non stupisce affatto che vi sia una difficoltà ordinamentale nei confronti della gestione di questo tema. Infatti, lo sviluppo delle tecnologie che permettono di archiviare ed elaborare enormi quantità di dati è avvenuto ad una velocità di molto superiore alla capacità di adeguamento legislativo, sia nazionale sia sovranazionale. Anche il GDPR – il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali – che ha segnato enormi passi avanti nella protezione dei dati degli individui, non tratta direttamente il concetto di proprietà del dato, da un punto di vista dello sfruttamento economico, in capo all’interessato del trattamento.
Le dimensioni della digital economy e delle attività data driven hanno sollecitato l’intervento di Stati e organizzazioni sovranazionali ed internazionali, che hanno dovuto affrontare il tema della tutela del valore economico dei dati, lasciando tuttavia insolute le questioni riguardanti la proprietà e l’accesso ai medesimi. Inoltre, alla velocità del progresso tecnologico e dell’utilizzo sempre maggiore dei big data, non sempre è corrisposto un adeguamento altrettanto rapido ed efficace da parte degli ordinamenti, sia sul piano normativo sia su quello giurisprudenziale.
Una digital tax comune?
Il principale problema del valore economico dei dati nell’economia attuale è costituito dal trasferimento di ricchezza che in concreto si realizza a favore delle aziende che elaborano i dati e, di conseguenza, degli Stati che ne beneficiano in termini di crescita economica.
La Commissione Europea ha avviato, da diversi anni, una serie di studi ed analisi finalizzate alla creazione di un quadro normativo adeguato alla sfida che stiamo affrontando. Tale impegno è animato, da un lato, dalla volontà di intervenire per garantire una certezza normativa ed una tutela che stimolino la crescita continua dell’economia digitale; dall’altro, viene frenato dal timore che un’implementazione di regole inefficienti possa rallentare o addirittura deprimere l’accesso ai dati e il conseguente sviluppo economico. La convinzione che si è diffusa ravvisa la possibile soluzione al problema nell’ambito di una digital tax.
Infatti, sarebbe estremamente problematico riuscire, volta per volta, a quantificare il valore dei singoli dati prodotti dagli utenti; al contrario, ciò che è più facilmente misurabile a posteriori sono i redditi prodotti all’esito dell’elaborazione e dello sfruttamento economico dei dati, così come sono misurabili ed individuabili gli utenti che hanno contribuito alla loro produzione, insieme alla loro provenienza geografica.
Su questo punto si è registrata, all’inizio del 2020, l’apertura da parte degli Stati Uniti ad un accordo internazionale che possa portare all’elaborazione di una digital tax ampiamente condivisa nelle modalità di applicazione a livello globale.
Questa apertura ha portato recentemente alla pubblicazione di un documento condiviso in seno all’OECD, supportato dai Ministri dell’Economia dei Paesi del G20, con cui è stata proposta una digital tax costruita su tre differenti livelli e che consentirebbe agli Stati di sottoporre a tassazione profitti che attualmente possono sfuggirvi.
Una digital tax, inoltre, è allo studio presso la Commissione Europea, che ha elaborato fin qui due possibili proposte. La prima ipotesi era un’imposta del 3% sui ricavi lordi ottenuti da attività in cui fosse l’utente a dare il maggior contributo nella creazione di valore. La seconda ipotesi era invece basata su una significativa presenza digitale, calcolata sulla base di ricavi eccedenti i 7 milioni di euro, utenti superiori a 100.000 o sulla sottoscrizione di oltre 3.000 contratti di servizi digitali, in un singolo Stato dell’Unione.
Nel frattempo, la difficoltà nel raggiungere una decisione nel complesso processo legislativo dell’Unione europea ha aperto la strada ad uno scenario in cui alcuni Stati membri hanno scelto di intraprendere iniziative singole sul tema. Tra questi, troviamo il Regno Unito, la Francia, l’Italia, l’Austria e l’Ungheria.
Nel nostro Paese, l’introduzione della digital services tax è avvenuta a gennaio del 2020 e la sua applicazione è basata sui parametri della prima proposta della Commissione Europea, ma con delle soglie di applicazione di 5,5 milioni di euro di ricavi su base nazionale o di 750 milioni di euro su base globale. Le previsioni di gettito erano di circa 708 milioni di euro l’anno in più, al momento dell’entrata in vigore.
L’obiettivo di una digital tax dovrebbe essere quello di restituire valore a tutti, o quasi, i dati prodotti dagli utenti. Dunque, solo uno sforzo congiunto dei governi nazionali a livello globale può garantire un efficace contrasto al fenomeno della traslazione dei profitti verso paesi ad imposizione ridotta o nulla, sfruttato da molte tech companies. Si stima che dall’elusione fiscale derivante da tali pratiche, gli Stati perdano complessivamente circa 240 miliardi di dollari di gettito fiscale annuo.
Il valore aggiunto degli open data
Una soluzione possibile per mutare l’approccio al tema potrebbe essere quella di trattare i dati come un bene pubblico.
L’emergenza Coronavirus sta dimostrando l’immenso valore dell’applicazione dei dati sia per i soggetti privati, sia per le Istituzioni. Nel corso della recente pandemia da Covid-19, ad esempio, i dati riguardanti le transazioni con carte bancarie hanno permesso un’analisi quasi in tempo reale del comportamento dei consumatori conseguente all’emergenza e ai lockdown nazionali. Affiancando tali dati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, inoltre, è possibile cercare di delineare dei modelli di predizione degli acquisti, in grado di aiutare le aziende che si occupano di vendita al dettaglio nelle loro strategie commerciali. Al tempo stesso, i medesimi dati sono in grado di aiutare le autorità nell’analisi dell’efficacia delle misure anticrisi e consentono di costruire modelli aggregati per conoscere più a fondo non solo la salute dei cittadini, ma anche l’accesso al sistema sanitario e gli schemi di comportamento e spostamento.
Avere accesso a grandi masse di dati, in grado di restituire un’immagine della società e dell’economia in tempo reale, consente anche alle Amministrazioni di prendere decisioni migliori e più velocemente.
In conclusione, è evidente come la capacità dei dati di restituire un valore aggiunto sia ai privati sia al benessere pubblico, non possa essere ritenuta una questione secondaria, ma necessiti di essere risolta al più presto con una soluzione condivisa che, da un lato, compensi anche indirettamente i produttori dei dati grezzi e, dall’altro, non comporti una limitazione per il settore economico che maggiormente contribuisce alla crescita economica e allo sviluppo tecnologico a livello mondiale.
Il presente articolo è una sintesi divulgativa del Report dell’Osservatorio Cybersecurity Eurispes “Il valore dei dati: una ricchezza da governare – tra privatizzazione e interesse pubblico”, disponibile al link https://eurispes.eu/news/eurispes-osservatorio-cybersecurity-il-valore-dei-dati-una-ricchezza-da-governare/.