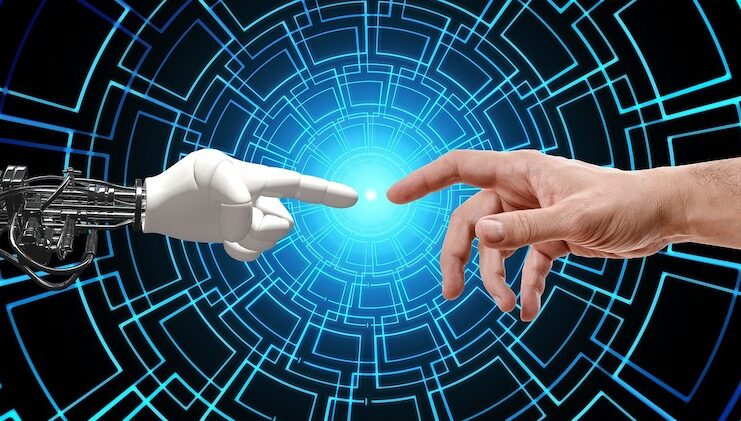Economia, clima, popolazione, consumi, tecnologia. Ci avete fatto caso? Da quando esiste Internet siamo letteralmente inondati da un profluvio di Rapporti di ricerca. Non passa praticamente giorno senza che, aprendo la posta, non si incappi in una mail che ci presenta (o rimanda a) qualche nuova, “strabiliante”, lettura della realtà: non c’è praticamente ambito di vita non scandagliato dall’occhio di qualche analista. La cosa curiosa è che tutto ciò è messo a disposizione, quasi sempre gratuitamente, sulla Rete, da think tank, centri di ricerca, banche, società di consulenza, enti governativi, imprese, ONG, centri studi.
Viene da chiedersi perché si prendano tanto disturbo; perché questi soggetti mettano al lavoro delle persone, anche competenti – e perciò ben pagate – per poi regalare a chiunque la conoscenza da loro generata.
A questo primo fenomeno se ne lega, poi, un secondo, più silenzioso: alludiamo alla chiave di lettura “economicista” che viene seguita nel commentare pressoché ogni accadimento, indipendentemente dalla sua natura. Per dire di un film importante se ne citano gli incassi; i disastri climatici si misurano con il metro dell’entità del danno monetario prodotto; i risultati sportivi di un team di calcio sono valutati in ragione dell’introito aggiuntivo che ne deriverà per le casse societarie (e, in questo caso, non si capisce di che abbiano a gioire i tifosi).
Sovrapponendo questi due aspetti della nostra contemporaneità, globalizzata e tecnologica, si scorge, allora, la presenza di un territorio particolare, inesistente in epoca pre-Internettiana. É uno spazio di conoscenza accessibile a tutti, disegnato e popolato da una incessante marea di dati, informazioni, elaborazioni, grafici e tabelle, prodotti e offerti dai soggetti sopra richiamati. Che senso ha questo spazio? Cosa significa?
Probabilmente la risposta è molto articolata ma si può provare ad illuminarne un pezzo, prendendo come caso di analisi un Rapporto recentemente pubblicato dalla Banca Mondiale: “The Safe Food Imperative” – “L’imperativo del cibo sicuro”. È un rapporto breve, di agevole lettura, con una estetica scientifica ben curata e firmato da un organismo istituzionale, perciò supposto autorevole.
Si tratta di una lettura che mette a fuoco i danni generati da cattive pratiche di gestione della filiera agroalimentare. Il tema è tutt’altro che marginale e anche il nostro Istituto se ne occupa, in particolare con l’Osservatorio Cibi, Produzioni e Territori. Il Ministero della Salute italiano conferma la centralità dell’argomento sul proprio sito, avvisando che l’alimentazione è causa primaria di molte patologie, fra le quali: alcune forme di tumori, obesità, ipertensione arteriosa, diabete, patologie cardiocircolatorie.
Bene, dunque, tema giusto e rilevante: ma cosa c’entra la Banca Mondiale con tutto questo? Utile ricordare cosa sia la Banca Mondiale. Si tratta di una organizzazione fondata nel secondo dopoguerra, appartenente alla galassia-Nazioni Unite, il cui fine precipuo è quello di creare le condizioni affinché i paesi possano abbandonare il perimetro del sottosviluppo economico: lotta alla povertà e sostegno ai paesi in difficoltà. Ha sede negli Stati Uniti, precisamente a Washington e, dopo esser stato uno dei bracci operativi della ricostruzione post-bellica dell’Europa, ora lavora a beneficio dell’intero pianeta.
Il Rapporto fissa un dato di realtà: «ogni giorno il cibo non sicuro fa ammalare oltre due milioni di persone, tenendole lontane dal lavoro, dalla scuola, fino a innescare drammatici processi degenerativi che possono portare addirittura alla morte». Naturalmente questo problema non è distribuito omogeneamente nel pianeta ma ne affligge con particolare intensità una specifica porzione: laddove risiede il 41% della popolazione mondiale – ovvero nel Sud-Est Asiatico e nell’Asia meridionale, nonché nell’Africa Sub-Sahariana – si concentrano il 53% delle malattie da cattiva alimentazione e addirittura il 75% dei decessi. Quali le cause? Facile: il cattivo funzionamento della catena che conduce il cibo dai campi alle tavole. Quanto costa? Una bazzecola: oltre 110 miliardi di dollari l’anno, fra perdita di produttività (95) e spese mediche (15). Il Rapporto spiega, con pregevole sintesi, come il problema delle patologie legate all’alimentazione sia direttamente connesso agli obiettivi del Millennio fissati dalle Nazioni Unite, in che modo affligga il consumatore, l’impresa, l’industria, il settore alimentare e, infine, l’economia tutta.
Le pagine si scorrono rapidamente, si legge e capisce senza difficoltà ma quella domandina rimane sempre lì: perché la Banca Mondiale scrive un Rapporto su questo argomento?
La risposta non tarda a venire; il mistero è svelato dalla pagina venti in poi: cari Paesi con livelli di reddito medio-bassi – quelli con la maggior incidenza del problema – ecco cosa dovete fare. Anzi, tanto per non lasciare spazio alla vostra improvvisazione, noi della Banca Mondiale vi articoliamo i nostri consigli per organo che se ne deve occupare: ministero delle finanze – o altri ministeri economici coordinati; agenzie o altri corpi governativi incaricati di alimentazione; altri ministeri tecnici – agricoltura, salute, commercio, ambiente; camere di commercio e associazioni di categoria dell’industria alimentare; centri di ricerca e università; partner di progetti bi e multilaterali.
Tutto qui? No. Tanto per essere chiari e non lasciare spazio a interpretazioni, gli estensori del Rapporto si prendono anche la briga di dare istruzioni ai paesi circa le strategie da adottare, distinguendo i loro consigli a seconda che si tratti di paesi a struttura tradizionale, in transizione, o in modernizzazione.
Insomma, eccoci qua al punto: questi rapporti usano dati, informazioni, elaborazioni, grafici e tabelle, ma il senso del loro essere sta nella mole di consigli, indicazioni, comandamenti vari, che da tutto ciò scaturisce. Siamo di fronte, insomma, a un fenomeno di moral suasion espresso su larga scala: globale e locale, istituzionale e popolare ma, soprattutto, attuata attraverso l’unico, vero, medium di massa della nostra era: Internet. E forse, allora, un bel pezzo di risposta alla domanda che si siamo posti all’inizio sta proprio qui. Internet come habitat naturale di una nuova forma di potere, leggero, contendibile, subliminale e globale: la pressione indotta, ovvero indurre le élite, la pubblica opinione, a tirare le istituzioni per la giacca e portarle a seguire certi orientamenti.
Un tempo, penserà qualcuno, lo faceva la stampa…