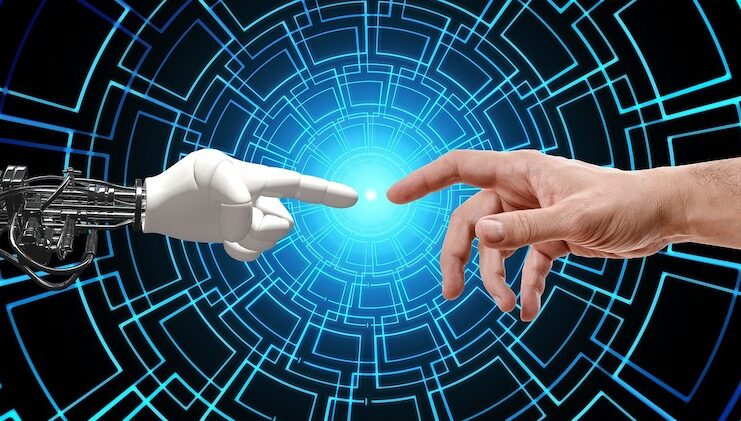Il 23 maggio 1992. L’autostrada Palermo Punta Raisi alle ore 17 e 56 viene ridotta in un colabrodo. La furia di una mafia stragista si era abbattuta contro Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti di scorta. Un teatro immenso di dolore e di paura investì la Sicilia e l’Italia. Il 1992 è l’anno del punto probabilmente più alto (seguirà infatti a luglio il tragico attentato che fu fatale a Paolo Borsellino), di una strategia assassina decisa da Cosa Nostra finalizzata a cancellare per sempre l’azione di quel pool antimafia, ideato da Giovanni Falcone, che aveva cambiato profondamente i metodi investigativi e di conseguenza la capacità di contrasto del fenomeno criminale.
Nessuno, più di Gian Carlo Caselli, Procuratore della Repubblica, attualmente presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità nel settore agroalimentare, può avere le carte in regola per ricordare la tragicità di quel momento. Oltre ad aver avuto un rapporto di profonda amicizia con Giovanni Falcone, ne ha raccolto l’eredità morale e professionale, operando dal gennaio del 1993 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo. Anni difficili per un capoluogo siciliano in cui bisognava “venire e restare” come sosteneva Padre Sorge, gesuita “in trincea”, inviato in quella Sicilia per lavorare su una rivoluzione morale che sarebbe arrivata a costo di ulteriori lutti e sofferenze.
Procuratore, proviamo a riavvolgere il filo della memoria, so che questo genera dolore, ma serve a rafforzare la coscienza collettiva. Siamo al ventisettesimo anniversario della strage di Capaci. Giovanni Falcone, se fosse stato in vita, avrebbe compiuto ottanta anni, proprio lo scorso 18 maggio. Che ricordo ha dell’uomo e del magistrato?
Non è facile evitare la retorica nel doveroso ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Provo a farlo in due modi. Innanzitutto, rievocando un episodio di importanza davvero straordinaria nella mia esperienza palermitana. Avevo deciso, dopo le stragi del ’92, di trasferirmi da Torino a Palermo, per provare a raccogliere la pesante eredità di Falcone e Borsellino (consapevole dei miei limiti, ma anche del decisivo aiuto di tanti generosi colleghi). La ritrovata unità della Procura ci consentì ‒ operando in simbiosi con le Forze di polizia ‒ di catturare un numero imponente di latitanti di grosso calibro. Fra questi, Santino Di Matteo, mafioso di Altofonte, che appena arrestato chiese di poter parlare personalmente con mé. Ci andai: mi squadrò, negò persino di avermi mai chiamato e rimase zitto. Qualche settimana dopo chiese di nuovo di incontrarmi. Ci tornai: questa volta accennò a problemi che aveva avuto in carcere. Disposi le verifiche necessarie e poi fu scena muta. «Nuttata persa e figna fimmina» (nottata persa e figlia femmina n.d.r.), per dirla con Andrea Camilleri.
Aveva fatto un vero e proprio buco nell’acqua. Come reagì?
Non mi sono arreso. Mi ripromisi che, se anche mi avesse ancora chiamato, non ci sarei più andato. Temevo infatti che volesse studiare i miei movimenti, magari per farmi “intercettare” da qualche mafioso ancora in libertà. Ma quando, per la terza volta, mi fece sapere che voleva essere sentito proprio da me, tornai da lui. Per una serie di ragioni, riuscii ad arrivare nell’ufficio della DIA di Roma, dove nel frattempo era stato portato, solo verso le due di notte del 23 ottobre 1993. Cominciò così (per concludersi intorno alle sei del mattino) un interrogatorio destinato ad assumere un posto centrale nella storia della lotta alla mafia.
È corretto dire che eravamo a una svolta?
Proprio così. Con mia grande sorpresa, infatti, Santino Di Matteo volle prima di tutto parlare della strage di Capaci, alla quale (nessuno lo sapeva) confessò di aver materialmente partecipato. In particolare, fece un racconto dettagliatissimo dell’organizzazione ed esecuzione del feroce attentato, del chilometro e mezzo di autostrada polverizzato con l’esplosivo, elencando uno dopo l’altro tutti i responsabili, precisando persino il ruolo svolto da ognuno. Enorme (si può ben comprendere) fu la soddisfazione mia e degli uomini della DIA che erano in quel momento con me: eravamo i primi – io come magistrato, loro come funzionari di polizia – a conoscere e scoprire la verità di Capaci. I mafiosi “corleonesi”, che avevano ideato e attuato lo spietato attacco frontale al cuore dello Stato, avevano per la prima volta nomi e cognomi, con attribuzione certa, a ciascuno, di precise responsabilità. Finalmente una grande vittoria per lo Stato. Per Giovanni Falcone ed i suoi compagni di sventura poteva essere fatta giustizia.
Da quel momento niente sarebbe stato più come prima?
Certamente no. Per “Cosa nostra” fu una sconfitta bruciante, l’avvio di una rovinosa catena di “pentimenti”. Una slavina che la bestialità mafiosa cercherà di fermare con una rappresaglia (di vero stampo nazista) sul figlio tredicenne di Santino Di Matteo, Giuseppe: sequestrato, tenuto prigioniero per diciotto mesi, maltrattato e torturato, alla fine ucciso (strozzato a mani nude) e sciolto nell’acido. E tutto questo “soltanto” perché figlio di suo padre, il primo “pentito” che aveva osato infrangere l’omertà che avrebbe dovuto proteggere per sempre i segreti di Capaci.
Aveva accennato a un altro modo di ricordare Falcone. A che cosa si riferiva esattamente?
L’altro modo per ricordare Falcone mi è offerto da un libro del 1999 ristampato proprio in questi giorni, intitolato La mafia ha vinto, un libro di Saverio Lodato (esperto come pochi altri di storie di mafia) che contiene il resoconto di numerosi colloqui con Tommaso Buscetta, il “pentito” che aveva consentito a Giovanni Falcone di mettere “Cosa nostra” in ginocchio. Rileggere questo studio è importante (come spiega Luigi Li Gotti, storico legale di Buscetta) perché «non è come scorrere le pagine ingiallite di una storia passata, ma, mutando i nomi e i volti, significa venire a conoscenza di ciò che i cronisti di domani potrebbero scrivere».
Entra in gioco l’uso dei pentiti. Che cosa aveva intuito Falcone che gli altri magistrati non avevano mai sperimentato?
Per capirlo bisogna rifarsi al prezioso “cristallo” rappresentato da un ritratto di Falcone, ricco di sfumature e notazioni intelligenti, che nel crogiolo, ancora oggi ribollente del racconto di Tommaso Buscetta, viene via via formandosi. Si snodano una serie di ricordi che alla fine scolpiscono – con grande forza rappresentativa ‒ quella “battaglia comune” che “l’accoppiata Falcone-Buscetta” condusse efficacemente per anni, e che avrebbe potuto segnare il definitivo affossamento di “Cosa nostra”, se l’opera di Falcone non fosse stata brutalmente interrotta, prima ancora che si scatenasse la violenza stragista dei mafiosi, dalle calunnie che gli furono scagliate addosso negli anni Ottanta.
Il famoso “terzo livello” non era dunque il frutto di fantasie complottista, ma il “nodo” reale di un legame da sciogliere tra la mafia e i poteri forti della politica?
Aveva scritto, Falcone, che: «Una delle cause principali, se non la principale, dello strapotere della mafia risiede negli inquietanti suoi rapporti col mondo della politica e con centri di potere extra-istituzionale». Sospettava persino che dietro la «perdurante inerzia nell’affrontare i problemi del pentitismo» si nascondesse la voglia di non «far luce sui troppo inquietanti misteri di matrice politico-mafiosa per evitare di rimanervi coinvolti». Anche Buscetta (osserva Lodato nella nota introduttiva alla nuova edizione del suo lavoro) aveva intuito che «la mafia sarebbe sempre esistita sino a quando lo Stato, le istituzioni, l’intera società italiana, non avessero affrontato radicalmente, e con lo scopo di reciderlo, il nesso di quest’organizzazione criminale con la politica, quanto meno con alcune cospicue parti di essa».
Intanto la mafia, dimostrando grande capacità di adattamento, ha cambiato volto e probabilmente anche il teatro geografico della sua “azione” criminosa. Che cosa risponderebbe, mentre in questa fase si parla di una nuova possibile Tangentopoli alle porte, a chi sostiene con arrogante superficialità, che la mafia non esiste più?
La morte di Falcone rimane ancora la risposta più forte che si può dare alla sua domanda. Il sacrifico del magistrato e degli uomini della sua scorta diedero allo stesso Buscetta la forza ed il coraggio per rivelare, anche all’autorità giudiziaria italiana (già prima lo aveva fatto coi magistrati Usa) fatti sconvolgenti in tema di rapporti fra mafia e politica. E allora si capisce perché sia sempre di moda il tentativo di demolire come “teoremi” le sue lucide rivelazioni. Il nesso mafia-politica è troppo ingombrante, questa è la verità. Meglio non vedere. Senza negarsi un tocco di ipocrisia, accusando magari di nefandezze assortite coloro che vogliono combattere la mafia anche sul terreno delle complicità illustri.