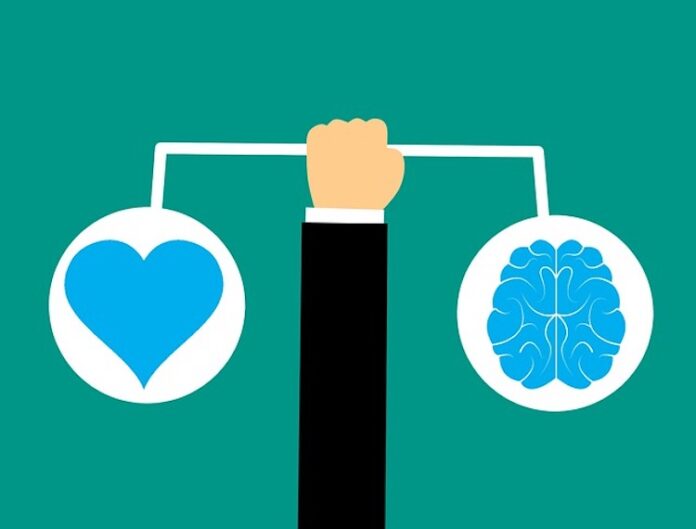“Empatia” è una delle parole più utilizzate degli ultimi anni. Il suo impiego è così frequente e diffuso che nella prassi comunicativa viene inevitabilmente esposta ad abusi che ne minano il significato più autentico. In tanti la invocano, e molti la reclamano, dando ad intendere di saperne fare un uso consapevole e corretto. Non c’è terapia comportamentale che non la contempli e non c’è test sulla personalità che non si proponga di rivelarcene e misurarne la presenza. Nella scuola italiana si usano schede valutative in cui l’empatia è considerata alla stregua di un indicatore. Eppure, se l’empatia fosse un bene facile da misurare, riprodurre e far circolare, la narrazione del quotidiano sarebbe con tutta probabilità un’altra. Se così fosse, saremmo in presenza di quella civiltà empatica che Jeremy Rifkin ha teorizzato e con tanta fiducia anche preconizzato. Lo fece poco più di dieci anni fa con un libro che, forse anche per la sua carica di positività, diventò giustamente un caso letterario. Contro la tendenza apocalittica del pensiero contemporaneo, che continua purtroppo a trovare in guerre e pandemie molti dei suoi sinistri riscontri, si era allora levata la voce di un accademico americano che dichiarava di avere visto tra le predisposizioni naturali dell’uomo la capacità di creare un mondo più solidale, ancora in grado di porre rimedio ai disastri del presente.
Che cosa vuol dire “empatia”
Se “empatia” è parola che si usa spesso con scarsa cognizione di causa, è perché se ne ignora il vero significato. Questo accade perché, come farà notare Edith Stein, l’empatia può venire confusa con atti e vissuti intensamente emotivi che le sono, comunque, affini. Non è, ad esempio, unipatia, fenomeno che si attiva quando il soggetto che empatizza non è più in grado di distinguere il proprio dal vissuto altrui che genera l’azione empatizzante. Sarebbe come se, per richiamarsi a una metafora di Theodor Lipps utilizzata dalla stessa Stein, noi osservatori, comodamente alloggiati sugli spalti di un circo, assistessimo alle peripezie di un acrobata, convinti di provare esattamente le stesse emozioni del funambolo che, sospeso nell’aria e senza una rete di protezione, rischia la vita. L’esempio potrà non piacere a tutti, ma qualcosa di simile accade quando sosteniamo di sapere esattamente che cosa provano gli altri, perché qualcosa di analogo (un lutto o qualche altro “inconveniente” della vita) è accaduto anche a noi, con la differenza che se sulle peripezie dell’acrobata potevamo esibire una discutibile competenza, ciò che invece la vita riserva anche agli altri è, per nostra disavventura, materia di cui, invece, ci riteniamo esperti. Alla vera essenza dell’empatia si sarebbe avvicinato Max Scheler, teorizzando la compresenza di più vissuti nell’esperienza empatica di chi prova il dolore o la gioia o qualsiasi stato d’animo di un’altra persona. Molto severamente, Edith Stein giudicherà errata anche questa interpretazione perché sminuirebbe il valore originario del vissuto altrui che percepiamo come nostro. Insomma, la grande lezione che ci viene elargita dalla filosofa è che se empatizzare significa sentire e provare ciò che sentono e provano gli altri, non per questo sarà possibile sostituirci a loro.
L’imperativo categorico del soggetto empatico
Sarebbe, tuttavia, un grave errore contenere il proprio slancio empatico per il timore di risultare molesti e prevaricanti. L’empatia, così vogliamo dire, è una virtù democratica che deve essere resa popolare nella giusta misura. Vuol dire che ci appartiene e che non è sbagliato considerarla come una sorta di talento innato. Secondo Daniel Goleman, teorico dell’intelligenza emotiva, l’empatia contiene le radici dei principali valori morali. Così, se sviluppiamo questa, andrà da sé che i valori stessi si faranno più solidi: «la radice dell’altruismo – scrive Goleman – sta nell’empatia, che si raggiunge con quell’educazione emotiva che consente a ciascuno di conseguire quegli atteggiamenti morali dei quali i nostri tempi hanno grande bisogno: l’autocontrollo e la compassione».[1] Più facile a dirsi che a farsi, naturalmente, perché la strada che conduce ai buoni valori etici, insegnano generazioni di filosofi e moralisti, è irta di ostacoli. Potrebbe essere d’aiuto, allora, un principio guida che ispiri le nostre azioni, una sorta di imperativo categorico per soggetti empatici in via di formazione. Una formulazione poco accomodante di questo principio potrebbe essere la seguente: “non esitare ad immedesimarti nell’altro che non potrai mai essere e cogline la presenza con tutta l’apertura di cui sei capace, mai dimenticando che il tu che non sei non potrà annullarsi nell’io che ti rappresenta”.
Educare ed educarsi all’empatia
Uno dei motivi pedagogici oggi più diffusi soprattutto nel mondo dell’istruzione è la fiducia che sia possibile educare all’empatia. Educare ed educarsi, perché, come ci ricorderebbe il nostro forse troppo cervellotico imperativo, là dove l’empatia travalica la soglia di una corretta applicazione, è facile incorrere in forme di prevaricazione. “So bene di che cosa hai bisogno”, “le tue necessità non sono poi così diverse dalle mie”, “devi solo fidarti di me e far sì che possa esserti d’aiuto”: in queste espressioni, tanto affettuose quanto di circostanza, è visibile il rischio di un indebito sconfinamento a cui si espone l’apertura empatica. Come evitare che ciò accada e che si venga traditi da quelle che sono, comunque, delle nobilissime intenzioni? Forse dovremmo fidarci di chi, come Goleman e Howard Gardner, ritiene l’emotività una forma di intelligenza, che, in quanto tale, può essere messa alla prova e alimentata.
Sentire l’altro, attivare una relazione, sarebbe, per dirla poi con Laura Boella, anche un’esperienza eccitante e, quindi, raccomandabile. C’è, innanzitutto, l’emozione dell’incontro, e «ciò che mi sconvolge, mi spaventa, mi incanta è la rivelazione della relazione tra me e l’altro»;[2] un’emozione troppo forte perché dentro di noi, in qualsiasi frangente della nostra vita, non s’inneschi un processo trasformativo. Solo chi non “vede” l’altro può ignorare quanto questo possa arricchirne e modificarne l’orizzonte esistenziale. Ma l’empatia, avverte Boella, va esercitata: «Praticare l’empatia è un esercizio fondato su una scommessa di tipo diverso. Si tratta di affinare le possibilità di relazione che nascono dalla scoperta e messa a profitto delle risposte impreviste che scavalcano i nostri desideri e obiettivi. Non è detto che l’asimmetria, il gesto senza ritorno non siano un rispondersi e corrispondersi. Da questo riconoscimento dipende la sorte di quasi tutti i rapporti umani».[3]
Empatici globalizzati
Forse è troppo immaginare l’empatia alla stregua di una risorsa salvifica, come se fosse la virtù da riscoprire e praticare disperatamente e a tutti i costi per rimettere il mondo nella giusta carreggiata. Un’umanità empatica non correggerebbe probabilmente il corso del mondo; potrebbe, semmai, comprenderlo meglio. E sarà inevitabile che accada, secondo Rifkin, perché gli uomini sono per natura biologicamente predisposti alla condivisione, e le ultime generazioni, venute al mondo in piena era digitale, lo sarebbero in misura maggiore. Non dovranno creare un altro mondo o teorizzare una nuova utopia, perché empatia e utopia sono l’una l’opposto dell’altra. L’utopia è una dimensione in cui male e sofferenza si sono estinti; l’empatia è la dimensione che incorpora morte e dolore nel tentativo di alleggerirne, tramite un atto di partecipazione emotiva, la carica di sofferenza. L’empatia si nutre naturalmente anche di stati e vissuti emozionali come la gioia, e, detto per inciso, far propria o sentire come tale la gioia altrui è solo in apparenza un’operazione più facile di quella che si può compiere costruendo un rapporto empatico in situazioni di segno opposto come la tristezza e la sofferenza. La gioia dell’Altro può essere però tanto radicale e forte quanto lo stato di disagio e infelicità in cui può sfortunatamente trovarsi chi ci sta di fronte, ma il dolore e la sofferenza, così come la gioia, sono materia di questo mondo, e l’esperienza empatica ci aiuta a tenerlo presente. Così, se Utopia è il luogo che non c’è, empatia è la dimensione del quotidiano, travagliato, ma reale. Dire che sia poco sarebbe ingiusto e poco lungimirante.
[1] D. Goleman, Intelligenza emotiva, tr. it. di I. Blum e B. Lotti, Rizzoli, Milano 2011, p. 14.
[2] L. Boella, Sentire l’altro. Conoscere e praticare l’empatia, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 28.
[3] Ivi, pp. 95-96.