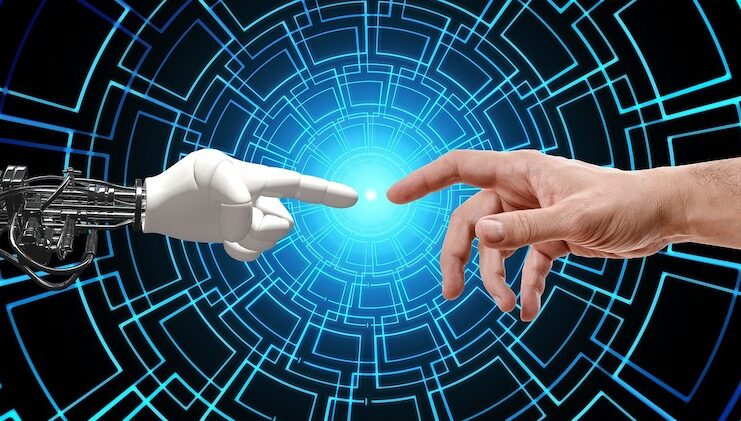Nella personale di Lorenzo Marini, “Dal silenzio alla parola”, ospitata nella splendida Piazza San Marco, antico cuore di Venezia, presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, si avverte un bisogno di andare oltre le apparenze, di spezzare il velo della finzione per andare alla struttura profonda del significato. Un’antologica di trenta opere che, oltre a un itinerario estetico, si configura come un percorso dello spirito. «Viene il momento in cui il fiume arriva al mare, decidendo di condividere idee ed esperienze», questa confluenza per Marini, art director di successo e titolare di uno studio internazionale con un’intensa attività che lo porta continuamente a viaggiare da Milano a New York, vuol dire mettere tra parentesi l’universo ridondante della pubblicità, per ritrovare l’asciutezza nella dignità del segno linguistico.
“La parola liberata”
Le tele scandiscono tappe molto precise. Il bianco è il cominciamento, l’area della privazione ma anche della purificazione, iconizzata nel “logo che soffre”, tela che apre il percorso di visita e che colpisce subito il visitatore. In questa prima parte della mostra, si compie un processo di desemantizzazione, l’artista sembra volersi emancipare dalle sovrastrutture cui il meanstream della pubblicità obbliga. È una guerra “semiotica” di liberazione, che si riallaccia al futurismo per la potenza del segno e l’amore per l’innovazione. C’è un rapporto tra materia e forma (il riferimento ad Aristotele rimane implicito ma è sicuramente molto forte e, come vedremo, non è certo l’unica citazione filosofica che i disegni sollecitano) da bilanciare, un capovolgimento di paradigma da rappresentare e da spiegare al pubblico, quel capovolgimento che ha dato forza alla Type art, filone originale di ricerca che ha portato Marini ad esporre le sue opere nelle gallerie più prestigiose in giro per il mondo. «Ho pensato di celebrare le nostre povere lettere – mi spiega nel corso di una piacevole conversazione a Monselice la sua città natale immersa nell’incanto dei Colli Euganei –, di liberarle dal perimetro stretto della pagina». Scardinare la logica classica, intrisa di quel funzionalismo che ha portato la cultura occidentale a misurare il valore semantico di ogni lettera lungo l’asse dell’unità sintagmatica, dentro l’orizzonte di una stretta cornice di regole, rimane, infatti, l’obiettivo che fa da volano all’ispirazione di un autore che pare, come Heidegger, in perenne “cammino verso il linguaggio”. È parola liberata quella professata da Marini, che non vuole annegare nella babele dell’incomunicabilità, ma che attraverso l’arte si ricarica di senso per ridare fiato al terreno della relazione, che ha bisogno di leggerezza e di profondità in questa epoca che ha visto la desertificazione della città, prevalere l’afasia del vuoto, in cui la distanza ha scandito la “sintassi” della paura.
Il progetto parte da lontano e non si è mai arrestato neanche in questi mesi di buio per il mondo. All’indomani della agognata chiusura del lockdown, Firenze, Torino, Roma e Milano hanno salutato il ritorno alla vita con l’alfabeto colorato della Type Art riprodotto su tram, mezzi pubblici e pensiline. Nel capoluogo lombardo è successo di più: l’installazione “dimmi il tuo nome” è divenuta permanete, impreziosendo la fermata “Duomo” della metropolitana. Il mega poster, realizzato con materiali d’avanguardia, si è tramutato in uno spazio aperto a disposizione di chi (sono stati e sono tantissimi) desidera lasciare la traccia della sua presenza. Il nome, ci ricorda ancora Aristotele, quale espressione unica dell’essenza, attraverso cui evochiamo l’identità. Ciascuno si riconosce nella propria lettera, come abbiamo fatto fin da piccoli quando abbiamo imparato a firmare, a volte esercitando la sintesi delle iniziali come se volessimo dire più in fretta chi siamo. La scrittura e la differenza, per dirla con Jaques Derrida, il segno sul foglio è il limen, il prima e il dopo di una storia che è la nostra storia, che trova nell’altro la possibilità di riconoscersi, quell’altro che, come ha scritto magistralmente Bertrand Badieu, è «la circostanza che ci chiama all’essere».
“La casa dell’essere”
Giungiamo così al secondo step della mostra veneziana (visitabile fino al 30 agosto) in cui la lettera diventa figura, in un trionfo della comunicazione, particolarmente godibile nell’omaggio a Venezia, tela in cui dominano i colori dell’oro di una città fulcro di potere, motore di ricchezza, terra di scambio, ma anche teatro di fatti negativi, vittima di pestilenze, invasioni e carestie, eventi che hanno forgiato il carattere forte degli abitanti della laguna.
Vale la pena soffermarsi sulla gonna svolazzante di Marilyn di “quando la moglie è in vacanza” soggetto di uno dei quadri, è l’icona dell’instabilità che crea, del divenire eracliteo che va oltre la convenzione per conquistare territori di appartenenza ancora inesplorati. Lettere fluenti dunque, lettere nascoste, incarnate, simboliche, perché «dietro ogni lettera – precisa l’autore – c’è sempre un’idea che noi incarniamo». Questo “passaggio platonico” è un ulteriore fil rouge che attraversa le opere. Inutile cercare risposte definitive: la vita è un libro (raffigurato in una delle opere più belle) da scrivere, le idee sono già nell’iperuranio, cartesianamente chiare e distinte, perché sono esse stesse dei pezzi di realtà, che ogni individuo riporta alla luce, incarnando il mito di Er, che prefigura (come narra il filosofo ne La repubblica) ad ogni anima il suo destino.
Nell’“alfa cube”, installazione che chiude il percorso espositivo, «siamo dentro una parola crociata che non ha inizio né fine, dentro il tempo circolare del mito, dentro il linguaggio come “casa dell’essere”, dove si realizza l’uno tutto parmenideo». Bisogna entrare nel cubo, immergersi per superare il silenzio della notte, che è poi quel nihil negativum che ci ha assorbito, quel virus che ha fiaccato il nostro corpo e svuotato la mente. Ritessere con umiltà la trama della parola che comunica, il messaggio della mostra ha anche un valore terapeutico, perché ci ricorda, come ha fatto molto bene Bernard-Henry Levy in un pamphlet che farà discutere (Il virus che rende folli) che la “vita è altrove. È l’amore dell’altro. L’amore tout cour. Il pensiero libero che ha la forza di cambiare il mondo.