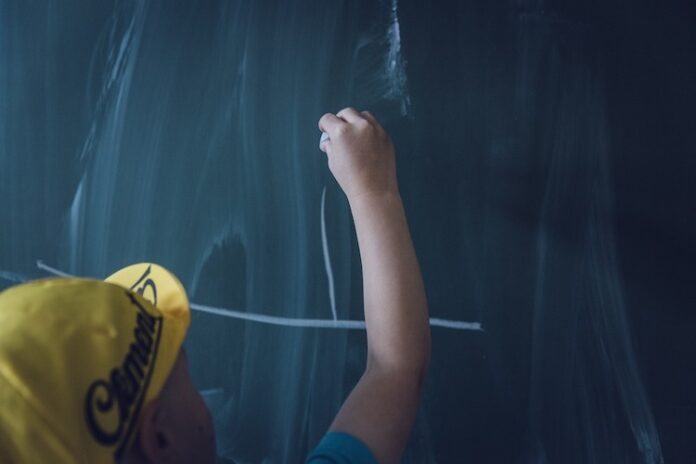È difficile trovare un settore come quello della scuola in cui si sia cimentata con così tanta insistenza la verve riformistica dei politici italiani. Del gran numero di riforme o di progetti di cambiamento di cui, insieme agli studenti, sarebbero dovuti diventare i diretti destinatari si lamentano spesso gli insegnanti, le cui voci, a seconda di chi le intende e recepisce, piaccia o non piaccia, sono un po’ come la cartina tornasole del sistema dell’istruzione nel nostro Paese. Ciò di cui in generale si lamentano è una gamma di motivi che chiamano in causa la presunta inefficacia delle riforme o il ritardo con il quale se ne tenta l’applicazione, ma anche l’inadeguatezza, e cioè l’incapacità di avviare un reale processo di cambiamento, oltre a una presunta astrattezza che non terrebbe conto delle vere urgenze e dei problemi concreti del mondo dell’istruzione. Non c’è discorso istituzionale a loro rivolto che non ricordi ogni volta che la scuola è una priorità. Al di là della solennità di certi pronunciamenti, ci si potrebbe chiedere se lo sia davvero per tutti e per le stesse ragioni, e cioè se esista una visione comune di quello che dovrebbe essere il sistema dell’istruzione nel nostro Paese. È vero o non è vero che negli ultimi vent’anni sono stati sistematicamente smontati progetti di riforma della scuola sopravvissuti solo pochi giorni alla caduta delle forze di governo che li avevano partoriti? E se questo è vero (come confutarlo, d’altronde?), quale immagine dell’urgenza e serietà dei problemi della scuola sarà stata rappresentata agli occhi dell’italiano medio? Quale contezza reale si ha del fatto che dalla qualità dell’istruzione dipenda il futuro di un Paese? Un vero patto tra generazioni – tale riteniamo essere l’effetto di qualsiasi misura politica capace di andare oltre la contingenza del presente – potrà mai prescindere da un investimento di futuro e progettualità sulla scuola? Ovviamente, no.
Negli ultimi vent’anni sono stati sistematicamente smontati progetti di riforma della scuola alla fine di ogni governo
Quando si parla di scuola e si ha l’impressione di essersi lasciati alle spalle opere incompiute o forse troppo rapidamente accantonate, uno sguardo al passato può essere sempre salutare. Servirebbe, ad esempio, a ricordare come, iniziando con la legge Coppino del 1877, a poco più di 15 anni di distanza dal compimento dell’Unità nazionale, il processo di costruzione di un nuovo sistema scolastico avesse individuato nel prolungamento dell’età dell’obbligo uno dei temi sui quali la classe politica al governo si sarebbe poi sistematicamente confrontata, introducendo anche una disciplina, una sorta di prima versione della futura educazione civica, a cui assegnare il compito di costruire in un senso sempre più laico la coscienza nazionale delle nuove generazioni, quelle stesse che, nella realtà dei fatti, avrebbero dovuto farsi carico dell’eredità del Risorgimento. Più precisamente, l’articolo 2 della legge prevedeva che si dovessero impartire sin dall’inizio dell’esperienza scolastica le “prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino”. Una formula che, mutata nella dicitura e integrata con il dovuto rispetto che si deve alla dimensione dei diritti, costituisce ancora oggi, tutto sommato, uno dei pilastri dell’educazione civica e dell’offerta formativa generale della scuola italiana. Dopo Coppino, e sempre sotto il segno della Sinistra storica, si determinò un ulteriore innalzamento dell’età dell’obbligo scolastico. Lo Stato s’impegnava, in sostanza, ad assumersi oneri maggiori per migliorare, se non altro in termini quantitativi, gli effetti della scolarizzazione. Durante il fascismo, prenderà poi corpo quella che si potrebbe definire la più longeva delle riforme scolastiche[1]. La ideò un filosofo, Giovanni Gentile, la cui figura di pensatore e intellettuale controversamente organico al fascismo è oggi al centro di un nuovo interesse. “Fascista” nella sostanza (si pensi solo all’impianto classista che la sorregge), definita dallo stesso Mussolini come la più fascista delle riforme, quella del 1923 diventerà negli anni una delle riforme meno gradite al regime[2]. Non c’è storico della scuola italiana che non sottolinei questa “curiosa” contraddizione.
Col processo di defascistizzazione molte cose cambieranno ma la riforma Gentile non sarà tra quelle
Caduto il regime, instaurata la Repubblica e avviato il processo di defascistizzazione, molte cose cambieranno, ma la riforma Gentile, penetrata in profondità, non sarà tra quelle. Per essere più espliciti si potrebbe ricorrere a un esempio: immaginiamo che con una frequenza quasi ciclica una serie di terremoti scuota le fondamenta di un edificio, incidendo delle crepe sui suoi muri. Questo edificio, si sarà capito, per alcuni vetusto e per altri, invece, sempre abbastanza efficiente, è la scuola italiana. Le scosse lo hanno spesso fatto vacillare, facendone temere o prevedere una caduta rovinosa. Dopo ogni scossa (non tutte però della stessa intensità, proprio come i progetti di riforma che hanno visto la luce nel secondo dopoguerra), ci si accorge, attraverso una perizia dello stato di salute dell’edificio, che l’ultimo sisma ha incredibilmente cancellato le tracce del precedente, lasciando, comunque, impressi i segni del suo passaggio. Anche l’occhio più esperto troverebbe arduo stabilire se le nuove crepe abbiano avuto un effetto per così dire risanatore o se l’ultima crepa non abbia invece reso ancor più pericolante la struttura. È muovendosi in simili contesti che, a dirla tutta, il politico potrebbe dimostrare di non avere la stoffa del bravo sismologo. Non deve perciò sorprendere più di tanto se anche oggi, e non solo perché ne ricorra il centenario, accada di fare i conti con la riforma Gentile, e non solo per storicizzarla sempre più rigorosamente all’interno di un contesto che tutti sappiamo essere molto problematico. Fare i conti con la riforma del 1923 significa valutare l’incidenza dell’onda lunga dei suoi effetti, riconoscerne innanzitutto la presenza, prendere in esame le ragioni che possono aver determinato il fallimento, più o meno parziale e più o meno doloroso, di molti tentativi di cancellarla. La coincidenza, felice, anche se non deliberatamente ricercata, tra i cento anni della riforma Gentile e la pubblicazione del nuovo Rapporto dell’Eurispes sullo stato dell’istruzione in Italia può essere un’occasione per procedere in questa direzione.
Fare i conti con la riforma del 1923 significa valutare l’incidenza dell’onda lunga dei suoi effetti
Nel primo Rapporto nazionale sulla scuola del 2003 molte delle questioni qui implicitamente richiamate avevano costituito una parte considerevole del piano di ricerca e dell’indice. Questioni senza tempo, potremmo definirle, in ragione della lunga gestazione che ne riconduce l’origine all’impianto della riforma Gentile. Questioni come la dualità del sistema dell’istruzione e della formazione professionale o il travagliato processo della ricerca scientifica costretta a muoversi tra riforme e stentata, se non mancata o assente, competitività. Ci si chiese allora se mortalità e dispersione scolastica fossero fenomeni imputabili alle caratteristiche strutturali del sistema e come eventualmente questa coincidenza potesse trovare una plausibile spiegazione nella diversa efficacia dei sistemi scolastici regionali. Rispetto a vent’anni fa, dopo l’esperienza dell’emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta, sarà più che legittimo attendersi novità e qualche soluzione in più. Pensiamo all’uso da tutti rivendicato delle nuove tecnologie e all’impatto che dovrebbero avere avuto sulla didattica. L’immagine è quella che ci riporta ai giorni difficili del Covid: decine di migliaia di insegnanti costretti a fare lezione di fronte allo schermo di un pc, su piattaforme digitali di cui in tanti ignoravano l’esistenza, e forse anche l’utilità, chiamati a produrre materiali didattici in formato elettronico da condividere con gli studenti, acquisendo in poco tempo i rudimenti di una formazione digitale diventata improvvisamente indispensabile. Il Rapporto del 2003 registrò l’ingresso delle nuove tecnologie nelle scuole italiane, ma non ancora nelle aule. Nel 2023 si contano, invece, a migliaia le aule dotate di postazioni informatiche e lavagne multimediali, e i fondi del PNRR dedicati all’istruzione si convertiranno copiosamente (questo è l’auspicio di tutti) in ambienti didattici di nuova generazione. Quanto sarà però impopolare interrogarsi sull’uso reale che ne verrà fatto? Quanto di quelle nuove tecnologie che varcheranno la soglia dell’aula scolastica si coniugherà con le modalità operative di nuove metodologie didattiche? Quale “fruttuoso” innesto sapranno produrre le buone prassi in uso nella scuola e le istanze della media literacy?
Il Rapporto Eurispes del 2003 registrò l’ingresso delle nuove tecnologie nelle scuole ma non nelle aule, oggi migliaia di aule sono dotate di postazioni informatiche
Sul tappeto ci sono però tante altre non meno urgenti questioni. Non ci dispiacerebbe chiamarle “vertenze di prospettiva”, volendo pensare che la loro soluzione sia, se non dietro l’angolo, comunque possibile. Tra le tante: lo stato dell’insegnamento delle discipline Stem; il disequilibrio tra il profilo in uscita dello studente (il cosiddetto Pecup) e le effettive esigenze del mercato del lavoro; l’inadeguatezza strutturale di una parte non trascurabile degli edifici scolastici del Paese, che potrebbe riflettere imbarazzanti difformità di ordine geografico; la già discussa efficacia dell’assimilazione delle nuove tecnologie nella didattica; la definizione di un nuovo status (ruolo, immagine, profilo professionale, valore sociale) del corpo docente, che ancora oggi, malgrado l’ultimo rinnovo contrattuale, continua a risultare tra quelli peggio remunerati del vecchio Continente; il valore reale che si riconosce alla ricerca; la mal digerita, soprattutto da parte degli insegnanti, introduzione di sistemi di valutazione come l’Invalsi che dovrebbero restituire un’immagine per così dire in presa diretta della scuola. È chiaro che l’accoglimento di qualsiasi novità necessita sempre di una quanto più estesa condivisione per esercitare tutta la sua efficacia. E a proposito di condivisioni e convergenze di vedute niente affatto scontate, quanti saranno ancora disposti a credere che la scuola è una priorità nell’agenda nazionale, se la voce del Pil relativa all’istruzione va sempre più assottigliandosi. È accaduto negli ultimi 25 anni, un lasso di tempo che ha visto ridursi dal 5,5% al 4% la spesa nazionale per la scuola. Un paradosso, visto che è tendenza comune considerare la scuola la grande priorità del Paese. Ecco perché non ci si può non dire fiduciosi sul buon uso che dovrà essere fatto dei finanziamenti del PNRR, sulla cui efficacia l’Italia si gioca una buona fetta delle sue prospettive di crescita.
La scuola è una priorità, ma negli ultimi 25 anni la spesa nazionale per la scuola è passata dal 5,5% al 4%
Per comprendere la scuola italiana e decifrare la traiettoria che sta seguendo o disegnando, non ci si potrà, infine, esimere dal compiere una comparazione tra questa e altri modelli di istruzione. Lo si è fatto per il citato Rapporto nazionale sulla scuola che Eurispes licenziò nel 2003. Oggi, dopo 20 anni dalla sua pubblicazione, riteniamo non meno urgente e opportuno un simile confronto. Lo scenario planetario in cui il giovane italiano munito di diploma o laurea deve operare è mutato e non può, certo, dirsi che si sia reso meno complesso. Sarebbe sbagliato e controproducente vedere in questa operazione nient’altro che il banale e sterile proposito di emulare realtà lontane, e per ciò stesso difficilmente attingibili, o, peggio ancora, scorgere in essa la volontà più o meno dichiarata e scoperta di sminuire la scuola italiana, che, secondo pareri diffusi, non reggerebbe il confronto con altri sistemi. Attraverso un simile confronto si potrebbero semmai portare più distintamente alla luce i punti di forza della scuola italiana, oltre, naturalmente, alle sue criticità.
L’Istruzione, d’altronde, più di qualsiasi asset, rappresenta oggi il futuro dell’Italia. Comprendere questo vorrà dire avere anche lungimiranza nel governare i processi di cambiamento già in atto nel mondo della Scuola, dell’Università e, dunque, di conseguenza negli strati più profondi della società e nelle economie che compongono la ricchezza del nostro Paese.
*Gian Maria Fara, Presidente dell’Eurispes.
[1] «Quali sono le caratteristiche principali di quella che Mussolini definiva la “più fascista delle riforme”? Era una riforma che propugnava una selezione aristocratica delle classi dirigenti nell’asse portante liceo-università. Prevedeva un notevole contenimento della scolarità elementare in scuole a breve termine e senza vie d’uscita (le complementari) o in scuole parallele (ma con una preminenza del liceo classico, unica scuola che apriva l’accesso a tutte le facoltà universitarie) alla principale istruzione secondaria (liceo scientifico, liceo femminile, istituto magistrale). Era implicito il disprezzo dell’istruzione tecnica e professionale, affidate ad altri ministeri specifici» (Francesco Susi, Scuola, società, politica, democrazia. Dalla riforma Gentile ai Decreti delegati, Armando, Roma 2012, p. 55).
[2] «Mussolini diede questa definizione per difendere la riforma Gentile, molto criticata nei primi tempi anche da parte dei fascisti» (Giorgio Candeloro, Storia dell’Italia moderna. Il fascismo e le sue guerre 1922-1939, Feltrinelli, Milano 2002, p. 197).