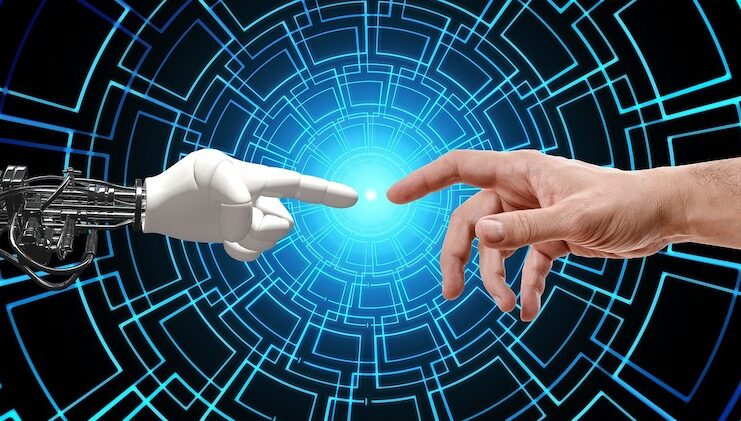Qual è la composizione ideale delle classi nelle scuole italiane? Una questione che dovrebbe prescindere, come tutte le altre connesse, dalle ragioni contingenti o dall’orientamento del Governo in carica, se davvero si convenga, come ha osservato Gian Maria Fara su questo magazine il 12 febbraio scorso, che «la scuola è una priorità che va oltre la politica». Il dibattito è ripreso dopo la polemica sulla chiusura di una scuola milanese in occasione del Ramadan (causa il gran numero di bambini di fede musulmana che di solito si assenta). Sembrava che la questione fosse conclusa con l’intervento del Presidente della Repubblica. Mattarella, senza alcun riferimento al fatto specifico, aveva espresso stima e apprezzamento per il lavoro svolto dai professori.
Nella scuola di Pioltello è stata fatta una scelta didattica e non religiosa
Invece, il ministro Salvini ha voluto precisare: «Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe. Come fa sennò una maestra a spiegare?» e il ministro Valditara ha aggiunto: «la maggioranza degli alunni deve essere italiana» ‒ enunciando il principio in un post che ha suscitato ilarità per la costruzione sintattica («gli alunni si assimileranno (…) se nelle scuole si insegni (…)»). Cos’era accaduto? A Pioltello (Milano) era stata decisa all’unanimità la chiusura dell’Istituto Iqbal Masih per il 10 aprile coincidente con la fine del Ramadan, una «scelta didattica e non religiosa», legata alla previsione di numerose assenze e all’inopportunità di svolgere il programma in aule vuote. Nell’Istituto infatti c’è una folta presenza di alunni di fede islamica. Le parole dei due ministri sono interpretabili in base al contenuto e alla tempistica. Sottendono il disappunto del Governo ed esprimono l’intento di prevenire, in futuro, situazioni di questo tipo. Riduciamo la presenza degli stranieri in classe, così quelle esigenze saranno meno rilevanti e non ci sarà motivo di adottare delibere di quel tipo. Il pensiero di fondo è che, chiudendo la scuola per tenere conto dei ragazzi musulmani, venga meno il principio di “italianità”.
La scuola è frequentata da tutti, e c’è un diritto generale alla prosecuzione delle lezioni
Ora è vero che l’episodio si sarebbe potuto concludere diversamente. La scuola è frequentata da tutti, non solo dai bambini di fede mussulmana, e c’è un diritto generale alla prosecuzione delle lezioni. Insomma, sarebbe stato più equilibrato mantenere aperta e funzionante la scuola, in quanto istituzione a servizio della collettività, pur considerando legittima l’assenza di coloro che osservano il Ramadan. Questo specifico episodio, pur accaduto nell’ambito scolastico, ha comunque rinfocolato la polemica sui fenomeni migratori. In particolare le proposte formulate, a causa del modo semplificato e della forma riduttiva, sono sembrate animate dal mero intento di restringere la presenza straniera nelle classi. Stavolta non si parla dell’immigrazione in sé, con riferimento all’ingresso nel Paese, sul quale è ben noto l’orientamento del Governo. Nel caso della chiusura delle classi, non si menziona il problema dell’arrivo degli stranieri, dei motivi che li spingono, e in definitiva del perché soggetti d’altra estrazione etnica o religiosa partecipino sempre più frequentemente alla vita del Paese. È tuttavia evidente che si avverte il medesimo senso di disappunto.
Stavolta il fenomeno migratorio emerge a proposito di persone che sono già presenti in Italia
Stavolta colpisce che il fenomeno migratorio emerga in certo senso indirettamente e a proposito di persone che sono già presenti in Italia (comunque siano arrivate), che vi lavorano da tempo e che magari, come accade spesso per i bambini che frequentano le nostre classi, sono persino nati nel nostro Paese, distinguendosi dagli altri solo perché non possono considerarsi cittadini italiani almeno sino alla maggiore età. Non è una differenza da poco. Il paradosso è che si parli drasticamente di “stranieri” a proposito di bambini e ragazzi che, pur avendo genitori di altra nazionalità, da sempre abitano qui, frequentano le nostre città, parlano perfettamente la lingua, magari con accenti dialettali, e frequentano i nostri figli. Eppure, verso di loro, si avverte diffidenza, scetticismo, avversione a motivo delle loro credenze, in contraddizione con i princìpi di uguaglianza e partecipazione tutelati dalla Costituzione.
Il paradosso è che si parli drasticamente di “stranieri” a proposito di bambini e ragazzi che frequentano le scuole italiane
A ben vedere, per orientarsi è opportuno soffermarsi sull’approccio. Parlando di popolazione scolastica e di istruzione, si possono usare molteplici categorie logiche ed argomentative, e pare imprescindibile richiamarsi innanzi tutto al grado dell’apprendimento, quale che sia la provenienza o l’identità del soggetto. Del resto, a considerare le prove Invalsi più recenti, non è raro osservare clamorose difformità generali su tutto il territorio, quanto a conoscenza degli strumenti linguistici, o delle nozioni tecniche, non riconducibili alla provenienza etnica. Invece qui il dato di partenza è la scelta di criteri descrittivi (gli stranieri, gli italiani) che chiaramente distinguono le persone in base alla discendenza, all’origine, alla nazionalità (trascurando, per esempio, che proprio le prove Invalsi evidenziano per i cosiddetti stranieri una maggiore facilità di apprendimento delle lingue). Naturalmente c’è, ed è serio, un problema didattico nella popolazione scolastica, derivante dal grado basilare di comprensione della lingua italiana, anche legato alla pratica d’uso, alle consuetudini, infine alla dimestichezza con grammatica, sintassi, lingua italiana. Sarebbe errato negare che l’uso in famiglia della lingua possa essere determinante. Ma sembra prevalere su tutto, nell’impostazione del Governo, la distinzione demografica, che poi incide sui rimedi immaginati.
La diversità non è disvalore, il concetto di integrazione implica un senso di comunità
La ricetta del ministro dell’Istruzione si riassume nella parola «assimilazione», e l’uso di questo concetto non è privo di significati e conseguenze. C’è una semplificazione riduttiva. L’assimilazione richiama le nozioni di assorbimento, acquisizione. La diversità come disvalore. Il concetto di integrazione invece, più articolato e complesso, implica il senso di una comunità, alla quale tutti partecipano. L’identità come frutto della pluralità. D’altra parte, la discussione sulle percentuali rischia di essere fuorviante. A rigore, le basse percentuali di presenze dovrebbero essere compensate in nome della praticabilità almeno con il raddoppio delle classi, altrimenti sarebbero indicazioni astratte e avrebbero l’effetto di contrarre l’istruzione rivolta a quei soggetti. Ancora una volta serve trasparenza: si tratta di chiarire quale sia lo scopo reale dei propositi, se cioè si tratti (come dovrebbe essere) di migliorare l’apprendimento dei più disagiati (tutti, a prescindere da provenienza, identità sociale, contesto territoriale) oppure di ridurre (sarebbe deleterio) la partecipazione di alcuni, scriminati per la fede religiosa e di riflesso per l’origine.
Mentre si denuncia la componente “straniera” si trascura che la scuola è la principale forma di integrazione e socializzazione
Poi, nel pronunciarsi sul tema, si omettono dati di fatto, di cui si dovrebbe tenere conto: intanto è da quindici anni che esiste una disposizione con la quale si fissa al 30% la percentuale auspicabile di studenti non madrelingua. Poi si trascura che anche questo limite è comunque di difficile applicazione nelle zone con forte presenza di migranti. In molte classi del Nord Italia, e in interi quartieri, gli “stranieri” sono in misura superiore alla metà, per non dire che ci sono anche classi interamente composte di bambini non madre lingua. Cosa facciamo? Chiudiamo le porte dopo aver raggiunto la percentuale? Il punto è che realisticamente (ed eticamente) la misura delle presenze non può essere stabilita senza considerare il numero complessivo degli studenti, e senza valutare altri fattori, come numero delle classi e degli insegnanti, ad esempio. Il rischio, con la fissazione di percentuali svincolate dal reale, è solo comprimere l’accesso all’istruzione dei cosiddetti stranieri. Non si considera appieno quanto tutto ciò sarebbe non solo contrastante con il diritto allo studio garantito dalla Costituzione, ma politicamente controproducente. Proprio mentre si denuncia la “pericolosità” della componente “straniera”, si trascura che la scuola è la principale forma di integrazione e socializzazione, un concetto fondamentale a proposito di qualunque condizione di disagio giovanile, a prescindere dalla provenienza etnica.
Misurare le presenze di alunni stranieri è controproducente e rischia di comprimerne l’accesso all’istruzione
Piuttosto andrebbe coltivato il disegno opposto di rafforzare e migliorare l’insegnamento nei confronti della parte della popolazione scolastica in affanno, e qui il discorso dovrebbe riguardare tanto gli studenti immigrati o di seconda generazione, quanto tutti gli altri, che accusano difficoltà perché provenienti da ambienti meno qualificati culturalmente. Andrebbe considerato che, a distanza di otto anni dall’introduzione, è latitante la figura dell’insegnante di italiano per stranieri, cioè quel ruolo che avrebbe dovuto colmare il divario tra alunni madrelingua e non. Basti ricordare che, nell’ultimo concorso per 44mila posti, quelli riservati a dette figure erano solo 51. Inoltre, andrebbe valutato il modo di rendere praticabile un ben diverso limite, il tetto di alunni per classe, in modo da avere un rapporto insegnante – studenti su basi numeriche accettabili. Il numero confligge con la qualità sempre, non solo quando sono presenti gli stranieri. È impensabile una didattica a misura di alunno con classi troppo numerose, e tenerne conto gioverebbe a tutti, madre lingua o meno.
Nelle scuole italiane andrebbe rafforzato l’insegnamento nei confronti della popolazione scolastica in affanno
La scuola dovrebbe essere messa in condizione di sopperire alle difficoltà degli alunni, che, dati Invalsi alla mano, per quanto riguarda i non madre-lingua arrivano al termine della scuola dell’obbligo con un ritardo grave nelle competenze di italiano, che è di uno-due anni a seconda che siano nati o meno in Italia. Soffermandosi su questi aspetti, si aprirebbe un discorso diverso e costruttivo, seppure più impegnativo e costoso. È la scuola nel suo complesso che andrebbe rimodulata nelle sue componenti di base (numero degli insegnanti, figure professionali, strutture e materiali, metodi di istruzione) perché possa garantire a tutti le condizioni di integrazione e di apprendimento.
*Angelo Perrone, è giurista e scrittore. È stato pubblico ministero e giudice. Si interessa di diritto penale, politiche per la giustizia, tematiche di democrazia liberale. È autore di pubblicazioni, monografie, articoli.