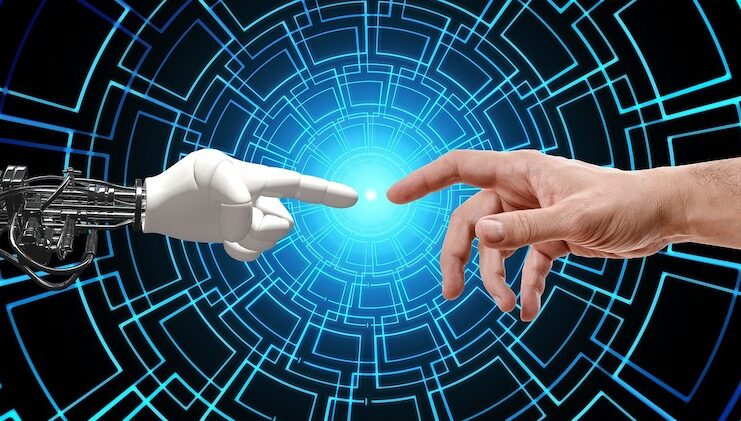La vera notizia di questa edizione degli Oscar è la vittoria, inattesa, del film sudcoreano Parasite (4 premi: miglior film, regia, sceneggiatura originale, pellicola internazionale). Per la prima volta, in novantadue edizioni, a vincere il riconoscimento più importante è un film in lingua straniera.
Una piccola rivoluzione, o meglio un’apertura faticosa che ha richiesto molti anni, per una realtà per altro conservatrice e conservativa come quella dell’Academy.
Netflix (simbolo dello streaming, a discapito del cinema in sala), al contrario, ed è la seconda notizia, continua a trovare le porte chiuse: nessuna delle 10 candidature di The Irishman di Martin Scorsese è andata a buon fine; e soltanto una delle 6 del bellissimo Storia di un matrimonio.
Irresistibile è la tentazione di ricordare errori, chiusure, vezzi dell’Academy, i cui “vizi” sono noti.
I criteri di assegnazione dei premi sono improntati alla regola del bilancino, della spartizione e, in caso di errore, della compensazione tardiva. Con la logica, affermatasi in modo più netto negli ultimi anni, della distribuzione ragionata dei riconoscimenti, per scontentare meno soggetti possibile, in molte edizioni recenti sono mancati i film pigliatutto, addirittura non si riusciva più ad individuare un vero vincitore.
Tradizionalmente, in molti casi con un premio si rimedia ad un errore, nel passato come negli anni più recenti: già negli anni Sessanta Elisabeth Taylor venne premiata per Venere in visone dopo troppe nomination in fumo, Nicole Kidman l’anno dopo il suo trionfo personale in Moulin Rouge! trascurato dall’Academy, Renee Zellweger l’edizione successiva alla sua prova di bravura in Chicago, Leonardo Di Caprio quando la sua sfortuna agli Oscar era ormai oggetto di ironia.
In modo simile, si è scelto di premiare l’ultimo capitolo della trilogia de Il signore degli anelli con il numero record di 11 Oscar come riconoscimento per una grande saga giunta al termine, dopo aver quasi snobbato i primi due capitoli – certamente di valore non inferiore.
Hollywood ama celebrare se stessa premiando le proprie icone quando diventano registi – Redford, Gibson, Costner, Eastwood; accoglie con entusiasmo tra i premiati i suoi giovani attori in rapida ascesa (Paltrow, Jolie, Lawrence, Vikander, Stone), ma non perdona alcuni personaggi che hanno sfidato l’Academy – a Mickey Rourke è stato negato un sacrosanto Oscar per The wrestler.
E sbaglia, anche clamorosamente a volte.
Hitchcock, Chaplin, Welles non hanno mai ricevuto l’Oscar come migliori registi. Kubrick, addirittura, non può vantare nessun premio per i suoi film (eccettuati gli effetti speciali di 2001: Odissea nello Spazio), ma neppure il parziale risarcimento dell’Oscar alla carriera assegnato ai suoi colleghi. Martin Scorsese ha dovuto aspettare decenni prima di ricevere Oscar tardivi, e non per le sue pellicole migliori.
Non hanno vinto come miglior film capolavori come Quarto potere, Apocalypse now, Taxi driver, C’era una volta in America, Mezzogiorno di fuoco, Blade runner e molti altri.
Dopo i mancati premi come miglior film a Pulp fiction e Bastardi senza gloria, Tarantino è stato premiato per opere successive valide ma non altrettanto perfette, un po’ come il nostro Ennio Morricone. E gli esempi sarebbero molto più numerosi.
Storicamente, inoltre, l’Academy fatica enormemente a trovare il coraggio di fare scelte nuove. I film di animazione solo raramente vengono candidati come miglior film dell’anno e, in ogni caso, anche quando presentano meriti indiscussi, non riescono a vincere – si pensi ai pochi candidati: La bella e la bestia per la prima volta nel 1992, Up, Toy story 3, capolavoro assoluto, animazione o no. Neppure i film in lingua straniera prima di questa edizione erano mai riusciti a trovare la strada verso il premio più importante e si erano dovuti accontentare di quello per la migliore pellicola in lingua straniera. Per non parlare dei film con supereroi, generalmente trascurabili, ma vittima di un evidente pregiudizio, come dimostra il torto fatto nel 2009 a Il cavaliere oscuro – e quest’anno Joker ha perso nelle categorie “nobili”: film, regia, sceneggiatura. Avengers: Endgame – valido, ma non un capolavoro, va precisato – è stato, invece, del tutto escluso nonostante i suoi incassi strepitosi, per la delusione di molti.
Se uscire dalle logiche consolidate non è mai stato facile per l’Academy, aprirsi, sia pure gradualmente, a cambiamenti sempre più radicali dell’industria e della tecnologia sembra particolarmente arduo.
Il confronto con la velocità del progresso tecnologico, ad esempio, è stato spesso spiazzante, soprattutto in sede di Oscar. Ad inizio Millennio la tecnica della motion capture, sublimata nei film de Il signore degli anelli con il personaggio di Gollum, pose la spinosa questione della premiabilità o meno dell’attore che lo interpretava. Alla fine, non se ne fece nulla. Quando esplose con forza, sia pure per una breve stagione, il 3D, i film che ne rappresentavano il simbolo non erano capolavori, Avatar in primis, ma senza dubbio spiazzarono la giuria.
Alla fine del 2019, invece, a stupire è stato l’utilizzo della nuova tecnica del ringiovanimento digitale, la Cgi (“Computer-generated imagery”), nella pellicola di Scorsese The irishman, grazie alla quale i volti di De Niro, Pacino e Pesci vengono riportati indietro di decenni. Risultato, alcune nomination (non tradotte in premi) ma anche parecchio scetticismo, destinato a crescere di fronte alle prospettive future della tecnica. Ancor più quando prenderà corpo la scelta di far rivivere artificialmente attori scomparsi come interpreti di nuove pellicole (il primo sarà, a quanto annunciato, James Dean).
Ora il problema principale si chiama Netflix e non riguarda gli effetti speciali, quanto l’affermazione crescente dello streaming e delle grandi piattaforme digitali. La capacità di budget della corazzata Netflix le ha permesso di allargare le proprie prospettive passando in un solo anno dal produrre film d’autore e d’intrattenimento con star di primo piano, a superare le più rosee aspirazioni producendo, addirittura, la nuova pellicola di Martin Scorsese.
Lo scorso anno fu impossibile non notare come a Roma di Cuaròn, targato Netflix, nonostante la nomination, venne negato il (meritato) premio per il miglior film.
Quest’anno, con un po’ di ipocrisia, tante candidature ma pochissimi premi per i film Netflix (sia agli Oscar, sia, poco prima, ai Golden Globe). Siamo, del resto, di fronte ad una svolta epocale: film con budget e firme invidiabili che, con l’escamotage di un rapido passaggio in sala, sono disponibili sui diversi device per lo streaming, minacciando in modo diretto la concezione classica del grande cinema sul grande schermo.
Quel che gli Oscar ben riescono, d’altra parte, a rappresentare, è una discreta armonia tra gusti del pubblico e riconoscimenti dell’Academy. Non esiste quel netto scollamento, oggi evidente nel nostro Paese, tra il cinema dei premi ed il cinema di successo. Generalmente i detentori del titolo di miglior film dell’anno sono anche buoni incassi al botteghino – ulteriormente lanciati dalla vittoria dell’Oscar –, talvolta veri blockbuster.
Per fare un confronto, in Italia negli anni Ottanta hanno vinto il David di Donatello Ricomincio da tre di Troisi (battendo l’altro campione di incassi candidato, Il marchese del Grillo di Monicelli), Borotalco di Verdone, Speriamo che sia femmina di Monicelli, L’ultimo imperatore di Bertolucci – tutti grandi successi al botteghino –, negli anni Novanta Mediterraneo di Salvatores, Caro diario di Moretti, La vita è bella di Benigni. Nel nuovo Millennio e negli ultimi 15 anni, in particolare, i vincitori italiani sono quasi sempre film poco noti al grande pubblico.
Per contro, i vincitori degli Oscar, anche negli anni Duemila, sono nella maggior parte dei casi film amati da vastissime platee, come Il gladiatore, Il ritorno del re, Non è un paese per vecchi, The millionaire, Il discorso del re e The artist. Il vincitore dello scorso anno, Green book, era una commedia di grande popolarità, quello del 2018, La forma dell’acqua, una favola ironica e gotica in cui una donna si innamora di un mostro acquatico. Certo non da cinema d’essai.
Resta, però, come sottolineato, il pregiudizio per i film d’animazione e per quelli riconducibili, anche impropriamente, al genere cinecomic. Nonostante ciò, negli ultimi anni è stata annunciata l’intenzione di apportare alcune modifiche al meccanismo dei premi, tra cui l’introduzione di un Oscar per il film più popolare. L’idea non si è poi concretizzata, ma rientrava nei tentativi di contenimento della grave perdita di ascolti sofferta dalla cerimonia nelle ultime edizioni, specie tra i giovani.
Un altro elemento che sta caratterizzando in modo sempre più rilevante l’appuntamento con gli Oscar sono le rivendicazioni sociali, che nei premi trovano espressione e cassa di risonanza. Le polemiche, anche clamorose, non sono mai mancate – dalle critiche esplicite ad un presidente in carica o ad un intervento bellico alla storica presa di posizione di Marlon Brando a difesa della causa degli indiani d’America –, ma oggi la cerimonia è divenuta, più che in passato, un palcoscenico privilegiato sul quale dar voce alle istanze sociali, alla sensibilità del momento, al desiderio di cambiamento. Interventi a tema e filippiche animano la nottata e trovano eco nelle ore immediatamente successive. In questi anni non soltanto la politica è stata protagonista, ma anche la rivendicazione di diritti e la denuncia di discriminazioni e abusi.
Nella storia più recente degli Oscar il movimento Me too (nato nell’ottobre del 2017 contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne, specialmente in ambito lavorativo, dopo le denunce nei confronti di Harvey Weinstein) e Time’s up (nato in difesa delle vittime di molestie sessuali), soprattutto nell’edizione 2018 post caso Weinstein, hanno trovato voce sul palco rilanciando la denuncia di tanti comportamenti scorretti e, spesso, violenti, a danno delle donne, soprattutto nel mondo dello spettacolo. Espressioni di sdegno avevano trovato posto anche in altre cerimonie ed occasioni pubbliche, ad esempio i Golden Globe, gli Oscar della stampa; nel 2018 si era diffuso l’invito alle donne celebri a vestire in nero sul red carpet dei Golden Globe, per denunciare molestie e abusi.
Più in generale, in questi anni ha tenuto banco una necessaria campagna per la parità di genere nelle case di produzione e nelle agenzie di spettacolo. Proprio nel 2018, nel suo discorso di ringraziamento come miglior attrice protagonista, Frances McDormand ha parlato del ruolo della donna e della necessità di estendere l’inclusion rider (la clausola presente in alcune produzioni che determina la presenza di una “quota” di lavoratori nel cast del film che faccia parte di una minoranza – etnica, religiosa o femminile) a tutte le produzioni.
Sempre più spesso viene lamentata la scarsa presenza femminile nelle nomination agli Oscar nelle categorie diverse da quelle dell’interprete, in particolar modo dalla regia, ma anche dalla sceneggiatura. L’unica donna che abbia ricevuto il premio come miglior regista nella storia degli Oscar è stata Kathryn Bigelow nel 2010 – un problema che nasce a monte, perché raramente alle donne vengono affidate pellicole di grande rilievo. Anche quest’anno le nomination non vedono nessun nome femminile per la regia, aspetto che non è passato inosservato. La regista israeliana Alma Har’el ha addirittura proposto di creare due categorie diverse per la regia, una per gli uomini ed una per le donne – idea in sé francamente discutibile, se non controproducente. Intanto, stanotte l’attrice Natalie Portman “indossava” i nomi delle registe meritevoli escluse quest’anno dalle candidature.
I riflettori sono puntati, i nervi scoperti. In questo clima nel 2018 è stata decisa l’esclusione dell’attore Casey Affleck dalla cerimonia in seguito all’accusa di comportamenti scorretti avanzata da due donne. Quest’anno si è giunti al punto di dover rinunciare, per il secondo anno consecutivo, ad un conduttore della serata, per timore che emergessero sue eventuali azioni discutibili oppure dichiarazioni politicamente scorrette, come accaduto con Kevin Hart; scelto lo scorso anno e poi licenziato alla scoperta di commenti omofobi da lui pubblicati dieci anni prima.
Altra questione sociale sempre più aperta è quella del rispetto e del giusto riconoscimento nei confronti dei cittadini di colore (e, più in generale, di etnia diversa da quella dominante). Quella che rimane, da sempre, una ferita aperta in special modo negli Stati Uniti, è tornata con forza al centro del dibattito politico a seguito dei clamorosi episodi di violenza nei confronti di cittadini di colore – i più gravi hanno visto l’uccisione di giovanissimi da parte della polizia in assenza di reale pericolo. La battaglia per il diritto alla vita stessa della popolazione nera ha trovato riflesso anche in una rinnovata campagna per la parità dei diritti e della rappresentanza.
Da qui lo slogan Oscars So white nel 2016, lanciato dopo che per due anni consecutivi tutti e venti gli attori candidati per la migliore interpretazione erano bianchi. Spike Lee ha per questa ragione disertato la cerimonia. Nel 2017 due vincitori su quattro per la migliore interpretazione sono stati di colore, fino all’anno successivo, quando tutto è tornato come prima; nel 2019 ci sono stati di nuovo due attori non protagonisti neri premiati, nel 2020 un’unica candidata di colore.
Le denunce sembrano avere effetto ad anni alterni, col serio rischio di una distorsione dei valori. Film soltanto discreti candidati perché portatori di un messaggio di per sé condivisibile, proteste per la mancata candidatura di film altrettanto non più che discreti in virtù della condivisibilità della loro tesi di fondo. È forte il sospetto che Moonlight sia stato scelto nel 2017 come miglior film – ai danni del favorito La La Land – al di là dei suoi meriti, proprio in quanto storia di un uomo di colore ed omosessuale maltrattato dalla vita. Un po’ come Il caso Spotlight nel 2016, arrivato, a sorpresa, al momento giusto, a denunciare i numerosi casi di pedofilia nella Chiesa cattolica ed il loro colpevole occultamento. Il film Green book fu, invece, aspramente (ed ingiustamente) criticato da alcuni perché avrebbe affrontato troppo superficialmente la questione razziale negli Stati Uniti.
Le emergenze sociali, dunque, si riverberano non di rado sulla scelta dei premi, con il risultato di sensibilizzare e far riflettere un vastissimo numero di persone, ma anche col rischio di interferire con il riconoscimento del reale valore artistico delle opere. E con il rischio di banalizzare questioni fondamentali derubricandole a mode, come quando l’attenzione nei confronti di una condizione di ingiustizia si spegne nell’arco di un anno, in attesa di un nuovo trend più spendibile mediaticamente.
Nella 92esima edizione degli Oscar svoltasi stanotte c’è stato solo un rapido accenno alla politica interna, ma non è mancata la volontà di dar voce allo spirito dei tempi. Oltre alla Portman, il vincitore come miglior attore protagonista di quest’anno, Joaquin Phoenix, nel suo discorso di ringraziamento ha sottolineato la necessità di superare tutte le forme di discriminazione ed ha denunciato il cinico sfruttamento degli animali e, in generale, dell’ambiente da parte dell’uomo.
Nel nostro piccolo, qualcosa di simile avviene ormai da anni nella manifestazione più seguita dello spettacolo italiano, il Festival di Sanremo, che ospita monologhi sulla violenza contro le donne, sull’immigrazione, sull’amore omosessuale, contro la mafia.
Il rischio, nel nostro Paese come negli Usa, è che le battaglie, se non tradotte in comportamenti, si trasformino in mode che, come tali, durano una o due stagioni senza poi lasciare traccia.
È però innegabile che qualcosa, sia pur lentamente, sta cambiando. Nel corso degli ultimi anni la composizione dell’Academy è mutata, lasciando più spazio ai giovani, alle donne ed alla diversità etnica. Quest’anno si è trovato il coraggio di premiare un film in lingua straniera, prima o poi altre barriere saranno abbattute.