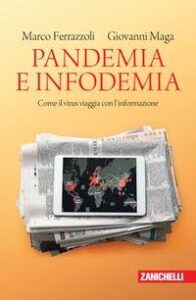Presentato ieri, giovedì 17 marzo, a Roma presso la sede centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche il libro “Pandemia, infodemia. Come il virus viaggia con l’informazione” (Zanichelli editore) del giornalista Marco Ferrazzoli e di Giovanni Maga, Direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare di Pavia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha aperto l’incontro con un video-saluto la Presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza. Le conclusioni sono state affidate alla Direttrice del Dipartimento scienze biomediche CNR, Daniela Corda e la moderazione a Mirella Taranto, Capo Ufficio Stampa dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Gli utili della vendita del volume sono stati devoluti all’AISLA – Associazione Italiana per la Sla. Proponiamo la recensione di Stefano Della Casa.
Pandemia e infodemia
La pandemia e l’infodemia, cioè l’eccesso di informazioni (più o meno fondate) che ci disorienta, continuano a monopolizzare la nostra attenzione e i mass media. Eppure non siamo al punto di partenza. Dopo due anni di eventi e cambiamenti epocali dobbiamo cominciare a riflettere più lucidamente sullo tsunami che ci ha investito così come hanno provato a fare gli autori di questo volume.
La pandemia osservata con un approccio multidisciplinare
Ferrazzoli e Maga spiegano nell’introduzione di aver seguito l’evolversi della pandemia e dell’infodemia dal principio, ognuno dal punto di vista dettato dal proprio ruolo professionale e dalla propria formazione. La pandemia infatti deve essere studiata attraverso uno sguardo di insieme, una mappa delle infinite ramificazioni cominciate dal primo contagio umano di un virus allora sconosciuto.
Il volume è diviso in quattro parti, tutte scritte a quattro mani: Scienza, Conoscenza, Comunicazione, Società. Con questa struttura gli autori ripercorrono i moltissimi temi essenziali della pandemia da Covid-19 con una prospettiva multidisciplinare. Dallo spillover alla didattica a distanza, dalle sfide della produzione dei vaccini all’effetto del virus sulle disuguaglianze sociali e internazionali, dalla sovraesposizione degli esperti alla difficilissima gestione della comunicazione istituzionale. Fino al dibattito sul complicato ma inevitabile compromesso tra libertà individuali e salute pubblica, e senza dimenticare il confronto con le tante pandemie ed epidemie del passato, che hanno lasciato una traccia permanente nella nostra cultura.
Ma perché è arrivata questa pandemia?
Qui torna utile una lezione di storia: siamo stati sfiorati dalla Sars appena 20 anni fa, e sapevamo già moltissimo su come nasce un virus pandemico. Forse, allora, non abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre questo rischio. Ma la storia ci racconta anche che in un passato un po’ più remoto abbiamo affrontato epidemie simili con atteggiamenti talvolta molto diversi da oggi. Stupisce, per esempio, leggere le prime pagine dei quotidiani che, nel secondo dopoguerra, minimizzavano l’influenza asiatica (1957-58) e quella di Hong Kong (1968-69), responsabili di decine di migliaia di vittime anche in Italia.
Forse perché al tempo molti altri rischi, inclusi quelli di morire per malattie oggi prevenibili con un vaccino, erano dati per scontati. Scrivono gli autori:
In tutto il libro il passato è un utile punto di riferimento per orientarsi, anche per non sentirsi sopraffatti da una situazione in continuo mutamento. Persino nei capolavori della letteratura mondiale le pandemie (e le infodemie ante litteram) sono ben rappresentate. E osserviamo, oltre alle differenze, anche molte similitudini con l’attualità. Le epidemie non sono mai state solo una questione sanitaria, ma eventi che mettono a nudo la natura umana e le società che colpiscono. Questo vale oggi come valeva al tempo della peste di Giustiniano o della SARS. Anche il cosiddetto complottismo o la diffusione virale di notizie false non sono certo una novità: basta pensare ai presunti untori ben descritti da Manzoni.
La crisi è sistemica
Gli autori si soffermano diffusamente su come il virus abbia cambiato la nostra lingua. Quasi da un giorno all’altro abbiamo cominciato a usare comunemente decine di vocaboli ed espressioni nuovi o con un nuovo significato. La parola che forse è più importante, però, non è ancora molto popolare: sindemia. Indica il fenomeno per cui due o più epidemie interagiscono tra loro in modo sinergico, rafforzandosi a vicenda. Questo processo è guidato, oltre che da fattori biologici, anche da fattori culturali, ambientali e politici, altrettanto o più importanti.
Quella di Covid 19 è una sindemia, perché in tutto il mondo ha dato il via a una serie di reazioni a catena che hanno, in primo luogo, peggiorato le condizioni di salute di chi già non se la passava bene. Ed ecco come un virus che sulla carta avrebbe bassa letalità (ma altissima contagiosità), ha spinto il mondo in una situazione che molti descrivono in termini bellici, esacerbando le crisi già presenti di un pianeta fiaccato dalla recessione economica e dal degrado ambientale. Del resto, è proprio la distruzione degli habitat che favorisce il contatto con nuovi patogeni. Mentre il cambiamento climatico, prima ancora di minacciare le nostre coste, sta permettendo a malattie tropicali di arrivare dove prima non era possibile.
La strada da fare è ancora moltissima, ma non bisogna cadere nel pessimismo e nella resa. Come scrivono gli autori nelle conclusioni di Pandemia e infodemia:
«Questa esperienza, non ancora conclusa, dovrebbe insomma farci ripensare il governo del mondo. Spronarci a migliorare la cooperazione internazionale attraverso organismi come UE e ONU, OMS, FAO, UNESCO, per poter affrontare uniti le emergenze planetarie. Non c’è bisogno di un’invasione di alieni, come nei film di Hollywood, per affratellare tutto il genere umano. Lo diciamo non come esortazione etica o retorica, ma nella consapevolezza che i problemi hanno ormai dimensioni globali, si tratti di economia, lavoro, migrazioni, ambiente, clima, salute. E che il tempo a disposizione è sempre meno»..
Pandemia e infodemia: come il virus viaggia con l’informazione (Zanichelli editore, collana Chiavi di lettura, 232 pp., euro 14,30).
Leggi anche https://www.leurispes.it/lopportunita-etica-della-pandemia-tecnologia-e-valore-umano-nel-post-covid/