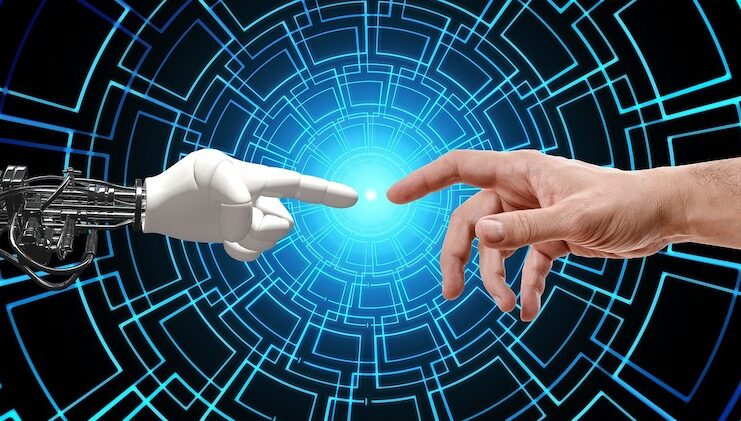«Ogni bambino, al più tardi all’età di sei anni, si chiede che cos’è la morte. È questa – ha sostenuto Gadamer – la forza enigmatica della filosofia». Con gli anni, quel bambino che immaginiamo aver varcato da poco tempo la soglia della prima classe elementare, imparerà anche a chiedersi che cosa è l’amore, se esiste la felicità, se c’è un Dio, se la Verità è possibile – oltre che raggiungibile – perché mai esiste il male e non solo il bene, e se il nostro essere al mondo ha un senso. Se lo chiedono gli adulti, soprattutto se sono filosofi, ma per farlo non è necessario essere adulti, né bambini mossi da una spiccata curiosità naturale verso le grandi e insolubili questioni della vita. È l’incanto dei perché estremi, alla cui risposta tutti, siano o meno filosofi di professione, possono contribuire. Ma la filosofia, come ben sapeva Matthew Lippman, non è una disciplina nata solo per dare risposta ai nostri perché senza facile e apparente soluzione. È un sapere, una tecnica che si fa arte e metodo utile, soprattutto (ma non solo ovviamente), per pensare quei “perché”. Intesa in questo modo, diventa un sapere e una disciplina senza età, nel senso che non ci sarebbe un particolare momento della vita – la maturità anziché la vecchiaia o la prima, sognante, adolescenza – più congeniale di altri per praticarla con la serietà che merita. Una serietà, sia chiaro, che niente ha in comune con la circospetta aura di accademismo che ancora oggi aleggia in quei luoghi della cultura dove la filosofia viene insegnata. Antiaccademica, per statuto e definizione, la filosofia non è, d’altronde, sempre capace di rivendicare questa sua originaria identità.
Può essere che si sia dimenticata la lezione di Socrate e che nessuno creda più nella bontà di quel metodo chiamato maieutica con il quale la filosofia propiziava il confronto e, riconoscendo pari dignità a tutti, incoraggiava l’audacia delle risposte? Nella storia della filosofia non vi è forse pensatore più “tradito” di Socrate, la cui esemplarità è stata esaltata oltremodo, ma raramente emulata e messa in pratica. Non è così però per Lippman e per quanti in Italia e nel mondo hanno voluto fare della filosofia un sapere da non rinchiudere e custodire in accademie, università e trattati per specialisti. Ispirandosi agli insegnamenti di Dewey, Matthew Lippman intuì che con la filosofia – intesa come pratica di ricerca fondata sul confronto e la partecipazione – sarebbe stato possibile dare un valore finalmente concreto alla presunta utilità euristica di questo sapere, rendendo meno astratta una disciplina del pensiero che è, per sua natura, intimamente legata alla vita. Proprio come insegnava Socrate, che ha sempre dato prova di intendere la filosofia come un sapere per tutti. Un sapere utile per tutti, perché la mancanza di razionalità e l’irragionevolezza diffusa, come insegnava Lippman, possono avere, alla fine, alti costi sociali. Da queste convinzioni, e dalla consapevolezza dell’utilità pratica della filosofia, sapere buono non solo per esercitare il pensiero ma anche per vivere, è nata la P4C.
È l’acronimo di Philosophy for Children (Filosofia per bambini), ma quella “C” vale anche per “Community”. Bambini, ma non solo, comunque, perché «qui, il punto di arrivo – come ha dichiarato Antonio Cosentino, uno dei padri della P4C in Italia – è quello segnato da una filosofia praticata, accessibile a chiunque». Una nuova proposta pedagogica, insomma, che parte dalla filosofia per mettersi al servizio di tutte quelle discipline che ritengono, come direbbe Edgar Morin, che una testa ben fatta sia da preferire a una bella testa e che un’educazione al pensiero non sia poi una proposta così peregrina.
Ecco, il punto è proprio questo: si può imparare a pensare perché possiamo apprendere come dirigere e svolgere più razionalmente i nostri pensieri. Immaginarsi quale prospettiva di mondo potrebbe spalancarsi davanti ai nostri occhi se solo tutti imparassimo davvero a pensare e – sarà bene precisare – a pensare meglio, sarebbe un’apertura di credito verso un futuro meno incerto e scoraggiante. Immaginarsi la P4C in azione sarebbe come visualizzare un’agorà in cui tutti si sentono chiamati a pensare e ad esprimersi, prestando ascolto e meditando attentamente sul già detto e pensato. Nelle sedute di P4C, ad esempio, si insegna ai partecipanti a pensare liberamente, e a non ripetere quanto è stato già detto da altri, perché non sempre repetita iuvant. Un bell’insegnamento che va contro certi luoghi comuni e che segna una direzione contraria rispetto a chi esercita impunemente la triste arte del riciclaggio del pensiero altrui.
La P4C non è, ovviamente, da intendere come una lezione di filosofia. Il fatto è che non è nemmeno una disciplina. È, se proprio vogliamo, una metodologia, una pratica, che può dare i suoi buoni frutti tanto in un’aula quanto in una casa per anziani o in un carcere. In Italia è sempre più praticata; non vive più solamente all’interno del classico ambiente didattico – vale a dire l’aula con il setting immaginato da Lippman –, anche se la scuola rimane il suo luogo d’elezione. Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli specialisti della formazione (soprattutto insegnanti) che hanno arricchito il loro bagaglio professionale con i corsi della P4C. La si scopre all’Università, le si dedicano riviste o rubriche in testate culturali, cresce la quantità di pubblicazioni e materiali didattici e, da più di vent’anni, opera anche una scuola internazionale, nata e attiva ad Acuto, nel Frusinate, che propone corsi di diverso livello. La dirige Antonio Cosentino, esperto e divulgatore del pensiero di Lippman e pioniere della P4C. Grazie a lui il “verbo” lippmaniano di una filosofia accessibile a tutti sta diventando realtà. Una conquista non da poco in un Paese la cui scuola contempla l’insegnamento della filosofia solo nei licei, tranne poche, quasi sperimentali, eccezioni che confermano, se ce ne fosse bisogno, la rigidità di una consuetudine dura a morire.