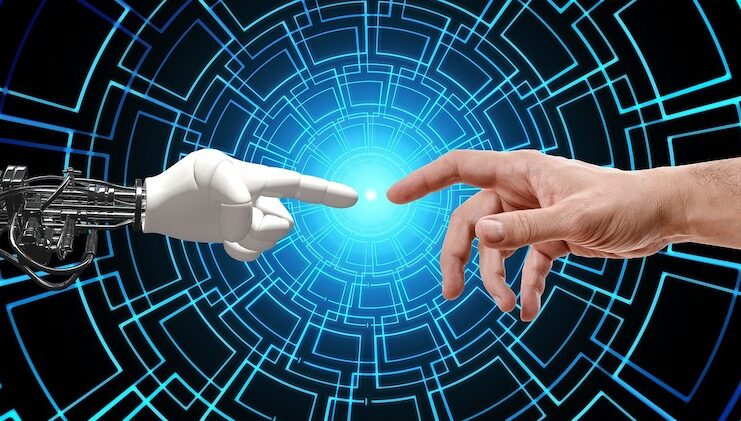Quando morì il 19 settembre del 1985, di Italo Calvino e della sua inattesa scomparsa sembrava essere già pronta da tempo una determinata impostazione commemorativa, come se, simile al personaggio di Antonio Tabucchi in Sostiene Pereira, una pletora di critici, studiosi e addolorati estimatori avesse inconsciamente concordato di celebrare la morte dello scrittore servendosi di un cliché in molti casi comune. Dell’autore delle Cosmicomiche, Palomar e tanti altri straordinari romanzi, in una sorta di mantra corale, si era deciso di ricordare soprattutto le Lezioni americane e quel tema, la leggerezza, che, a detta di tutti, anche dei meno “calviniani”, poteva essere considerato la cifra più significativa e distintiva del suo stile e uno dei maggiori e più impegnativi lasciti. In effetti, fare di Calvino il narratore e il teorico della leggerezza non è stato un azzardo e tanto meno un abbaglio, anche se oggi, a quasi quarant’anni dalla morte e cento dalla nascita, la prospettiva del distacco aiuterà a sondare meglio la portata di un’eredità difficile da esaurire.
Quale Calvino?
Nell’opera di Calvino, come sanno i critici più accorti e i lettori più acuti, si può riscontrare una varietà di stili, registri e tematiche che hanno pochi eguali nel panorama letterario mondiale. Si potrebbe dire, a torto, che ci sia un Calvino preferibile a un altro Calvino, un Calvino degli esordi, vicino alla poetica neorealistica e un Calvino architetto della parola e sperimentatore di trame e storie che ne hanno fatto scoprire e apprezzare la grande originalità. Un Calvino non sempre profeta in patria ed esaltato, invece, altrove. Un Calvino trascinato e travisato nella disputa insipidamente ideologica tra chi lo ha voluto presentare come un autore disimpegnato, quasi altezzoso, se non addirittura insensibile di fronte ai grandi temi del sociale, e chi si è fatto tentare dall’etichetta del genio incompreso, sempre utile per spiegare lo scarto tra letteratura e popolo e risolvere certe antinomie interpretative. Pensare che Italo Calvino abbia fatto della letteratura un esercizio per evadere dalla realtà sarebbe uno degli errori maggiori che si potrebbero ancora oggi assecondare e avallare. La disputa che lo contrappose a Pasolini è superata, e se la produzione narrativa non fosse sufficiente a dissipare un dubbio così ingeneroso, basterebbe prendere in mano gli scritti del Calvino critico, giornalista e saggista (quelli del “Menabò”, ad esempio), per capire che l’abbaglio non può avere attenuanti di sorta.
Un indagatore della modernità
Un asse interpretativo su cui è possibile ripercorrere e raccordare le tante diramazioni dell’opera di Calvino è il suo essere sempre stato un inaccontentabile indagatore della modernità. In Calvino, più che in altri scrittori e intellettuali italiani, si è potuta cogliere la consapevolezza dell’obsolescenza di un’immagine della realtà non più rispondente ai cambiamenti di un secolo, il Novecento, che l’avevano profondamente sfigurata o, comunque, trasformata. La sintonia tra la direzione intrapresa da Calvino e i sentieri battuti da una componente rilevante del mondo culturale italiano – i teorici, ad esempio, del pensiero debole – per quanto non esplicitamente dichiarata, è più di una suggestione interpretativa. Nella lezione americana in cui Calvino parla di molteplicità viene, non a caso, capovolto e diversamente letto uno dei capisaldi della modernità: l’idea di totalità, pietra miliare di una lunga tradizione metafisica che inizierà a venire messa in discussione solo a partire da Kant e Nietzsche, e, quindi, in tempi piuttosto recenti. «Oggi – leggiamo in una delle pagine finali delle Lezioni americane – non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, congetturale, plurima»[1]. Sembrerebbe una professione di fede da sostenitore del postmoderno, ma, conoscendo Calvino e la riluttanza ad assecondare facili adesioni a tendenze e movimenti, la “lezione” che propone non vuole essere così prevedibilmente e rigidamente istruttiva.
Le città possibili
Il centenario della nascita sarà l’ennesima occasione per ricordare la creatività estremamente feconda di questo scrittore, spesso citato nelle tracce degli esami di Stato, eppure raramente incrociato nei programmi scolastici, se non nelle antologie che ne selezionano alcune pagine per così dire memorabili, come se fosse davvero facile scegliere tra uno scritto e l’altro o come se, giusto per fare un esempio, il Visconte dimezzato fosse solo un romanzo per l’infanzia. La pluralità e varietà di letture che l’opera di Calvino esige verrà necessariamente ribadita in occasione del centenario. Critici e specialisti non mancheranno di prendere nota dell’inappuntabile, e tra i tanti libri di cui verremo invitati a riscoprire il fascino ci saranno Le città invisibili. Libro conteso tra filosofi, critici e architetti, Le città invisibili sono un geniale pretesto per interrogarsi sul senso del nostro modo di abitare il pianeta, dove ormai più della metà della popolazione vive nelle città. Già nelle prime tappe del suo lungo viaggio, Marco Polo, protagonista del romanzo, deve constatare che «Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda»[2]. Se Nietzsche, Hermann Hesse e Georg Simmel si sono sempre sentiti attratti dalla dimensione monumentale e architettonica della città, Calvino rivendica ora una diversa forma di attenzione, perché convinto che il genius loci sia il responso di una mediazione tra lo spazio e chi lo scopre e abita. «Oggi più che mai le città calviniane sembrano offrire un’apertura utopistica nei confronti di stereotipati modernismi, un possibile progetto urbano per metropoli stagnanti. Il concetto della città ‘invisibile’ ha conquistato piena cittadinanza nei manuali e corsi di architettura, come pure in libri che riflettono sul futuro delle nostre società e città»[3].
Calvino e l’Agenda 2030
La città di Calvino non è ovviamente uno spazio dispensatore di servizi, come bellamente si potrebbe credere, ma un luogo che induce all’interrogazione e che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe dare senso al nostro inquieto domandare. Città con un’impronta comunitaria, un’identità, dunque, e non concentrazioni di anonimi agglomerati. Oggi vengono chiamate in mille modi (cité éducative, come già recitava nel 1972 un documento dell’Unesco, happy cities, learning cities, comunità di prossimità, smart cities), ma l’idea che le ispira è comune e si basa sul principio della sostenibilità e di una rigenerata cittadinanza[4]. A chiedere che si vada urgentemente verso questa direzione è anche l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030. Accoglierlo e farlo proprio significa ripensare o rialimentare la città-utopia e contrastare, non solo negli effetti più appariscenti, i processi di urbanizzazione ancora dominanti. Tutto questo grazie anche a una delle tante lezioni di Italo Calvino.
[1] Italo Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, Milano 1988, p. 113.
[2] I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, p. 50.
[3] Elio Baldi, Citare Calvino. Le città invisibili e gli architetti, “Doppiozero”, in https://www.doppiozero.com/citare-calvino-le-citta-invisibili-e-gli-architetti.
[4] Nel 1972 una Commissione Unesco introdusse il concetto di “cité éducative” nel rapporto The world of education today and tomorrow.