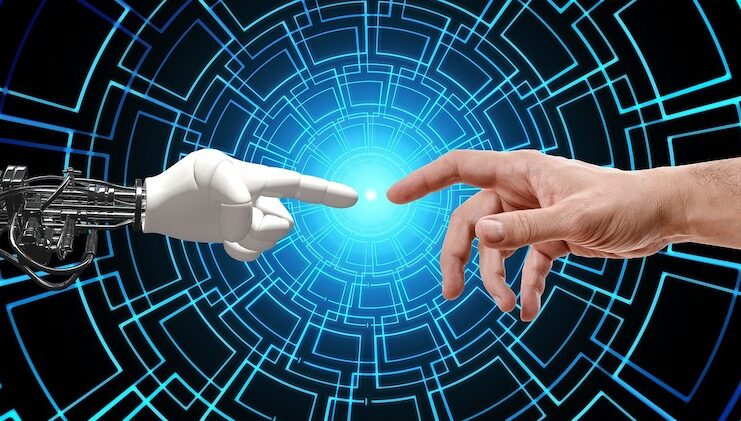Dalle urne elettorali alle urne funerarie in Libia il passo è breve. Sfumano le speranze di una transizione democratica indolore. A decretare ufficialmente il rinvio delle elezioni nazionali previste per il 24 dicembre, è stata l’Alta commissione elettorale libica. L’ordine di sciogliere i comitati elettorali e interrompere la preparazione del voto arriva dal capo dell’organismo di vigilanza, Imad al Sayeh. Tutto da rifare: spetta ora alla Camera dei Rappresentanti di Tobruk fissare un’altra data in calendario per l’anno venturo. Ma in pochi, oggi, scommettono sulla buona riuscita di un’operazione che fin dall’inizio ha sollevato dubbi e scetticismo.
Le incognite del voto
Nel voto oramai sfumato erano state riposte le aspettative della comunità internazionale. Era il 19 novembre del 2020 quando il comunicato finale del Libyan Political Dialogue Forum – kermesse che ha riunito a Tunisi settantacinque personalità libiche sotto l’egida dell’Onu – cerchiava in rosso la data del 24 dicembre 2021 per eleggere un nuovo presidente e rinnovare il Parlamento. La road map che doveva portare il Paese alle urne però è rimasta per gran parte inattuata. A febbraio, durante la riunione dei 75 delegati libici al Forum dell’Onu a Ginevra, la nomina dell’imprenditore Abdul Hamid Dbeibah come Primo ministro del governo transitorio e quella del politico di Tobruk Mohammad Younes Menfi alla guida del Consiglio presidenziale. Poi, a marzo, il via libera del Parlamento di Tobruk alla squadra del governo unitario.
La difficile strada verso le elezioni
Presupposti troppo deboli per garantire una strada sicura all’apertura delle urne, in un Paese ancora oggi sospeso tra una guerra per procura tra nazioni straniere e uno scontro tribale tra fazioni locali. Tre candidature di peso e controverse hanno agitato le acque. Quella di Dbeibah, che prima ha promesso di non correre e poi ha cambiato idea, ingaggiando e vincendo una battaglia legale per far registrare dalla Commissione la sua candidatura. Quella di Khalifa Haftar, il maresciallo della Cirenaica che nel 2019 ha tentato di prendere con il suo esercito la capitale Tripoli e poi, fallita l’esperienza militare, ha iniziato una burrascosa carriera politica. Infine, un nome noto: Saif Gheddafi, figlio del dittatore Muammar. Condannato a morte nel 2015, è tornato in campo dopo un’amnistia e, al termine di una serie di ricorsi, è riuscito a far accettare la sua candidatura. Ma il destino delle elezioni non è stato segnato solo dai cavilli legali. Per dirla con Richard Norland, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, nel Paese nordafricano sta emergendo «chi preferisce la forza delle pallottole alla forza delle urne». Nelle ultime settimane la situazione è precipitata. Da una parte il caos dei preparativi, con più di cento candidature annunciate e un fuoco incrociato di accuse tra fazioni. Dall’altra, una tensione che più volte ha sfiorato lo scontro militare. Come quando nella notte del 16 dicembre, milizie armate hanno circondato i palazzi delle Istituzioni e l’ufficio del primo ministro Dbeibah. Non un tentato golpe, ma una protesta della “Brigata Al-Samoud” contro la decisione di Al Menfi di sostituire il comandante supremo dell’esercito libico, Abdul Basit Marwan.
Giubbe e fucili
Qualunque disegno di stabilizzazione della Libia deve prima fare i conti con la realtà sul campo. E la realtà racconta che la Libia oggi è ancora terreno conteso da mercenari e unità militari legate più o meno ufficialmente a Stati stranieri. Ci sono i mercenari siriani inviati a migliaia dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan a difesa dell’ex governo tripolino di Fayez al-Serraj con la promessa di una lauta paga e della cittadinanza. A questi si aggiungono i mercenari sudanesi legati agli Emirati Arabi Uniti. C’è soprattutto il gruppo Wagner, la milizia di soldati russi intervenuta a sostegno di Haftar che fa capo all’oligarca Yevgeny Prighozin, soprannominato lo “Chef” di Vladimir Putin per la sua vicinanza al presidente russo.
Disattesi gli appelli della comunità internazionale
Inutili gli appelli lanciati dalla comunità internazionale negli ultimi mesi. A partire dalla clausola, contenuta nell’accordo per il “cessate-il-fuoco” dell’ottobre del 2020 e rimasta sulla carta, che prevedeva il ritiro entro novanta giorni di tutte le forze straniere: un contingente stimato allora dall’Onu nel numero di “almeno ventimila unità”. La strada per la liberazione del Paese dalle forze straniere è ancora in salita. A inizio dicembre, il Comitato militare libico congiunto 5+5, organo composto da cinque ufficiali del governo di Tripoli e altrettanti delle autorità di Bengasi, ha avuto una serie di incontri con il governo turco insieme all’Unsimil (la missione Onu di sostegno alla Libia) per tracciare un piano d’azione per il ritiro. Lo stesso comitato si è recato l’8 dicembre a Mosca, ricevuto dal viceministro degli Esteri Mikhail Leonidovich Bogdanov, per chiedere alla Russia di smobilitare i mercenari della Wagner. Una richiesta non facile da esaudire, perché il governo russo nega l’esistenza di legami ufficiali con la milizia e di conseguenza il diretto coinvolgimento nella crisi libica.
Leggi anche
Che cosa succede ora?
Dietro le quinte dell’escalation che ha sabotato il voto si muove un faticoso e incerto negoziato politico. Nella mattina di martedì 21 dicembre una delegazione di leader dell’Ovest è partita alla volta di Bengasi per intavolare una trattativa con i leader dell’Est e i deputati della Camera a Tobruk. Tra le fila dei negoziatori partiti da Tripoli ci sono l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashaga e l’ex vicepresidente del Consiglio presidenziale Ahmed Maitig. Quest’ultimo ha in agenda un incontro con Haftar: con il maresciallo della Cirenaica l’ex numero due del governo onusiano ha confidenza e in passato vi ha già trattato con successo, ad esempio, sulla gestione della produzione petrolifera.
Addio alle urne: una nuova corsa alle armi delle milizie
Sullo sfondo aleggia l’ombra di una nuova corsa alle armi delle milizie. A smentire “il ritorno alla normalità” annunciato da Dbeibah le testimonianze di movimenti militari a Tripoli. Secondo Agenzia Nova, a poche ore dall’annuncio della Commissione elettorale sul voto, alcune strade della periferia meridionale della città sono state chiuse da milizie locali. Più preoccupante il rischio, tutt’altro che remoto, di un altro, imminente vuoto governativo. Dopotutto, lo stesso Dbeibah è oggi un premier “sospeso” da quando si è candidato alle elezioni. Un ruolo importante spetta ora al presidente del Parlamento Agila Saleh: dovrà decidere il rinvio del voto presidenziale, previsto fra tre e sei mesi, cui seguirà cinquanta giorni dopo il voto per il rinnovo del Parlamento. Lo farà a stretto contatto con Stephanie Williams, inviata speciale dell’Onu e profonda conoscitrice delle dinamiche libiche. A lei il compito di fare l’impossibile per salvare il processo elettorale: un altro fallimento, ha detto l’esperta Federica Saini Fasanotti, getterebbe la Libia «in una condizione ancora più disperata, dalla quale sarà estremamente difficile riprendersi».
Che cosa cambia per l’Italia?
Per l’Italia il rinvio del voto libico rappresenta una delusione e apre al contempo scenari poco rassicuranti. Nonostante il protagonismo diplomatico e nonostante la presenza boots on the ground di Russia e Turchia abbia sostanzialmente reso marginale l’influenza di Italia e Francia sui processi politici libici, la posta in gioco rimane alta. Il governo guidato da Mario Draghi ha fatto sua fin dagli esordi la road map per le urne. Una strada ribadita dal premier italiano all’indomani del rinvio: «È importante che ci siano quanto prima elezioni libere, credibili e inclusive che possano unire il Paese e portare a una pace duratura». Tradotto: l’Italia è a favore del voto, purché rispetti precise condizioni. Su tutte l’inclusività: un’elezione delegittimata potrebbe sortire l’effetto indesiderato di una maggiore instabilità del Paese. Anche per questo, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha accolto con favore l’accettazione delle candidature di Gheddafi, Dbeibah e Haftar. Tutto rinviato al 2022, forse. Per Draghi, che ha dedicato a Tripoli la sua prima visita all’estero da capo del governo, il tracollo del processo elettorale è un monito preoccupante. Smentisce infatti gli auspici dell’ultima, ennesima conferenza sulla Libia, tenuta a Parigi a novembre scorso, con il sostegno decisivo di Palazzo Chigi e già delegittimata dall’assenza ai tavoli di Russia e Turchia.
Tra flussi migratori e interessi economici
Più di tutto la fase di incertezza che si apre rischia di avere un impatto immediato su due dossier prioritari per il governo italiano. Da un lato l’immigrazione, una vera emergenza: secondo l’OIM sono 1.508 i migranti morti nel 2021 lungo la tratta tra Libia e Italia. Un flusso che nel caos istituzionale libico sarà più difficile da gestire, tra milizie in subbuglio e l’incognita elezioni che rischia di rendere vano qualsiasi accordo preventivo. Dall’altro lato, gli interessi economici: preoccupa l’annuncio da parte delle Guardie delle strutture petrolifere (Pfg) della chiusura di tre impianti di estrazione. Tra questi c’è anche Wafa, l’impianto gestito dall’Eni che trasporta in Italia il gas libico attraverso i 520 chilometri del gasdotto Green Stream.